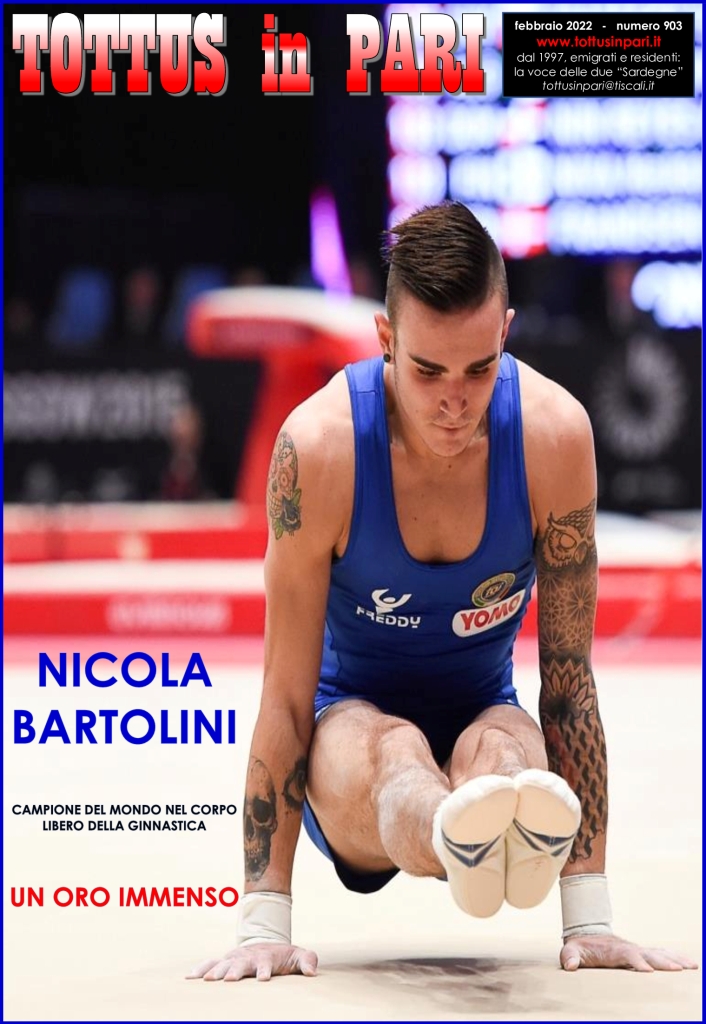di LUISA CARRACOI
«Le voyageur curieux des moeurs, de la misère et des passions de l’enfance des sociétés, pourrait tenter une excurcion au sein de l’Ogliastra, province montueuse, bordeé par la mer et qui doit son nom à ses bois d’oliviers sauvages».
Così inizia la bellissima descrizione dell’Ogliastra scritta dal Valery, pseudonimo di Antoine-Claude Pasquin, bibliotecario del re nel palazzo di Versailles e di Trianon, prima sotto il regno di Carlo X di Borbone (1824-30), poi sotto quello di Luigi Filippo di Borbone Orléans (1843-48).
La relazione sull’Ogliastra fa parte del suo “Viaggio in Sardegna”, che occupa il secondo volume di un progetto più corposo, dal titolo “Voyages en Corse, à l’île d’Elbe et en Sardaigne“.
L’Ottocento fu il secolo della riscoperta dell’isola sotto una luce diversa rispetto allo stereotipo come luogo di punizione e prigionia che la incatenava unicamente a visioni ostili e oscure.
Lo scrigno del suo immenso tesoro naturalistico e culturale, sconosciuto in gran parte agli stessi sardi, fu rivelato da viaggiatori, diplomatici, cartografi e scrittori stranieri che l’attraversarono per i sentieri più impervi, spinti dal desiderio di conoscere le diverse realtà di una terra “unica”, colpiti dal fascino dell’arcaicità e della primordialità dell’isola, tanto che Vuillier la definì Ile oubliée.
Il Romanticismo, che succedeva ai Lumi, aveva fatto sorgere negli animi una sensibilità nuova verso i luoghi per molti aspetti ancora sconosciuti. Mentre altri illustri viaggiatori dell’epoca percorrevano altre regioni e in particolare le città italiane, come Roma, Firenze Venezia e Napoli, Valery instancabile curioso e appassionato studioso, scelse sentieri meno battuti e ignorati fino ad allora dal Grand Tour. Giunse nell’isola alla fine di aprile del 1834, quando la Natura offre il massimo nella magnificenza dei suoi colori e, vi si trattenne per circa un mese e mezzo. La percorse in lungo e in largo e la descrisse in oltre ottanta tappe, ispirato da quei sentimenti d’origine romantica che traspaiono non solo dalla percezione dei paesaggi che gli offrirono lo spunto per profonde meditazioni, ma anche dal suo entusiasmo verso le manifestazioni culturali che legavano l’uomo alle sue origini ancestrali. La Sardegna aveva le caratteristiche di un mondo “fuori dal tempo”, ed era questa la preziosità che Valery voleva condividere con i suoi lettori.
Dell’Ogliastra descrisse in particolare due villaggi: Arzana e Baunei. Il borgo di Arzana, di appena cinquecento abitanti, era conosciuto per i suoi formaggi, ritenuti i migliori dell’isola, grazie sia alla cura prestata nelle varie fasi della loro produzione, sia all’eccellenza dei pascoli.

Il viaggiatore non dimenticò di mettere in rilievo che «L’air de ce bourg est salubre», come lo stesso toponimo attesta.
In questo villaggio, conobbe una bella signora anziana di centotre anni, che attendeva ogni mattina ai suoi esercizi di pietà, governava la casa e filava molto bene la lana e il lino. Alla caparbietà dei suoi anni sommava la gioia di avere ottantatre nipoti.
Questo è meraviglioso, visto che ancora oggi Arzana insieme a tutta l’Ogliastra continua ad essere terra di ultracentenari!
La curiosità condusse poi l’appassionato studioso a visitare il piccolo borgo di Baunei, arroccato sul costone calcareo di Monte Santo, località oggi rinomata come meta turistica internazionale per le paradisiache cale incastonate tra le acque turchesi, le falesie più imponenti d’Europa, i sentieri e gli scenari mozzafiato. Il villaggio si mostrò agli occhi stupefatti del viaggiatore come un luogo «resté à peu près au mème point qu’à son origine».
L’esploratore ribadì l’elogio pronunciato anche da Padre Francesco Cetti, professore dell’Università di Sassari, sul candore, la sincerità e l’amore per il lavoro degli abitanti di Baunei; uomini e donne ai quali la parola non era stata donata per mascherare i pensieri e, le cui sole forme di affermazione e di negazione utilizzate erano «le oui et le non». La semplicità dei loro alimenti sembrava legare i baunesi all’età delle origini perché essi vivevano di pane di ghiande per gran parte dell’anno.
Valery ne riportò anche la ricetta «Ce pain primitif se prépare ainsi: le gland après avoir été épluché, est mis sur le feu dans une marmite avec de l’eau filtrée à travers une certaine argile et des cendres de végétaux, sorte de lessive qui corrige quelque peu l’amertume du gland, et dont le gluten tiré de l’argile sert de liaison. Lorsque le tout a été bien remué et dissout et que cette bouillie a obtenu la couleur chocolat qui indique le degré de cuisson, on la laisse se figer, et elle este mise à sécher au soleil. On coupe alors cette pâte en petits pains ou par tranches qui se mangent avec du fromage, du lard, de la viande».
Il pane di ghiande, oltre che necessario, era probabilmente arricchito anche di un valore sacrale fin da tempo immemorabile.
Le ghiande venivano raccolte nel primo inverno esclusivamente da boschi di leccio e roverella ed unicamente in luoghi particolari che offrivano dei frutti dolci.
Dopo la raccolta venivano messe ad essiccare accanto al camino per una durata di circa venti giorni; essiccate e poste all’interno di un sacco di lana di capra, infine private del tegumento esterno tramite battitura su pietra.
Così come le ghiande, anche l’argilla veniva prelevata solo da determinate località. Una volta colata, depurata e versata in una grande tinozza di terracotta contenente acqua fredda, si mescolavano i due ingredienti fino ad ottenere una miscela rossiccia.

Questo procedimento che aveva lo scopo di arricchire l’acqua dei minerali rilasciati dall’argilla e ottenere così un pane nutriente, non ci deve stupire, visto che la geofagia possiede lontane arcaiche radici. L’acqua veniva versata dentro un paiolo di rame, su caddargiu, e portata ad ebollizione. Alla miscela rossa venivano unite quindi le ghiande prive di tegumento. Aveva così inizio la cottura, che durava circa sei ore e che aveva lo scopo di eliminare parzialmente il sapore amaro. L’argilla serviva a sottrarre ulteriormente vigore ai tannini e legava l’impasto. Alla poltiglia rossa bollente si aggiungeva lentamente la cenere setacciata di vite o roverella e si mescolava. Quando l’impasto era ben denso, veniva diviso in tanti panetti e lasciati asciugare al sole.
Si ottenevano due prodotti, uno più rustico destinato agli uomini come sostentamento nei lavori in campagna, un altro più raffinato, chiamato su lande ‘e fitta, destinato agli anziani, ai bambini e agli ammalati. Una volta pronti si gustavano insieme a del formaggio, del lardo o della carne.
L’impiego delle ghiande e dell’argilla per fare il pane costituirono importanti sostituti del grano in tempi di carestie e di guerra, tanto che il proverbio sardo ricorda «a su famini, peri su landi parit castangia». Ma, questo pane era certamente rinomato, visto che come ci è testimoniato da Valery nel suo resoconto di viaggio, esso aveva un prezzo superiore a quello d’avena locale e le donne lo andavano a vendere a Tortolì, capitale d’Ogliastra.
La quercia, connubio di forza terrena e divina, simbolo di forza interiore, conoscenza e saggezza, è parte integrante della nostra storia, così come questo pane prodotto con i suoi frutti, certamente un prodotto di nicchia da preservare e valorizzare.