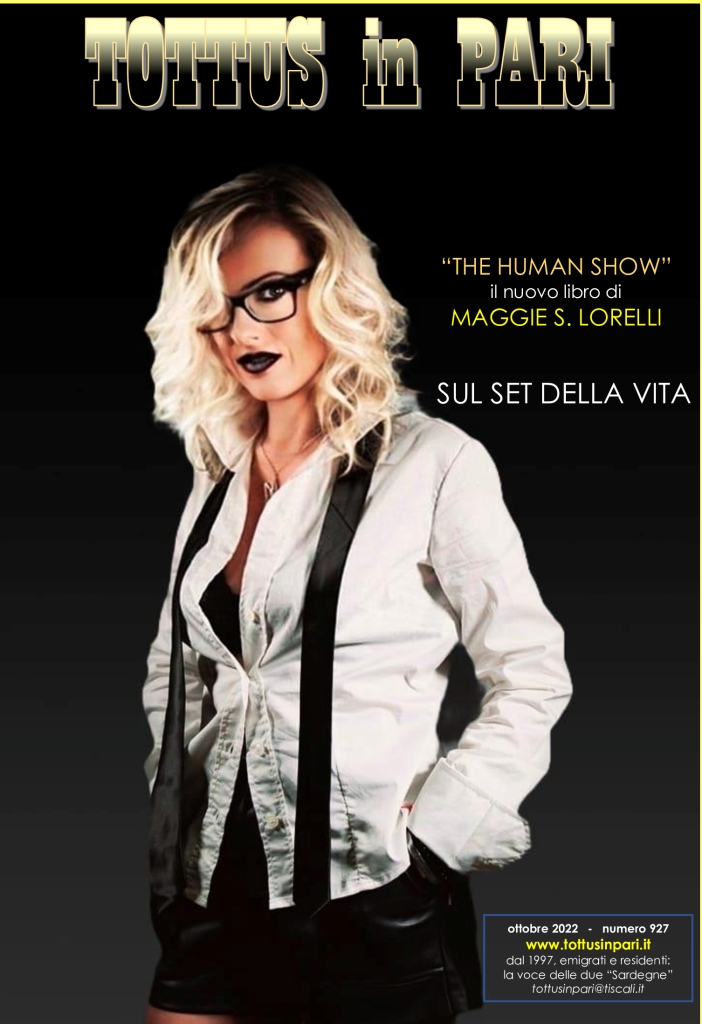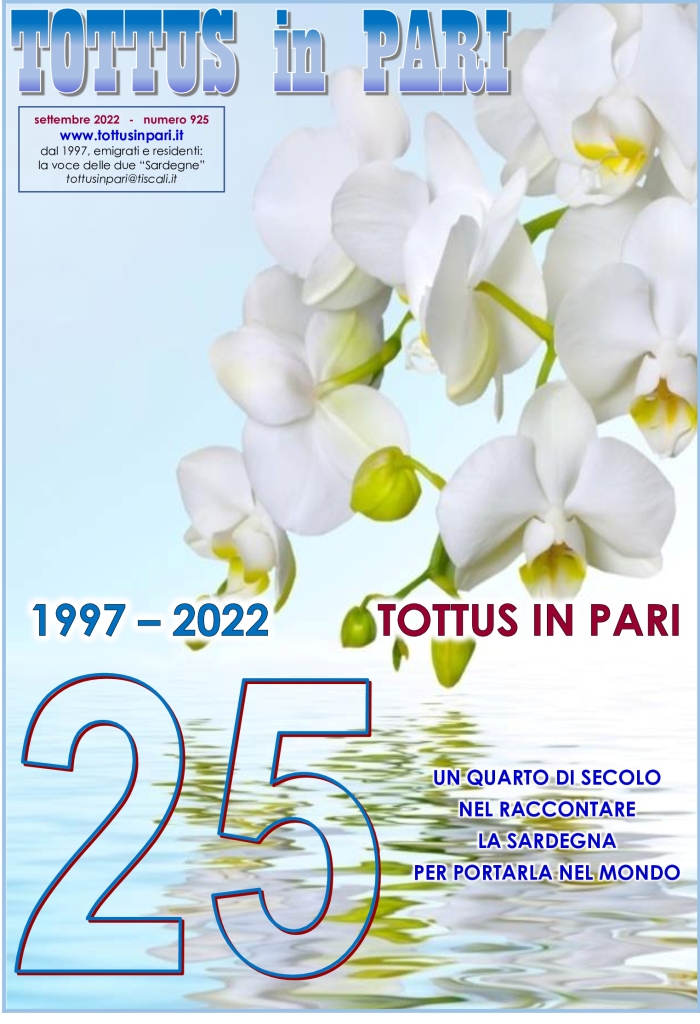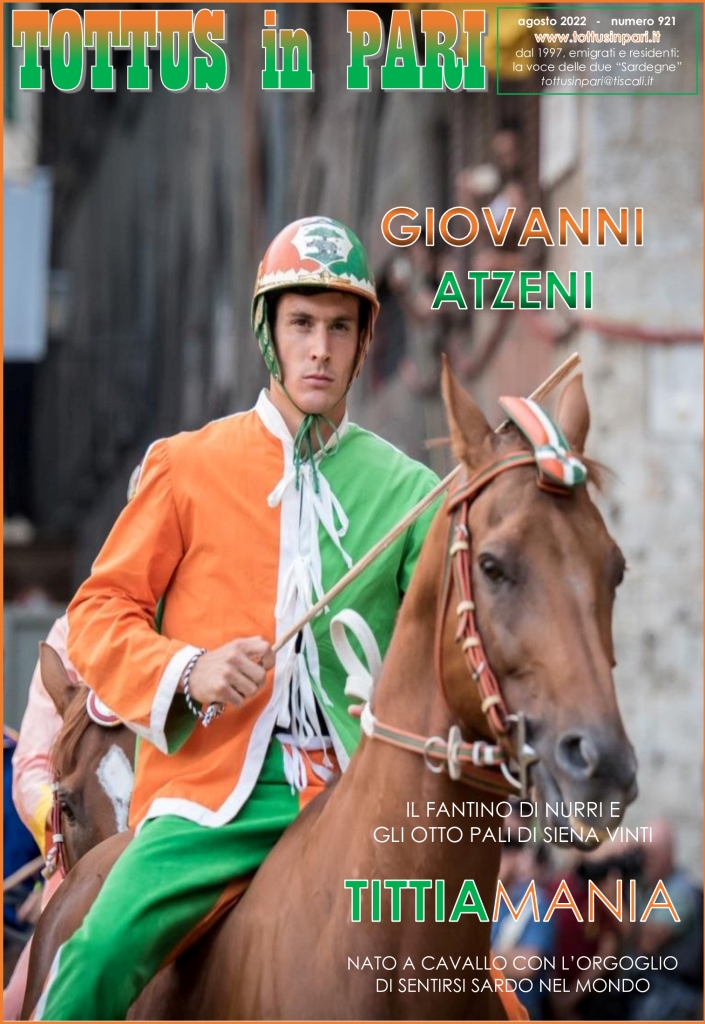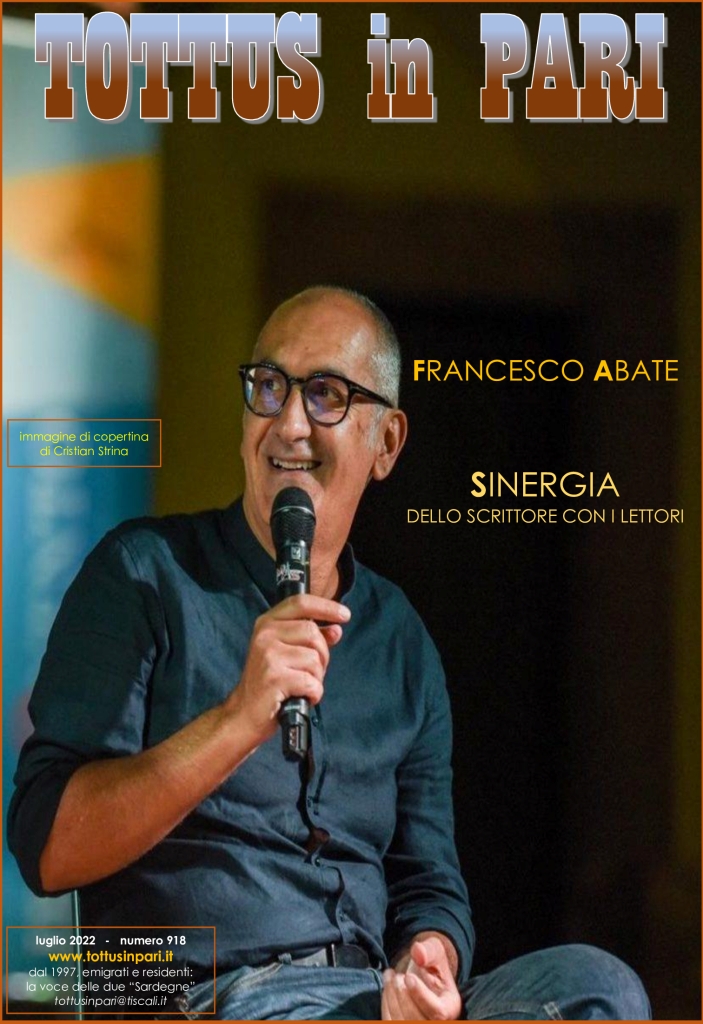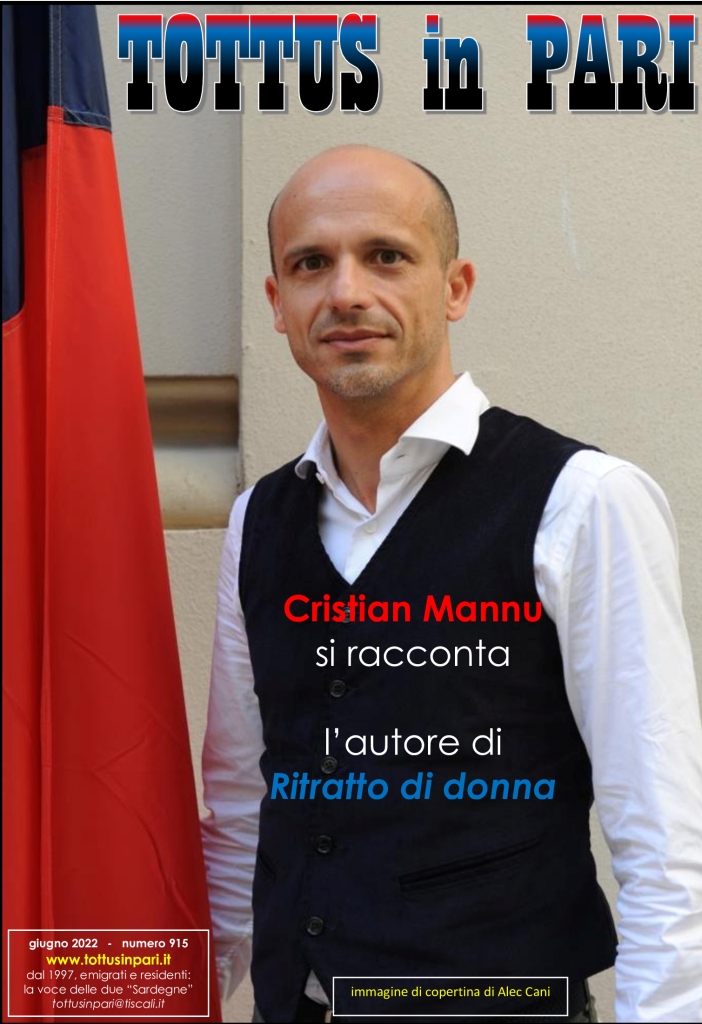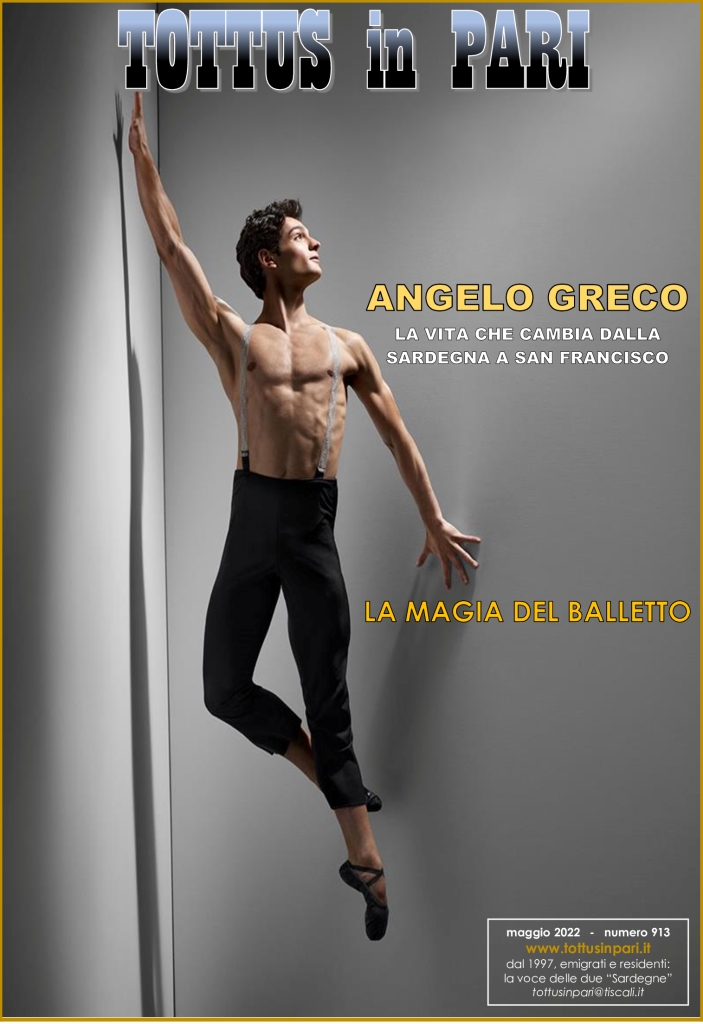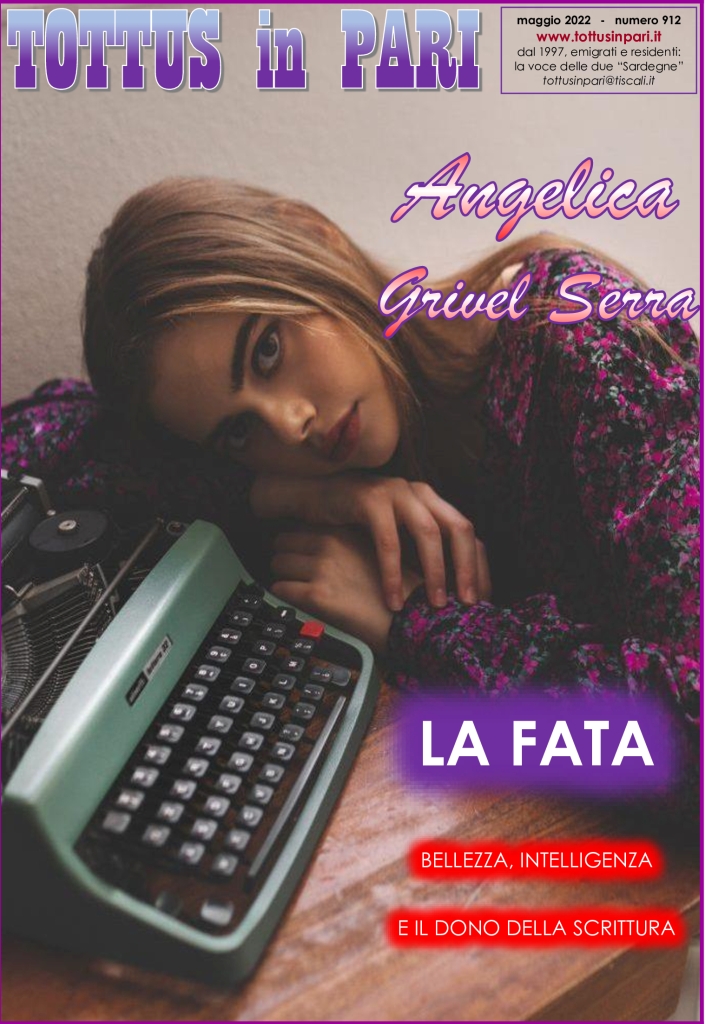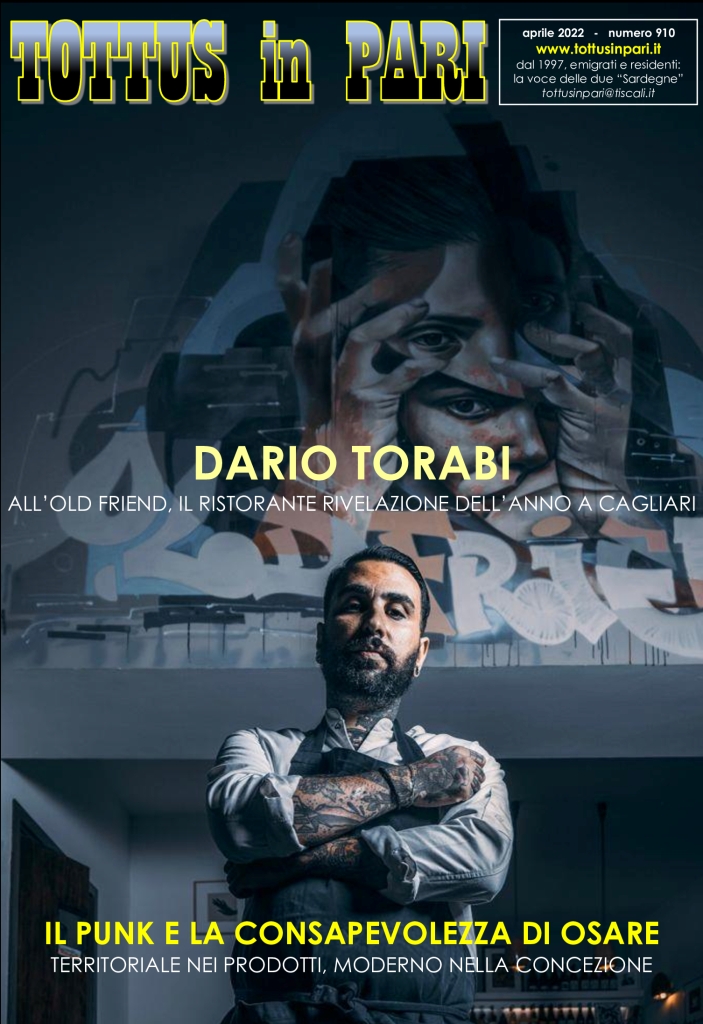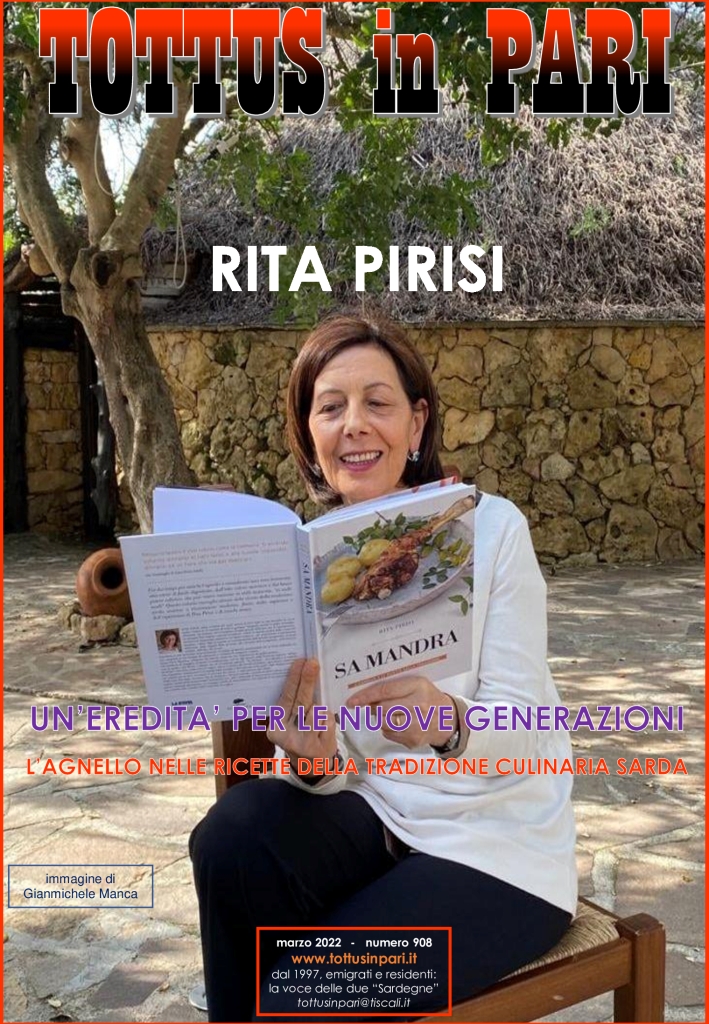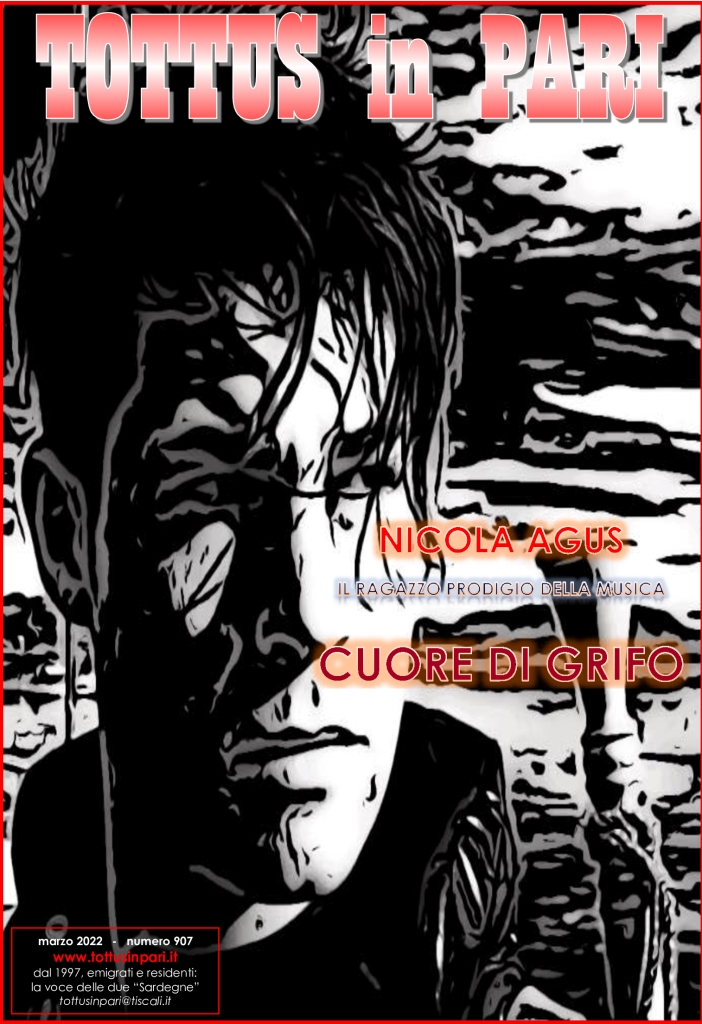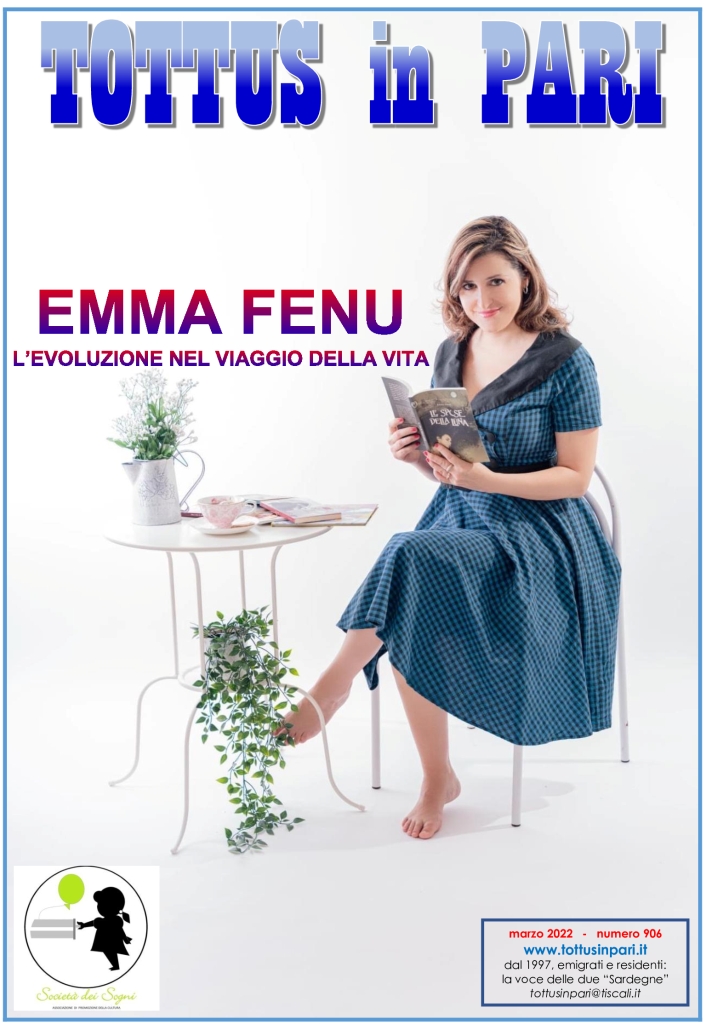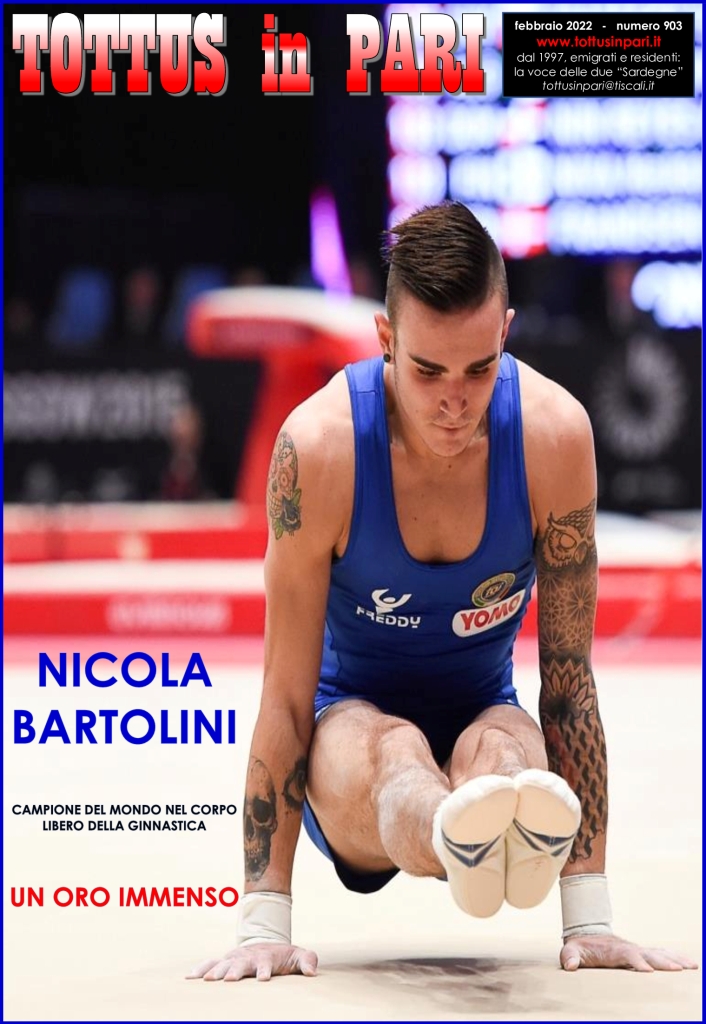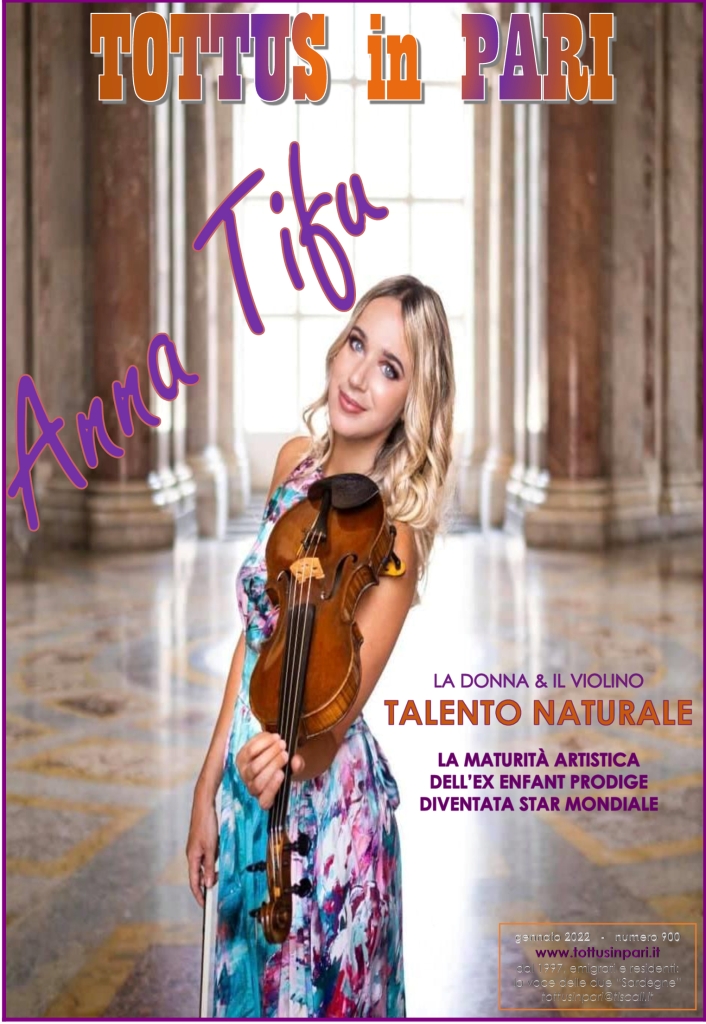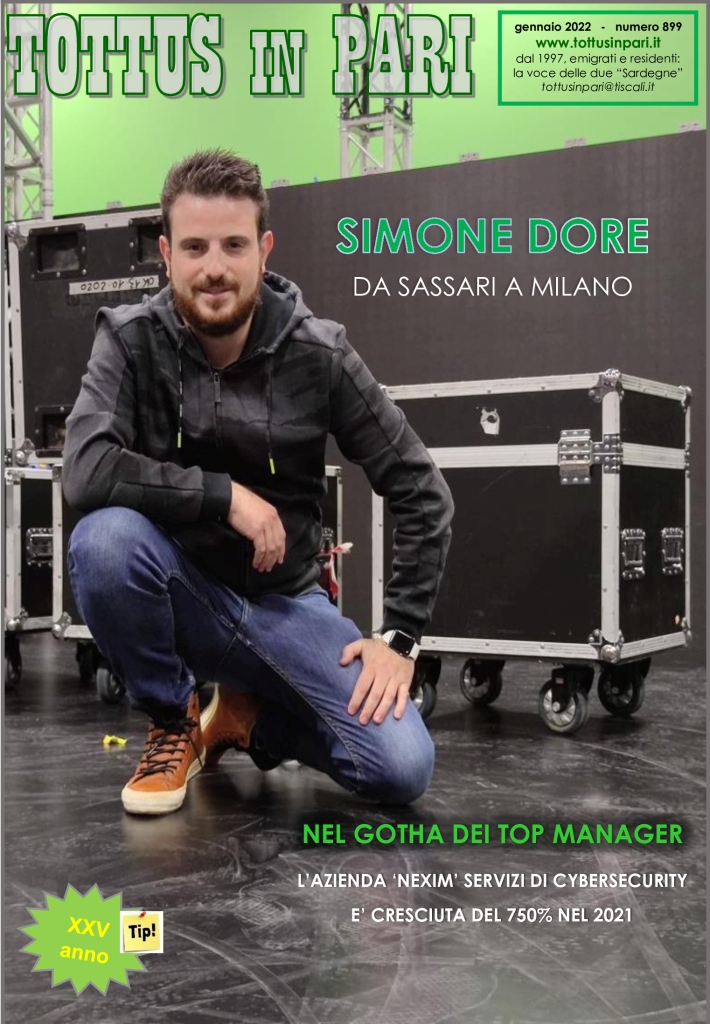Le tradizioni del periodo di Pasqua nel Campidano di Oristano sono in parte ancora vive, ma sono cambiate nel tempo. Ad esempio la Via Crucis, il ricordo della via della croce, si faceva come ora, per le vie del paese, ma le croci che indicavano le stazioni erano fisse sui muri delle case. Croci nere, senza il crocifisso. La processione del venerdì santo percorreva le strade e davanti a tutti camminava il Cireneo, un confratello anonimo con un cappuccio che gli copriva il volto, a piedi nudi. Era un volontario che lo faceva per voto. Un’altra tradizione era la benedizione dei mazzetti di fiori: le catechiste guidavano le ragazze a cogliere i fiori della primavera: violacciocche, fresie, roselline, gerani, ciò che trovavano; soprattutto foglie odorose, come la menta. Durante la funzione in Coena Domini il parroco lavava i piedi ai confratelli con le foglie morbide dei finocchi selvatici: tuffava il mazzetto nell’acqua, bagnava i piedi dei confratelli e li asciugava con un asciugatoio. Poi benediceva i mazzetti di fiori, che venivano distribuiti insieme alle palme benedette. Le palme grandi si mettevano al capo del letto, le piccole dietro la porta di ingresso e possibilmente anche dietro la porta del cortile, che immetteva alla casa. Si facevano le pulizie di Pasqua e si ornava la casa al meglio che si potesse. Doveva essere bella e gioiosa perché passava il prete a benedirla. Si mettevano le coperte più belle sul letto, le migliori tovaglie e su coberi bancu, manufatto tessile che copriva le cassapanche. Arrivava il prete con i chierichetti, che portavano il secchiello, l’aspersorio e anche unu scatteddu, un cestino di canne in cui si usava mettere i regali per il prete e per i ragazzi: uova fresche, arance e pardulas. Il dolce caratteristico, sa pardula, si faceva col formaggio fresco; chi non poteva farlo col formaggio fresco usava la ricotta. Il pane della Pasqua era su coccoi cun s’ou, il pane di semola con l’uovo. Un’arte vera e propria, tanto che si fa tuttora ma è considerato più un oggetto decorativo che un alimento. Quello piccolo, su coccoeddu, rappresentava un pulcino: il corpo era un uovo a cui si aggiungevano le alette, la testina, i piedini e la coda di pasta di pane modellata e tagliata con le forbicine. Stava dritto come un soprammobile. Nella versione più grande de su coccoi c’era sempre l’uovo, nella parte centrale, fermato da striscette di pane. Molte volte era cosparso di zafferano. Il pane allora si faceva normalmente il venerdì, quindi quello che si mangiava a Pasqua era fatto il venerdì santo. Per la domenica delle palme, invece, le mamme davano ai bambini pani a forma di palmetta in modo che questi, durante la messa, stessero a rosicchiare le palmette di pane e non disturbassero la celebrazione. Allora si usava fare sa mandada, tradizione di un’economia quasi di sussistenza: era uno scambio di cibo, si mandava qualcosa agli amici, ai parenti. In periodo pasquale si mandavano is pardulas, in un piatto racchiuso in un tovagliolo. Quelli che le ricevevano, se avevano fatto anche loro is pardulas, ricambiavano. In genere si mandavano a quelli che erano in lutto, i quali non facevano dolci per Pasqua, a qualche anziano, a qualche malato o anche a famiglie di amici e a parenti. Era uno scambio. Un modo come un altro di aiutarsi gli uni con gli altri. Allora come adesso, le campane restavano mute dal giovedì santo fino alla domenica di Pasqua. Per segnalare le ore della funzione religiosa, il sagrestano usava una tavola di legno, grande come un tagliere, a cui erano fissati uno o più battenti di ferro con lo scopo di sbattere sul legno per produrre rumore: sa matracca. Dietro di lui, una moltitudine di ragazzini faceva chiasso con su stròcci arrana (letteralmente: imita rana), uno strumento sonoro fatto con le canne. Altri usavano is tabeddas: tre pezzi di legno legati fra loro da un fil di ferro, il pezzo centrale sporgeva per poterlo afferrare e col movimento del polso si facevano sbattere le tavolette l’una all’altra. La maggior parte delle persone non aveva orologio e senza questi strumenti non avrebbe saputo l’ora esatta. I ritmi della vita in una società agropastorale, come quella sarda di non molte decine di anni fa, erano ancora dettati dalle leggi astronomiche e dai fenomeni atmosferici. Ora il progresso ha migliorato molti aspetti della vita, ma nella società di oggi, a volte, si sente la mancanza dei rapporti umani. Confesso che mi piacerebbe, un giorno, andare sotto casa di amici, segnalare la mia presenza con uno stròcci arrana e aspettare che mi aprano la porta per scambiarci un piatto di pardulas fatte in casa.
* L’Arborense