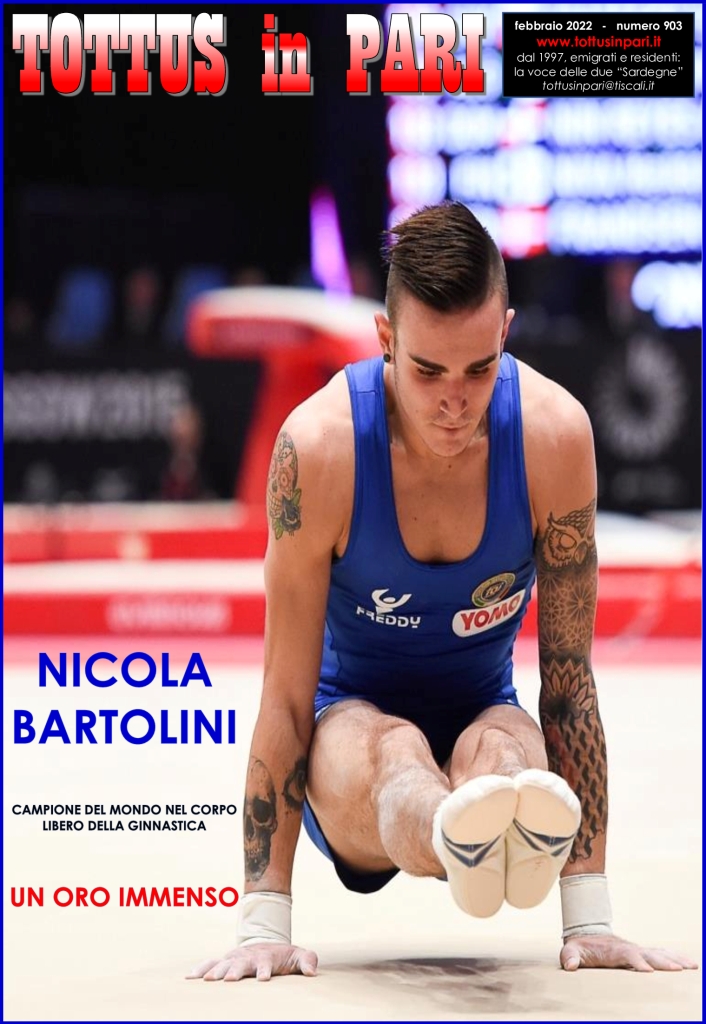di ANDREA CATERINI
Il segreto, mi ero sempre detto, sgranandolo a mente come un rosario, o come quell’allarme che suona ogni volta si rischia di cadere nel tranello di una ipocrisia da cui mai si è davvero immuni, era non cedere al folclore. Il dubbio era sempre lo stesso. Quello che ci veniva proposto di raccontare televisivamente dai nostri contatti sul territorio, quanto rispondeva al costume reale, o ancora meglio, quanto era davvero radicato alla vita stessa delle persone, e quanto invece era lo show che lo stesso territorio era disposto a offrirti per attrarti nella sua rete, a conti fatti per nascondere ciò che era realmente, spettacolarizzando una vita che non esisteva più, che potenziava, ridicolizzandolo, il proprio passato, trasformandolo in un’operazione di marketing? Tutti quei canti e balli e feste e falò popolari, tutte quelle leggende e mitologie e liturgie cosa avevano a che fare con il carattere di chi quei luoghi viveva? Con chi quei luoghi abitava quotidianamente? Con chi dalla sua terra non si era mai neppure allontanato? Mi continuavo a domandare, insomma, se quelle leggende, quegli spettacoli, quelle riproduzioni di una ritualità condivisa fossero ancora la visione di una vita fondata sul mito e sul sacro o non fossero invece, del mito, la sua degradata imitazione, dove di sacro non restava nemmeno la preghiera bisbigliata, neppure il silenzio degli spazi consacrati al cerimoniale.
Quando, prima di prendere un volo per Olbia, mi avevano proposto una festa ancestrale nella Valle di Lanaittu, in quella foresta dentro il territorio di Oliena, con fisarmoniche e pastori appositamente ingaggiati che cucinavano su un fuoco all’aperto il porceddu, facendogli sciogliere sopra, mentre il maiale da latte girava su se stesso sopra la brace, un trancio di lardo, avevo pensato che anche i barbaricini, con la loro centenaria riluttanza, col loro orgoglio coatto di isolani, avevano trovato un compromesso tra la diffidenza per chi veniva da fuori, e non dico solamente dei continentali ma pure di chi viveva sulle coste, e la necessità di sopravvivere a una contemporaneità che li relegava a essere non solo isolati geograficamente, cosa di cui continuavano a essere orgogliosi, ma anche allontanati da una modernità di cui percepivano appena l’eco. Nonostante l’isola che li aveva fatti nascere nei decenni avesse arricchito le sue attività commerciali e ravvivato gli uffici del turismo, continuava a resistere, negli abitanti dell’entroterra, un riottoso rifiuto dello straniero, colpevole di sfruttare la loro terra, di oltraggiarla senza capirla, tanto che ciò che l’estraneo più agognava, e di cui capitalisticamente si era appropriato, era la parte a cui loro tenevano meno, quella che consideravano, se non proprio un pericolo, quanto meno un’inezia. I sardi diffidavano dei turisti e più in generale dei forestieri perché sapevano di non poterne fare a meno.
Dal mare, il profilo nord orientale della Sardegna, per tutto il Golfo di Orosei, sembrava un muro di cinta impenetrabile. Le alte falesie di roccia calcarea si presentavano come le pareti di una fortezza da cui ci si poteva difendere. Avvicinandosi alle spiagge, sulla cima facevano da vedetta le capre al pascolo. Lo specchio turchese dell’acqua, e il candido colore dell’arenile, erano un inganno. La vera Sardegna non era il paradisiaco miraggio delle sue coste, ma ciò che dietro di esse si custodiva come il tesoro più prezioso.
In Sardegna il mare non esiste. Sì, è un ossimoro, ma non lontano dalla verità. Esiste certo per i continentali, come chiamano qui tutti gli estranei che raggiungono la regione dalle coste della penisola. Ma non esiste per i sardi, per cui il mare è sempre stato soltanto un pericolo: l’arrivo dell’invasore. I sardi sono uomini di montagna. Sono stati da sempre pastori e molto meno pescatori. Sono gente di terra, non d’acqua. Sono lo specchio del loro paesaggio meno conosciuto: chiusi e nascosti sotto le chiome di fitte foreste, abbarbicati alle loro tradizioni, inscalfibili come le pietre nuragiche che disegnano il loro paesaggio. Ciò che nei barbaricini era rimasto di atavico, lo si doveva alla loro posizione di isolamento all’interno della stessa isola. Una condizione imparagonabile a quella dei siciliani. La Sardegna è una nazione dentro la nazione, un minuscolo continente nel grande continente europeo. Non è di nessuno, non appartiene a nessuno fuori da chi la abita.

La Barbagia cominciava da qui, da queste montagne a precipizio sul mare, nel Supramonte di Dorgali, nella provincia di Nuoro. Il più grande scrittore sardo del Novecento, Salvatore Satta, ne Il giorno del giudizio, che avevo deciso di leggere per la seconda volta a distanza di anni tornando in questa terra da cui mi sentivo attratto e sempre straniero, diceva che ogni sardo guarda a Nuoro come alla sua seconda Patria. E tutto il nuorese è caratterizzato da questi altipiani rocciosi dove pascolano soprattutto capre. In Barbagia la cultura pastorale ha sempre vinto sulla cultura contadina. «La proprietà pastorale non ha nulla a che fare con la proprietà contadina. Questa, intanto, è raccolta in certe valli e in certe pianure, è divisa in tanti appezzamenti di terra, e non ce n’è uno che assomigli all’altro. Bisogna chiedere il permesso, quando si entra, anche per attraversarli. L’altra è dappertutto, e nessuna legge può impedire al pastore di considerare la sua proprietà in tutto quello che l’occhio può abbracciare».
Prima di conoscere Pantaleo, pastore ottantenne di Dorgali, Giuseppe, suo figlio, al telefono mi aveva avvertito, «Se ci dite che il servizio lo girerete alle dieci di mattina, non vi presentate tre ore dopo, mio padre non ve lo perdonerebbe». Quella minaccia mi aveva provocato una doppia reazione. Da una parte provavo tenerezza per quel figlio che si preoccupava ancora, a cinquant’anni, degli umori neri di suo padre, un padre che pure utilizzava per rendere più aggressivo l’ammonimento (non era lui che non ci avrebbe perdonato, ci aveva tenuto a sottolineare, lui che a quel servizio più teneva, ma il suo vecchio); dall’altra sentivo già addosso l’ansia di un problema da risolvere, perché il ritardo, durante le riprese, era la calamità da cui non si scampava nemmeno seguendo alla lettera tutti i buoni propositi dei piani di produzione compilati scientemente dalla scrivania della redazione. Capivo, insomma, che avrei dovuto trovare subito un metodo per non urtarlo, per fargli accettare la nostra indiscreta presenza, il nostro rumoroso sproloquio, la nostra irritante mancanza di rispetto.
Pantaleo mi aveva colpito subito per la stazza, due palmi più alto della media di tutti i sardi, più alto quindi anche di me, che a quella media ero affine. La calvizie permetteva alla forma della testa di adagiarsi su un naso curvo e aquilino, su una fronte corrucciata, su due labbra sottili come lame. A pensarci, credo che la prima sensazione che avevo avuto osservandolo era stata di timore, come percepissi che il compito che avevo non sarei stato mai in grado di assolverlo. Seduto a capotavola di un enorme tavolaccio di legno, ci aveva fatto trovare una grande quantità di formaggi, quelli che preparava con le sue mani da sessant’anni, e tre, quattro brocche in terracotta colme di un Cannonau che comprava da qualche produttore della zona a poco prezzo. Sentivo che era soprattutto di me che diffidava. Lo avevano informato di quale fosse il mio ruolo all’interno del programma. Non era la prima volta che mi scontravo con la resistenza di allevatori e contadini che guardavano con scetticismo al lavoro di concetto – così lo aveva chiamato una volta un contadino calabrese, facendomi reagire con sorpresa e autoironia –, come fossi né più né meno un imbroglione che aveva trovato un modo per aggirare il peso della fatica, un furbo a cui lavorare non era mai piaciuto. Ma a giudicarmi non era Pantaleo, ma i segni che aveva sul viso, le rughe che gli tagliavano la fronte, le sue mani tozze, le dita inguaribilmente gonfie. Mi sentivo piccolo, insignificante.
Tutto lo stress che lamentavamo per gli orari esagerati, la fretta delle ricerche, le pagine sfogliate di libri letti troppo velocemente per cercare qualche informazione e qualche citazione a effetto, scrivere copioni che avessero la parvenza di un senso, la pulizia maniacale dei tagli che compivamo al montaggio per evitare le insicurezze della vita, le rabbie represse contro operatori troppo sindacalizzati che pretendevano pause pranzo infinite, mentre dall’altra parte un libero professionista come me, con l’ansia della partita iva e le tasse da pagare a luglio guardando il conto corrente ogni due giorni per sapere se quel bonifico l’azienda l’aveva poi emesso, gli sembrava già tanto fermarsi per comprare un panino e mangiarlo in macchina spostandosi da un set all’altro. Ecco, tutto questo circo di miserie mi pareva assolutamente inutile, meschino di fronte a Pantaleo, che aveva passato la vita da solo, lontano dalla famiglia per mesi, durante il periodo delle transumanze, con la sola compagnia delle capre, affettando un pezzo di formaggio e spezzando il pane carasau per resistere al caldo e al freddo, alla testa che si riempie e si svuota in quelle ore di mutismo in cui i pensieri si accavallano, prendono una posizione scomoda, le certezze si spezzano.

E mi chiedevo cosa gli avesse insegnato quella solitudine, alla fine dei conti, con gli anni che si portava addosso, se tutta quella fatica, quel sacrificio erano davvero serviti a qualcosa, quale valore, quale significato avevano dato alla sua vita. Ora si prestava al nostro gioco di ciack e ripetizioni, di prova a esprimere meglio questo pensiero, non sovrapporre la tua voce a quella del conduttore, ruotati di qualche grado per essere a favore di camera, comincia a lavorare, spezza la cagliata nel pentolone bollente prima di iniziare a parlare, spegnete i telefonini, silenzio tutti: motore, azione! Cosa mai poteva importagliene a Pantaleo di mettersi davanti a una telecamera, fingere di vivere, degradando, a conti fatti, ciò di cui aveva vissuto per tutta la vita, sostenendo una famiglia che aveva dovuto tenere lontana per riuscire a sfamarla? Cosa era per Pantaleo la vanità se non l’orrore vacuo con cui si vanificava in un attimo solo tutto il passato, tutta la propria storia, la propria esistenza? Quella nostra invasione in un territorio tanto intimo e segreto, quella nostra oscena desacralizzazione della vita, in che modo lo interrogava, quale domande gli faceva porre?
La sera precedente, in albergo, ero sprofondato ne Il giorno del giudizio, cercando di decifrare quel mistero linguistico, quella sintassi che Satta aveva articolato come una seduta spiritica, o come rispettando le leggi di un’antica liturgia, quella in cui i morti chiedevano conto ai vivi della vita che era stata, quale senso avesse, se un senso avevano avuto i lunghi silenzi, i taciuti rancori, e i vivi domandavano a quelli che non c’erano più, che avevano gli occhi senza pupille, bianchi, vuoti come voragini di cui non si vedeva la fine, la ragione che li legava ancora alla loro memoria. «In questo remotissimo angolo del mondo, da tutti ignorato fuori che da me, sento che la pace dei morti non esiste, che i morti sono sciolti da tutti i problemi, meno che da uno solo, quello di essere stati vivi». La Sardegna, anzi la Barbagia, desolata di silenzi, dove per chilometri non si incontravano case, ristoranti, bar, neppure benzinai, era una terra priva di attese, dove niente ci si aspettava, e ciò che accadeva, accadeva come per un miracolo a cui nessuno si era appellato, di cui nessuno aveva fatto richiesta. Forse Pantaleo aveva davvero interpretato quella nostra intrusione come un miracolo, e che fosse di natura benigna o maligna non aveva alcuna importanza. Qualcosa era caduto dal cielo, o emerso dal fondo della terra per spezzare la monotonia della vita. Qualcosa che si poteva solamente accogliere, a cui non ci si poteva ribellare, come succede con le gioie improvvise, ma pure con la rabbia e la povertà, pure con la miseria.
«Versami un po’ di vino». Ero vicino a lui in quel lungo tavolaccio che tutta la troupe aveva assaltato spazzolando via in qualche minuto ogni bene offertoci. Non ero stato attento al contenuto delle brocche, perché avvolto da un coccio scuro. Avevo creduto che di recipiente uno valesse l’altro, che soltanto vino in fin dei conti poteva esserci donato. Solo che a un certo punto Pantaleo era scoppiato in una risata, e il viso assumeva tutta un’altra forma, si era disteso, la durezza dei tratti si scioglieva. Mi pareva di immaginarlo, dietro quel sorriso, quando era solo un ragazzino. Ridevo con lui, ma senza capire il motivo. «L’acqua non la bevo. Bevila tu».
Sono gli errori, alle volte, a concedere una deroga all’orgoglio, ad aprire una faglia, uno spiraglio sopra quella crosta dura che ci protegge dal mondo. L’errore, l’inciampo, la caduta, sono la misura della nostra sensibilità, o il momento in cui la sensibilità si manifesta disarmata. A Pantaleo era bastato poco, in fin dei conti, per lasciarmi passare lì dove sembrava impossibile. Ora lo guardavo e pensavo a mio nonno. E rivedevo lo sguardo che aveva, un poco perso dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ma ridente quando mi portava, io bambino, nell’osteria di quartiere, a me facendo bere una Coca Cola, e lui, al quinto sesto rosso, versato dentro quei bicchieri di vetro trasparente stretti, che si aprivano un po’ a cono, e che anche oggi ho voluto tenere a casa per tutto quello che mi ricordano, per il mondo in cui mi trasportano, mi prometteva che presto mi avrebbe regalato un pony da tenere nella sua campagna. Per un po’ avevo atteso la sorpresa, sognando di riuscire a cavalcarlo, poi ero stato io stesso a far cadere quel desiderio, quel sogno, quella promessa, e senza rimproveri o malinconia, come fosse bastata quell’inutile parola che mi aveva dato, dimenticata molto probabilmente dopo lo schiaffo della sbronza, ma che mi aveva acceso d’allegria. Panteleo era mio nonno.

Per troppo tempo ho creduto che il senso di appartenenza, le nostre radici, fosse qualcosa che si potesse riconoscere facilmente – la città che ti appartiene, le strade conosciute percorse migliaia di volte, il quartiere dove sei cresciuto, la casa in cui tornare, persino i monumenti che hai osservato così tante volte che oramai non vedi nemmeno più. Eppure, partendo quasi ogni settimana in giro per l’Italia, ci si accorge di appartenere a qualcosa di molto più grande e anche infinitamente più piccolo. Che le nostre radici sono anche in quel dialetto che non comprendi, in quel paese che calpesti per la prima volta, in quella strada di campagna che percorri in macchina dove per chilometri non incontri volto umano, in quelle provincie in cui ritrovi l’Italia contadina, orgogliosa e timida, silenziosa e pettegola. Riscopri, così, che quella Italia che pure non hai mai abitato, quell’Italia in cui non hai parenti e amici, ti appartiene come fosse un’infanzia che non ricordavi più di aver vissuto, e ti ritrovi così a gioire di sentirti a casa in Sardegna o nelle Langhe, in Puglia e in Lucania, in Campania e in Umbria, in Sicilia e in Toscana, e riconosci che potresti davvero abitare ovunque, che la casa che ti accoglie da forestiero potrebbe essere davvero la tua casa, e che i vecchi coi quali per anni ti sei fermato a parlare anche solo per qualche minuto, li avresti abbracciati tutti come abbracciavi tuo nonno, e allora percepisci che l’Italia, in ogni angolo, in ogni più remoto paese, custodisce segretamente la sua infanzia, un’infanzia a cui appartieni pur non avendolo mai saputo.
Ma cos’era l’Italia se non una contaminazione perpetua? E mi sembrava assurdo di poterlo toccare con mano proprio in Sardegna e non in qualsiasi altra regione d’Italia. Dico la Sardegna in cui poco è tollerata una storia, un passato diverso da quello autoctono, quello della civiltà nuragica, la sola, qui, che gli sia riconosciuto un diritto di nascita e influenza sui secoli successivi. Eppure, spostandomi sulla sponda Occidentale, percorrendo la Penisola del Sinis, in questo lembo di terra che spezza il profilo della provincia di Oristano, mi ero imbattuto nell’antica città di Tharros, dove le rovine mettevano in mostra, in un’istantanea, tutte le stratificazioni dei secoli. Nuragici, Fenici, Cartaginesi, Bizantini, Romani. Una stratificazione di storia, di culture, di civiltà, e non soltanto in senso figurato ma proprio tecnicamente, se è vero come è vero che i templi romani si sorreggevano sulle colonne doriche d’età punica. Capivo così che una civiltà che ne conquista un’altra, non necessariamente fa tabula rasa di tutto. Molto spesso costruisce su ciò che l’ha preceduta. L’intera civiltà è costruita sulle rovine di altre civiltà. La tradizione stessa non è che un tradimento del passato. Tradizione, del resto, ha una doppia etimologia: “trasmettere” e “tradire”. Quando riceviamo un sapere da qualcuno, quello stesso sapere, nelle nostre mani, necessariamente diventerà altro, si arricchirà della nostra esperienza e conoscenza. È così che la tradizione, guardando al passato, si rivolge necessariamente al futuro.
«La difficoltà che io trovo in questo ritorno al passato è quella di mantenere le prospettive», leggevo nel libro di Satta, «E si capisce perché: ognuno di noi, anche se si limita a guardare in sé stesso, si vede nella fissità di un ritratto, non nella successione dell’esistenza. La successione è una trasformazione continua, ed è impossibile cogliere e fermare gli attimi di questa trasformazione. Sotto questo profilo, si può dubitare del nostro stesso esistere…».
Forse era davvero questo il punto. La paura, insita in tutto il popolo Sardo, di mettere in dubbio chi erano o credevano di essere veramente. Se accettavano come vera la sola civiltà autoctona, è perché ai nuragici sentivano di appartenere ancora, di condividere con loro quel sistema di vita che si strutturava in piccole comunità, in un minuscolo agglomerato urbano che somigliava a un villaggio; villaggi e comunità separate l’una dall’altra, sempre in conflitto. I sardi si odiavano tra di loro finché restavano sull’isola, salvo poi scoprirsi fratelli, appartenenti a una sola e unica tradizione quando si incontravano oltre mare, quando erano costretti a emigrare. Gli altri popoli, le altre civiltà che avevano nei secoli abitato l’isola, non erano che invasori, estranei che volevano conquistarli, snaturarli, così come stranieri e invasori guardavano ai turisti che occupavano, in estate, tutte le coste. Solo a quelle pietre megalitiche dei nuraghe volevano restare fedeli, a quelle strane architetture che avevano trasformato da luoghi sacri e torri d’avvistamento in ovili in cui preparare il formaggio, in cui ripararsi in montagna durante le transumanze. Sacro allora era diventato anche l’ovile di pietra e tutta la loro cultura pastorale. Quegli ovili erano sarcofagi a cielo aperto, una sorta di necropoli diffusa in tutto il territorio, ma attraverso la quale riconoscersi, fare voto a un dio sconosciuto e solo loro: il dio della miseria, della rabbia, della solitudine, dell’orgoglio identitario.