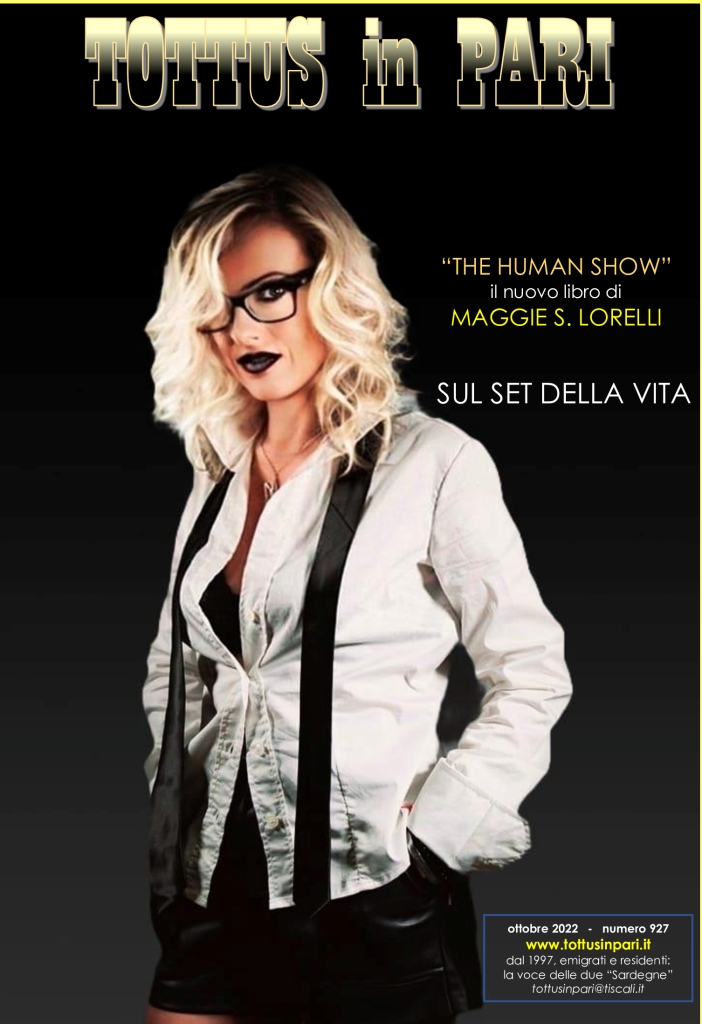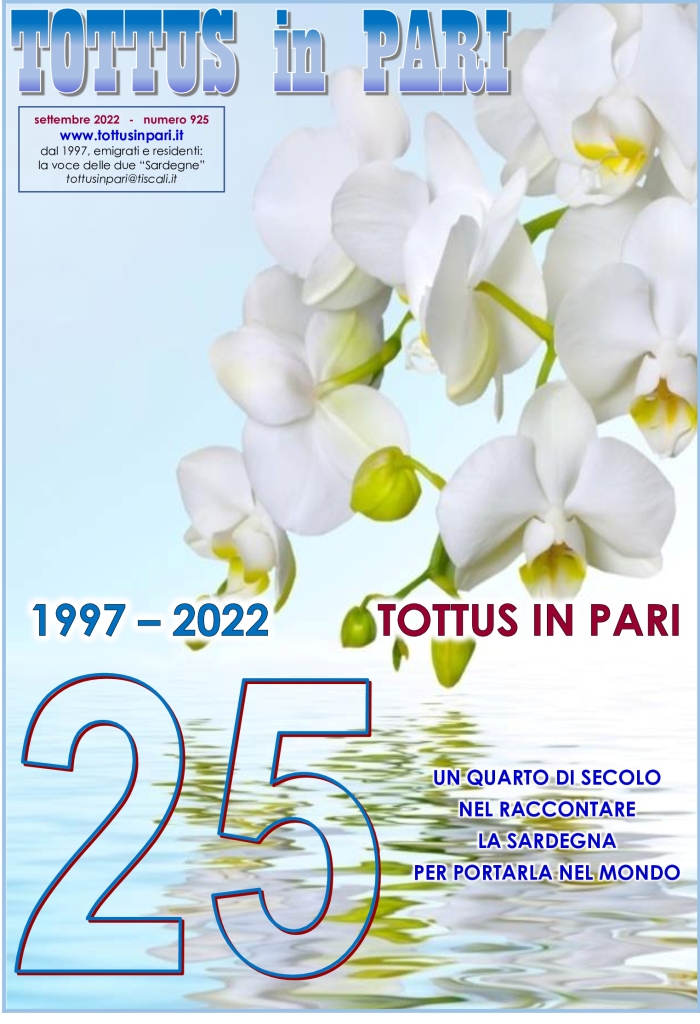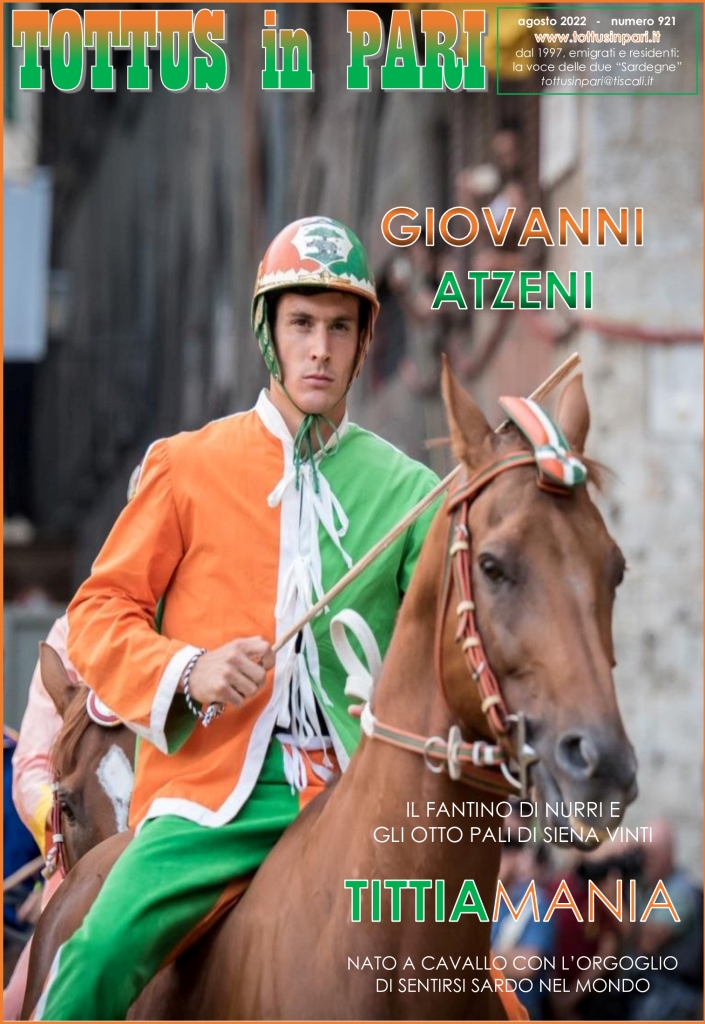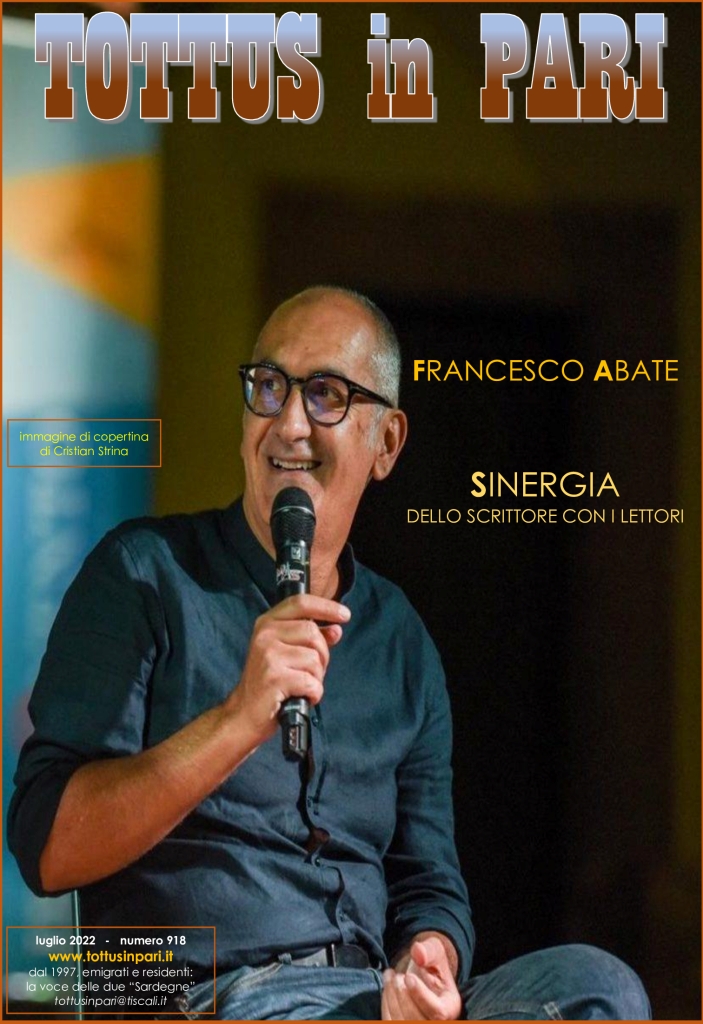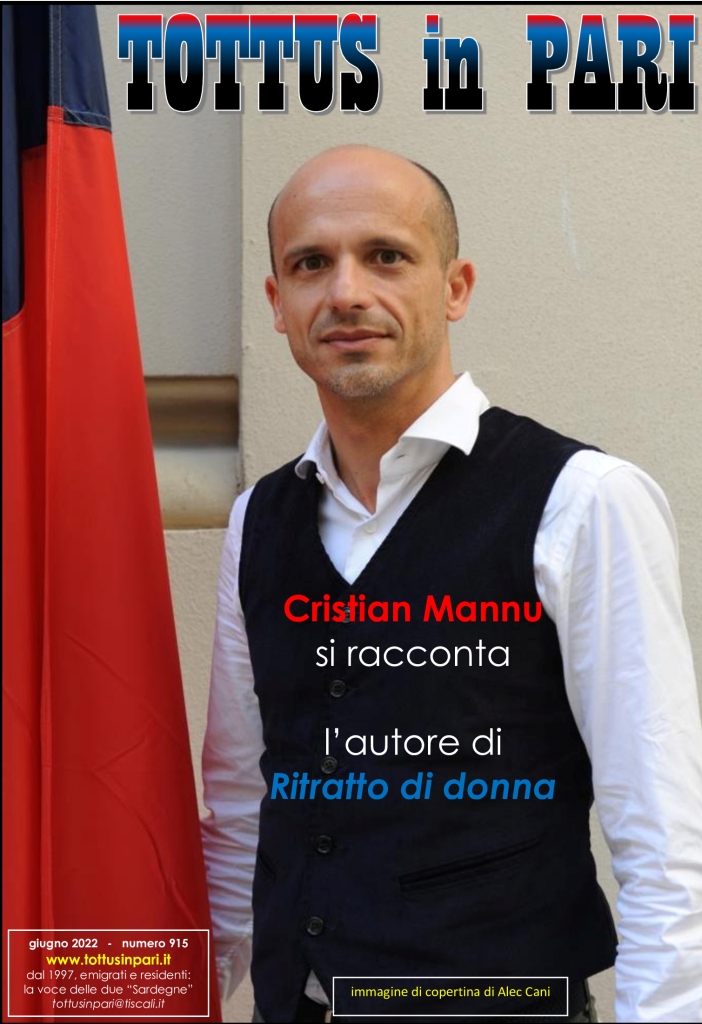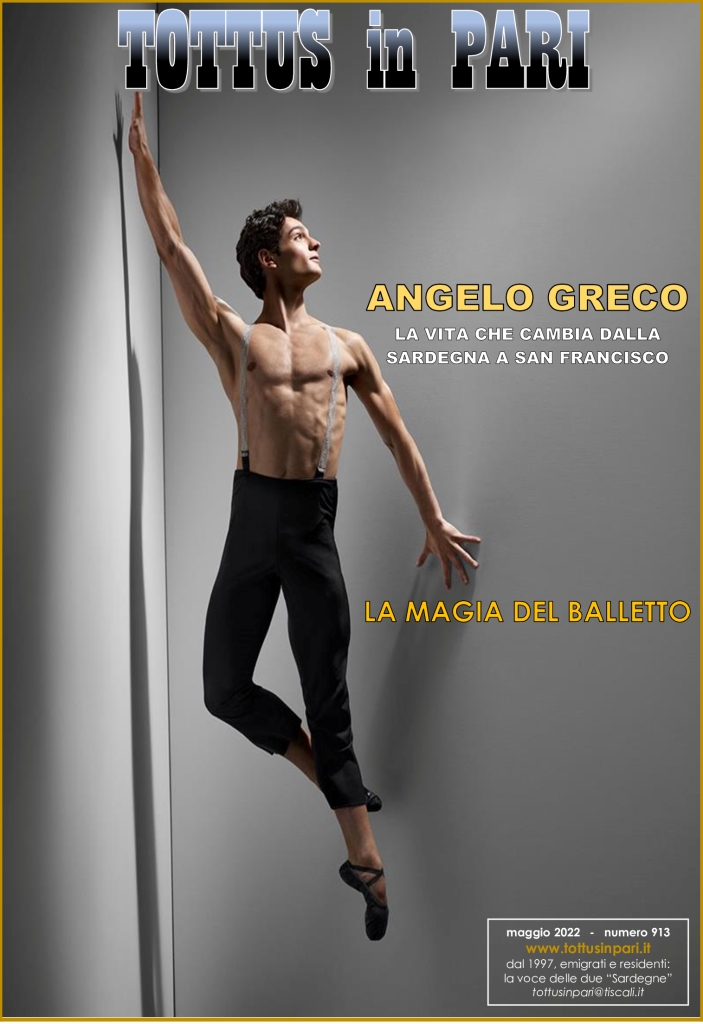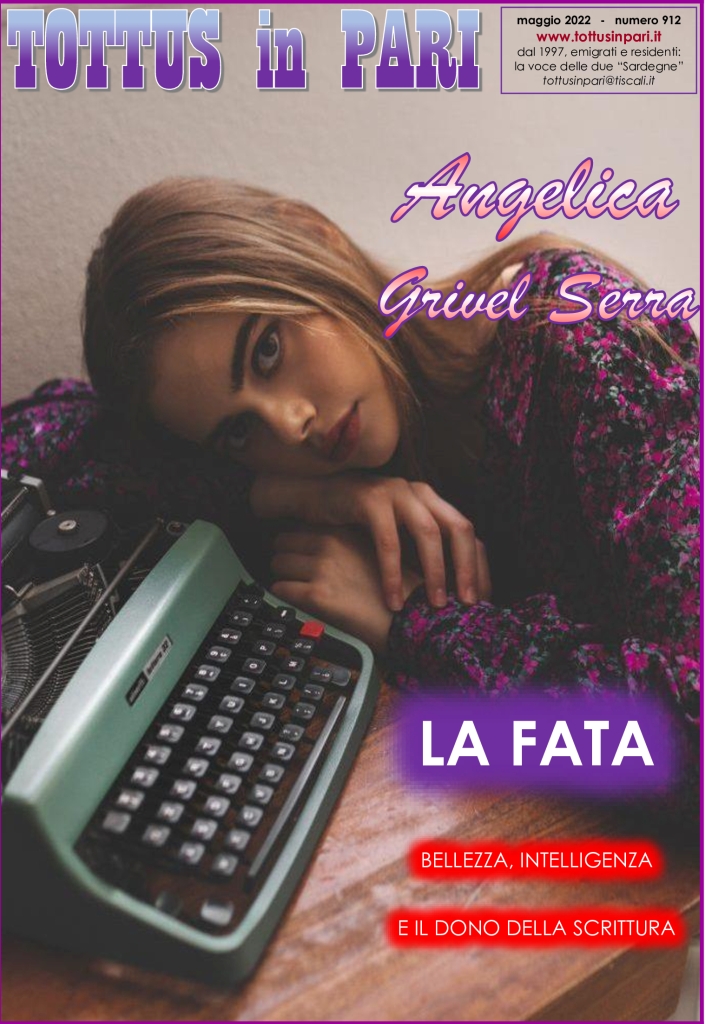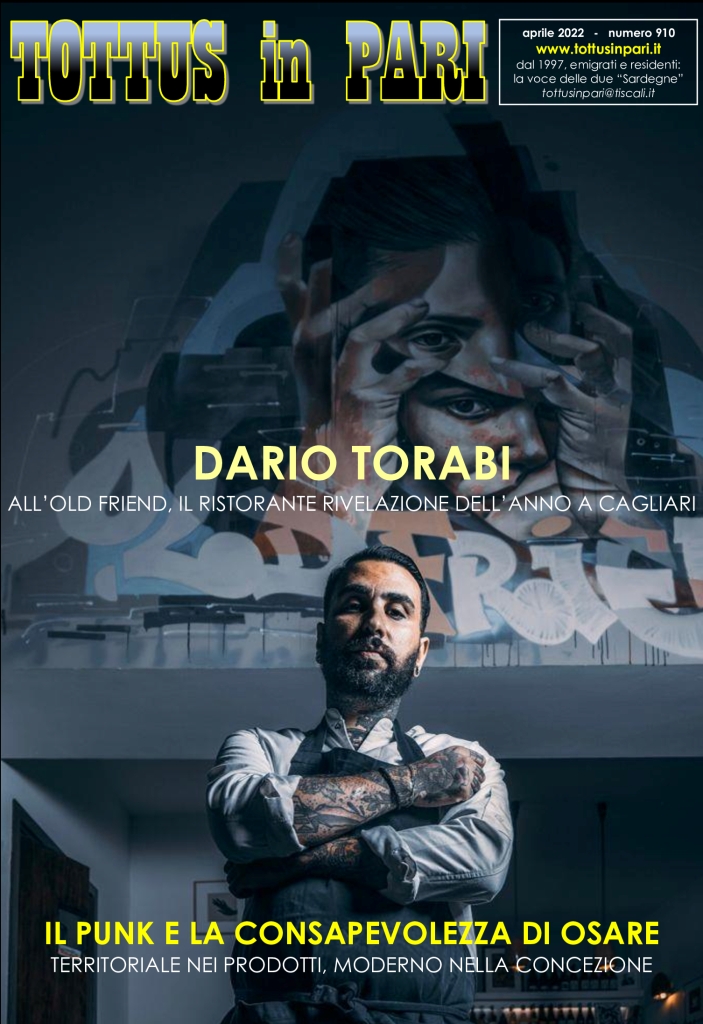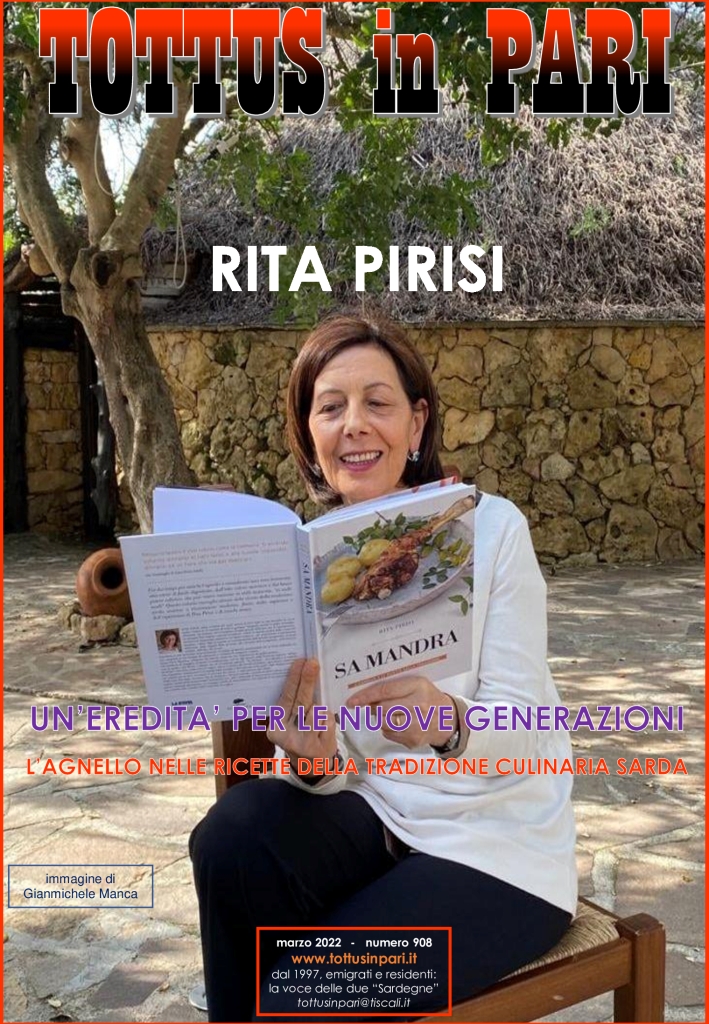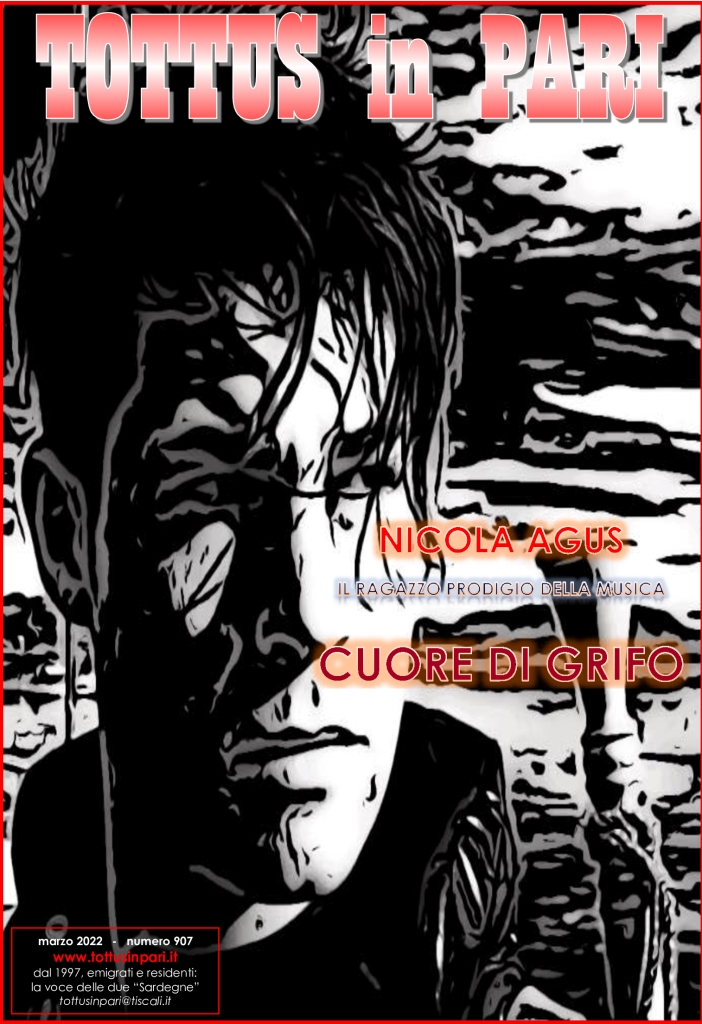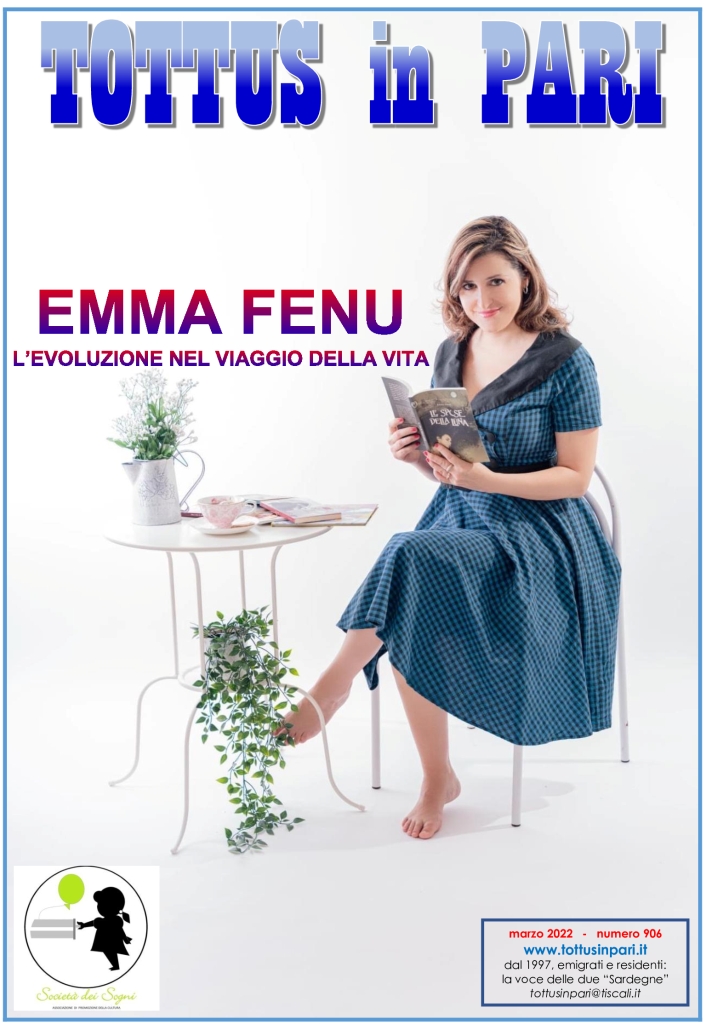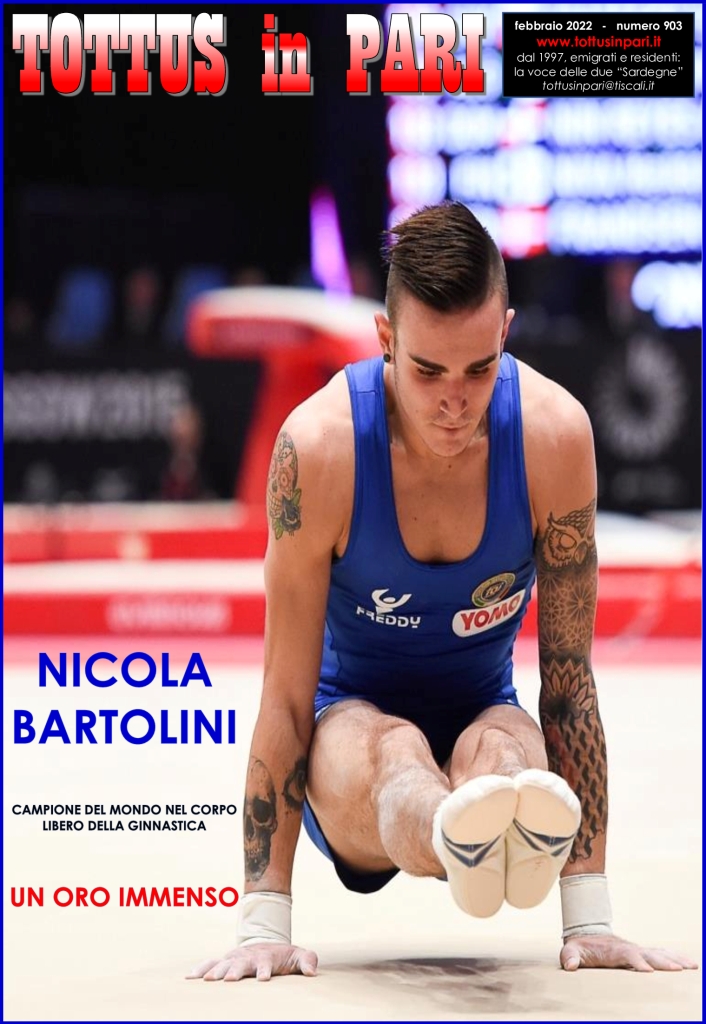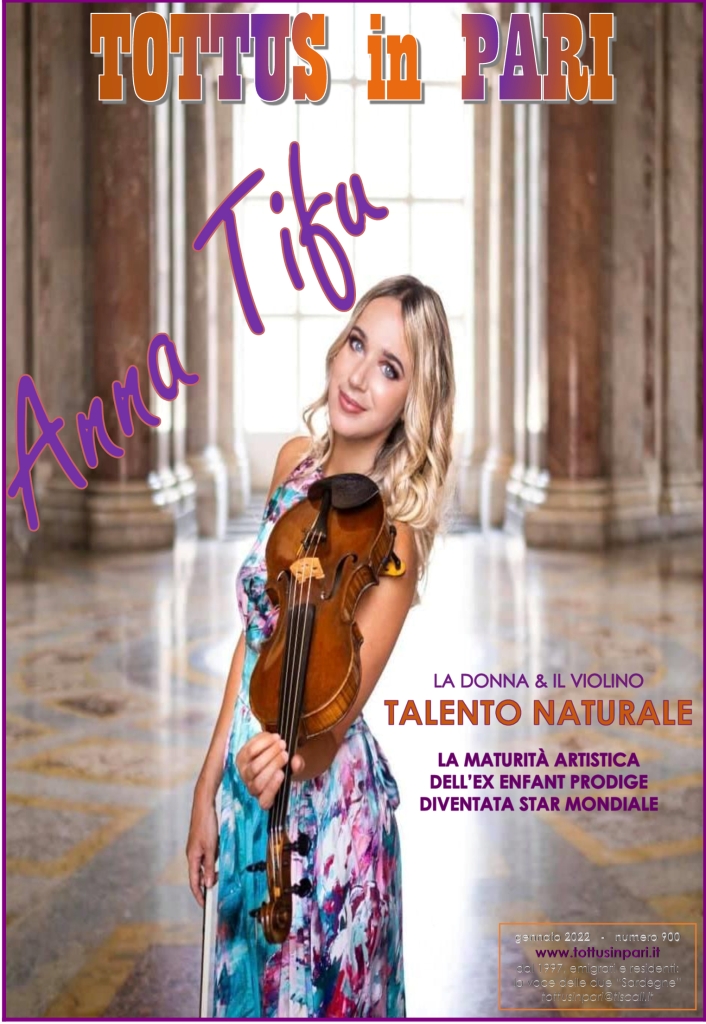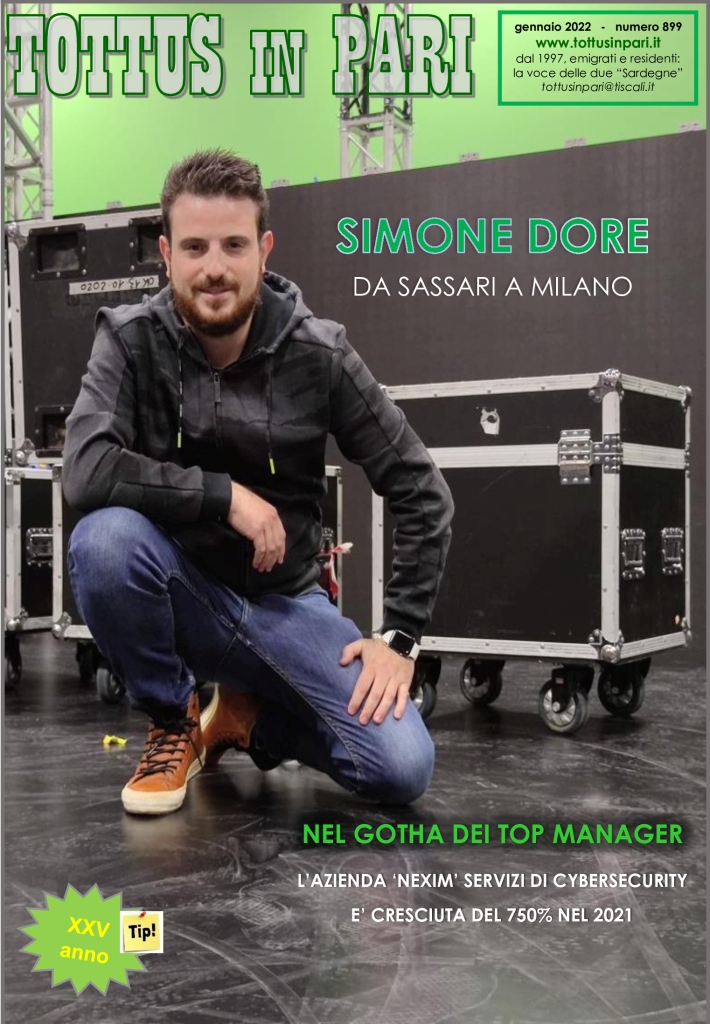di Claudio Moica
“Nemo propheta in patria”e se a dirla è stato Gesù Cristo sicuramente nessuno potrà negarla. Ma mai come in Sardegna è frequente questa abitudine tanto che per ricercare la verità su alcuni personaggi storici bisogna uscire dai confini regionali. Felicitas Maeder è una studiosa della storia del Bisso e chi meglio di lei poteva parlarci di Italo Diana considerato che in Sardegna tutto è messo a tacere? Nata nel 1946 a San Gallo, ha frequentato le Scuole a Teufen e a San Gallo; affrontato gli studi di lingua a Parigi, Londra e Bologna. Ha una formazione in Management di cultura, lavora in varie istituzioni religiose, sociali e culturali, attualmente ha in atto un programma interdisciplinare di insegnamento e di ricerca ambientale presso l’Università di Basilea. Impegnata nell’ambito culturale e ambientale. Dal 1998, volontaria presso il Museo di storia naturale di Basilea e iniziatrice del Progetto Bisso marino. Nel 2012 le viene assegnata una laurea Honoris Causa dall’Università di Basilea in “Philosophiae”per il suo lavoro sul Bisso marino.
Lei è volontaria presso il Museo di storia naturale di Basilea e iniziatrice del Progetto Bisso marino. Quando ha iniziato a interessarsi di Bisso e perché? Nel 2001 ho fatto un soggiorno di studi sul bisso marino a Taranto. Una bibliotecaria mi ha salutato e mi ha chiesto “Come mai una Svizzera, di un paese interno, arriva a portarci le radici della nostra storia?” La risposta era semplice. Nel 1997 ho avuto la possibilità di partecipare a una domenica di famiglia nel Museo di Storia Naturale di Basilea, sul tema conchiglie e chiocciole. “Muschelseide” – bisso marino in Italiano – era uno dei temi che suggerivano le pedagoghe del museo. Non avevo mai sentito questa parola, ma mi affascinò dal primo momento (forse l’associazione con il mare che amo, forse l’appello di qualche gene – mio nonno aveva un commercio di pizzi di San Gallo, e il sottotetto della nostra casa ne era pieno). A questo seguono le mie prime ricerche nelle biblioteche e archivi, il primo oggetto in bisso marino trovato a Berlino, la prima vetrina sul tema nel museo, il primo viaggio – a Calasetta e Sant’Antioco nel 1998. Un diploma di management culturale nel 2000 conteneva un progetto d’esposizione sul bisso marino – che realizzai finalmente nel 2004, in collaborazione con il Museo di Storia naturale e il Museo delle Culture di Basilea: “Bisso marino – fili d’oro dal fondo del mare”. Fin dall’inizio è stato importante per me presentare tutti i testi non soltanto in Tedesco, ma anche in Italiano – considerato che si tratta di un patrimonio italiano, non svizzero. Così anche il catalogo, il primo libro illustrato sul tema, è totalmente bilingue. Purtroppo, ha avuto poca risonanza in Italia.
Come si sviluppava il Progetto Bisso marino? L’esposizione era prevista dall’inizio come mostra itinerante. Così è andata a Taranto e Lecce nel 2006. Nel 2008 era a Lugano, nel Ticino, allargata ad oggetti tessili di Sant’Antioco che non erano ancora presenti a Basilea. Nel 2010 e stata messa in internet una sintesi delle mie ricerche in tre lingue: Tedesco, Inglese e Italiano (www.bisso-marino.ch). Lì si trova la storia del bisso marino intorno al Mediterraneo, dall’antichità fino a oggi, analisi delle fibre della Pinna nobilis, l’inventario di tutti gli oggetti trovati nei musei Europei e dei Stati Uniti, dal trecento alla meta del novecento, e un’ampia lista bibliografica. Il sito viene aggiornato continuamente con nuovi risultati di ricerche.
Quando si parla di Bisso si tende a rivolgersi a quello marino ma è corretta questa associazione? Sì e no. In ogni caso negli studi sul bisso marino è il tema più importante, il più difficile a far comprendere e il motivo principale per tanti malintesi ed errori d’interpretazione. Il termine bisso ha due significati. Primo: nell’antichità – anche nella Bibbia – si parla di un tessuto finissimo di lino (in un certo periodo forse anche di cotone). Tutte le bende delle mummie egiziane trovate fino ad oggi sono in lino. Il più fino, detto lino reale, era riservato per i sacerdoti e i culti dei tempi. Il secondo significato è: zoologico. Nel 1500 i filamenti delle bivalvi – come la Pinna – sono stati chiamati bisso dei naturalisti. Questo a causa della somiglianza con il bisso antico, non viceversa. Il naturalista francese Guillaume Rondelet menzionò nel 1555 due varietà di bisso: uno terrestre, quindi di lino, l’altro marino – «Byssus terrenus est et marinus». Però, come sappiamo, il bisso marino esisteva già nell’antichità; il più antico frammento è del 4° secolo d.c.- Ma mai era noto come bisso. Nel tardo antico veniva parafrasato, più tardi veniva chiamato fra l’altro lana di pesce, o lana di nacchera. In arabo ed in altre lingue aveva dei nomi che ancora non conosciamo con certezza. È questo il tema della mia ricerca attuale.
In Italia quali sono le regioni dove ancora si lavora il Bisso? Mi risulta che Sant’Antioco sia l’unico posto, dove oggigiorno viene ancora praticata la lavorazione del bisso marino. A Taranto probabilmente si è estinta con la seconda guerra mondiale. Si dice che una volta la Sicilia aveva un’ampia produzione di bisso marino – probabilmente si tratta di disinformazione, o traduzioni errate – ambedue cose molto comuni nella storia del bisso marino. Invece rafforza l’ipotesi del bisso marino nella Dalmazia, che presumevamo da fonti scritte.
Lei ha definito Italo Diana (1891-1959) la seconda persona per importanza sulla lavorazione del Bisso marino in Sardegna. Perché invece nell’isola si tende a sminuire la sua opera? Non è facile trovare informazioni su Italo Diana. Nel 2001 ho cercato nell’archivio comunale di Sant’Antioco, ma non ho trovato quasi nulla. Al contrario di Giuseppe Basso Amoux, non ha scritto niente sul suo lavoro, o almeno non è pubblicato. Oltre a ciò, e a differenza di Taranto, non si sa quasi niente sulla lavorazione del bisso marino in Sardegna primo del novecento. Benché Taranto non facesse parte dei soliti itinerari dei Grand Tour, i pochi visitatori quasi sempre raccontavano del bisso marino e portavano questo sapere nei loro paesi, come Swinburne in Inghilterra, von Salis Marschlins in Svizzera e Germania, Saint-Non in Francia, ed altri. Queste fonti mancano per la Sardegna. Non conosciamo in Sardegna neanche una persona come l’arcivescovo di Taranto, Giuseppe Capecelatro, che nel 700 promuoveva la lavorazione del bisso marino, per aiutare le famiglie povere dei pescatori. Poi, nell’inizio del 800, regalava dozzine di oggetti in bisso marino ai suoi ospiti – lo sappiamo fra la sua vasta corrispondenza che si è conservata. Certamente esisteva anche in Sardegna. (In una lettera del 8 Marzo 1804 alla sua amante Emma Hamilton, l’ammiraglio Nelson parla di un paio di guanti bizzaro e di un manicotto, molto raro, fatto soltanto in Sardegna dalla barba di conchiglie) Infatti Alberto della Marmora, nel 1826, parlava dei guanti in bisso marino che erano di uso frequente. Ma già nel 1820 Antonio Giovanni Carta aveva parlato del declino di questo artigianato tradizionale. Più tardi oggetti in bisso marino si conoscevano soprattutto nelle diverse esposizioni regionali e nazionali. A Cagliari, nel 1847, Giuseppa Poddigue di Oristano e Anna Melis di Cagliari esposero «un taglio di corpetto di nachera, berrettino di nachera, campione di nachera cardate». Nella prima esposizione sarda, nel 1871, Michelina Cara e Marianna Randaccio di Cagliari esposero un boa, un manicotto e uno sciallo. Il boa potrebbe essere quello che è stato mostrato due anni dopo all’Esposizione mondiale di 1873 a Vienna. Giuseppe Basso Arnoux (1840-1919) ha tentato il rilancio dell’artigianato del bisso marino. Negli ultimi anni della sua vita abitava a Carloforte e mi sono sempre chiesta se Italo Diana l’avesse conosciuto. Il Musée Océanographique di Monaco aveva comprato nel 1910 alcuni oggetti in bisso marino da Basso-Arnoux. Sarà stato lui ad averli fatti? Non lo sappiamo. E non si sa niente della sua fondazione Byssus Ichnusa Society, costituita per promuovere la lavorazione del bisso marino, e il perché avesse scelto come sede sociale Londra e non l’Italia. Anche degli oggetti fatti nell’Atelier Diana ne sono conosciuti soltanto alcuni che stavano in Sardegna. Dove sono tutti gli altri? Per esempio la coperta in bisso marino fatta da Margherita Raspa, allieva di Italo Diana, esposta e premiata a Venezia? O la tunica per una statua di San Francesco d’Assisi, fatta da Efisia Murroni?
La Pinna nobilis è attualmente sottoposta a regime di protezione e tutela in conformità alla Direttiva 92/43 “Habitat” della Comunità Europea ma nonostante tutto si continua a tessere con il Bisso. Da dove viene presa la materia prima? Non ne ho idea. La Pinna nobilis è endemica nel Mediterraneo, non esiste in altri mari. Altre specie della famiglia delle Pinnidae che vivono in tutti gli oceani sono molto più piccole. Non si sa se il loro bisso – molto più corto naturalmente – sia mai stato o sia usato per uso tessile.
La lavorazione del Bisso talvolta è associata a riti magici o pseudo religiosi. Secondo i suoi studi e le sue conoscenze che attinenza esiste tra le due cose? E’ veritiero che l’arte della tessitura del Bisso si può tramandare solo da madre a figlia? Il bisso (di lino) dell’antichità è da sempre legato a tanti miti e leggende. È lo stesso per il bisso marino. Ma non è il tema delle mie ricerche. Mi attengo a fonti scritte, dai classici ai moderni – e a questo proposito non ho trovato niente. Penso che il bisso marino e la sua storia di se stesso affascinino. Del resto, la trasmissione di un artigianato o un mestiere da padre in figlio o da madre in figlia è ben conosciuta sin dall’epoca preindustriale. Per quanto riguarda le conoscenze sul bisso marino, non ho mai trovato una tale tradizione nelle mie ricerche.
Considerata la sua esperienza nel settore ci può spiegare la differenza tra “Maestro” e “Tessitrice” del Bisso? No. Non ho alcuna spiegazione.
Che sviluppo può avere l’arte del Bisso ai giorni nostri? Cosa si augura per il futuro? Mi auguro che altri scienziati si interessino al tema. Per esempio non si sa niente di preciso su altri luoghi in Sardegna dove si lavorava il bisso marino. Si parla dell’Asinara, La Maddalena o Oristano, e forse altri. In più ci sono tante domande riguardanti la storia, l’archivistica, l’etnografia e la linguistica alle quali bisogna trovare delle risposte. Oltre a ciò mi auguro che tramite il tema del bisso marino la gente diventi consapevole della bellezza della natura – soprattutto quella marina – in tutte le sue sfumature e si renda conto dell’importanza di conoscerla meglio e di proteggerla.