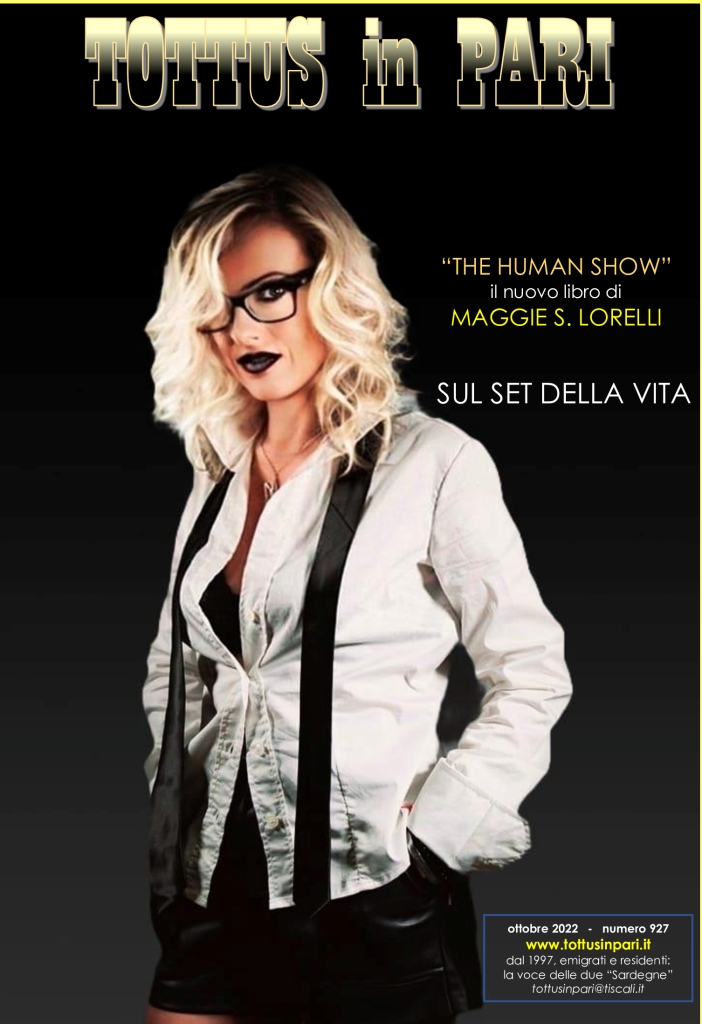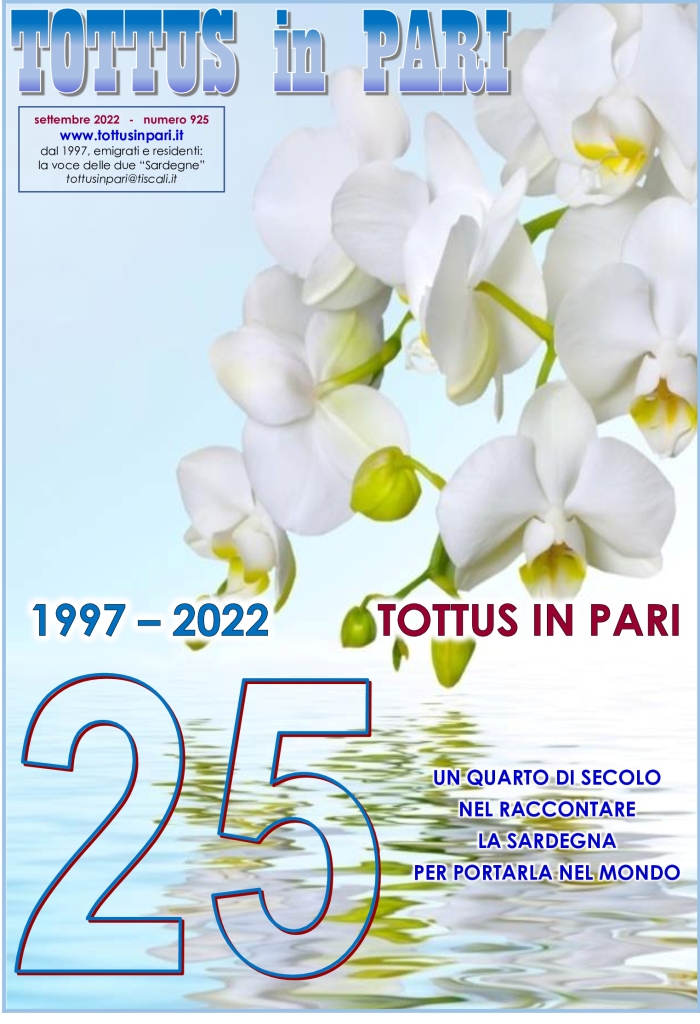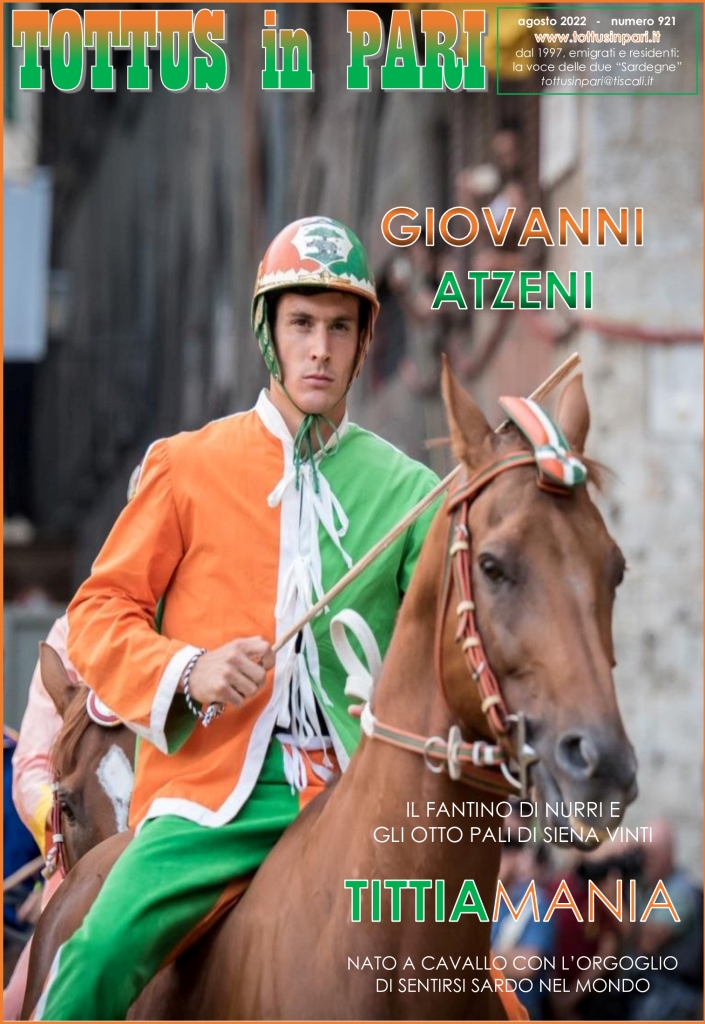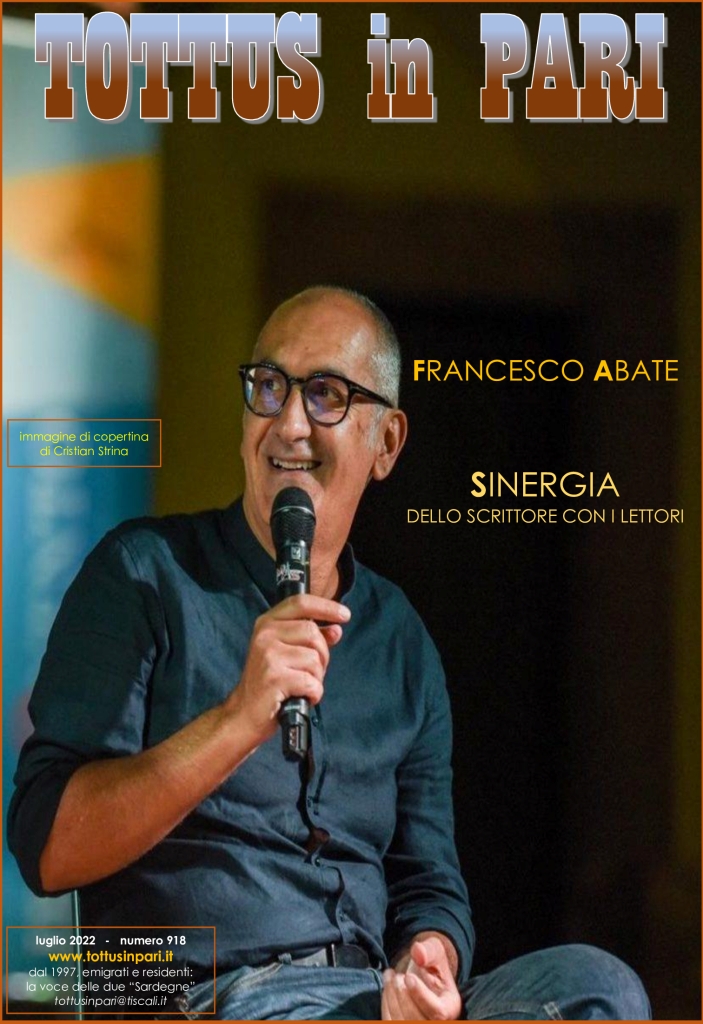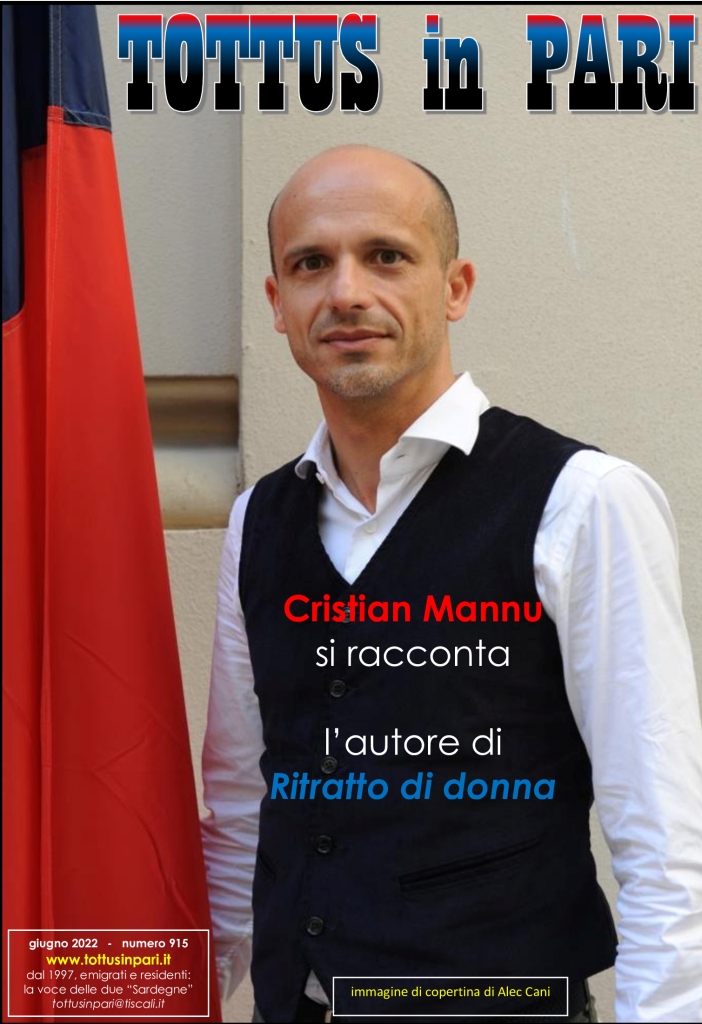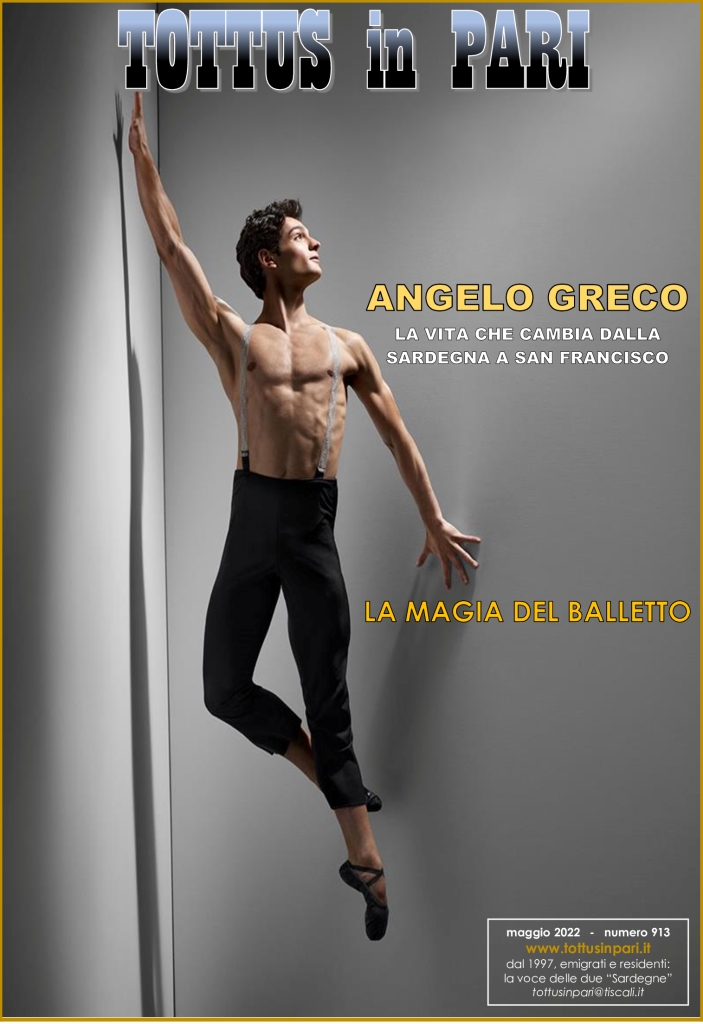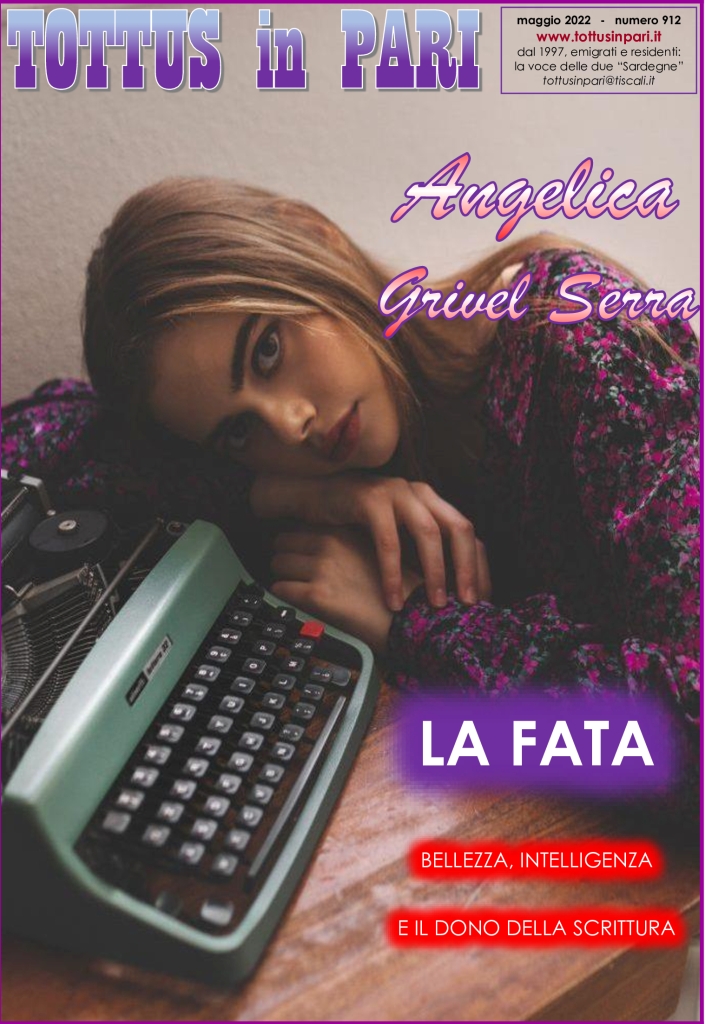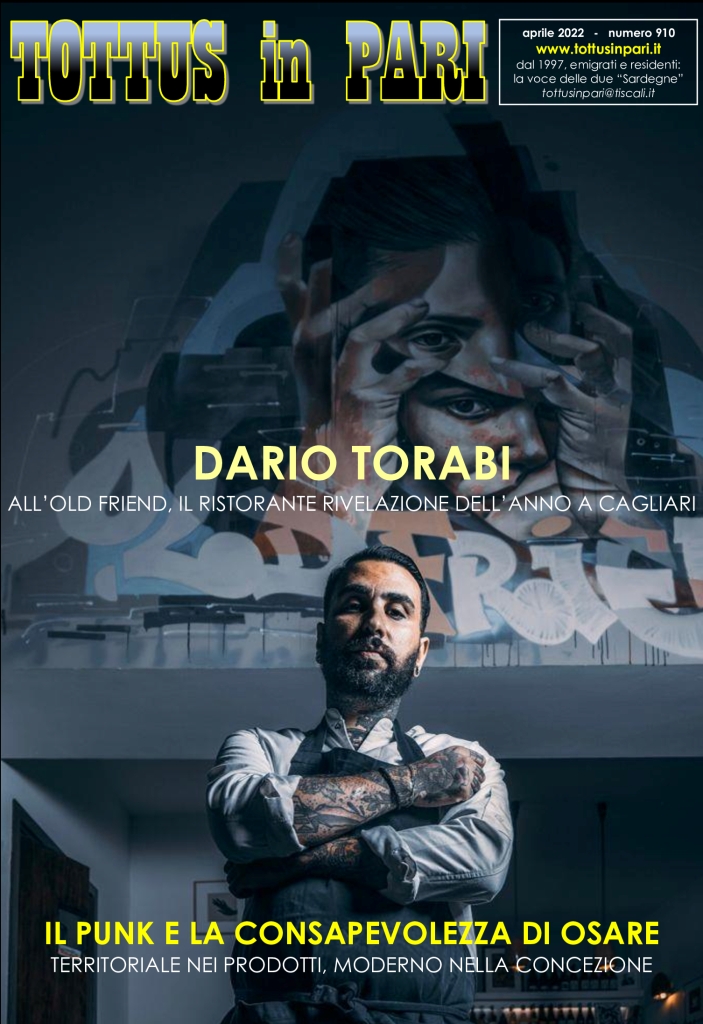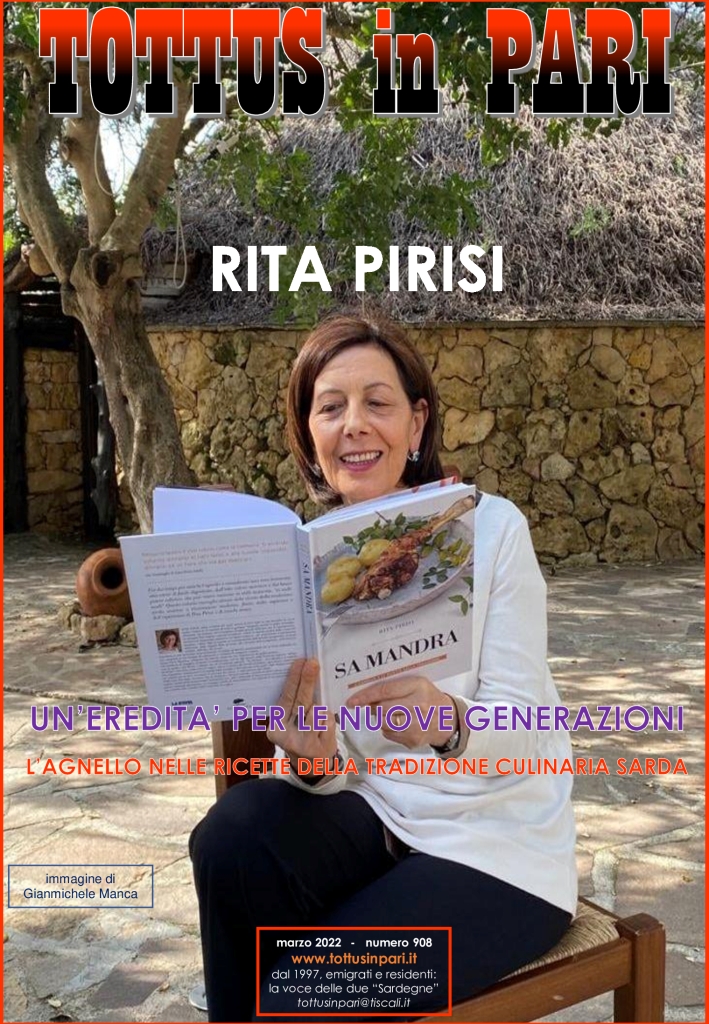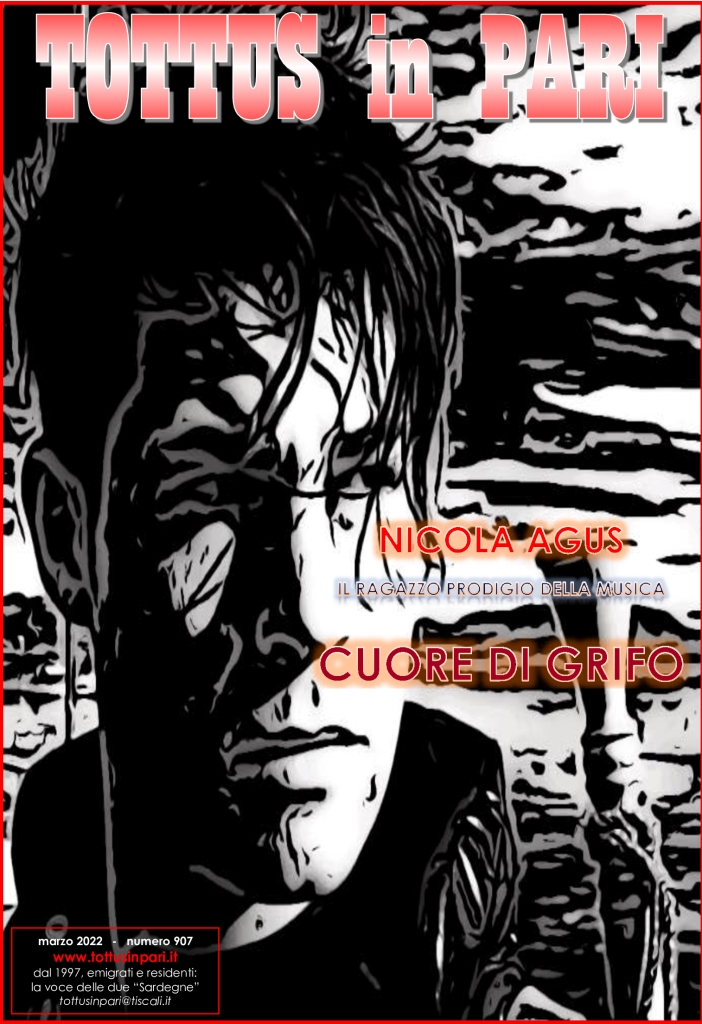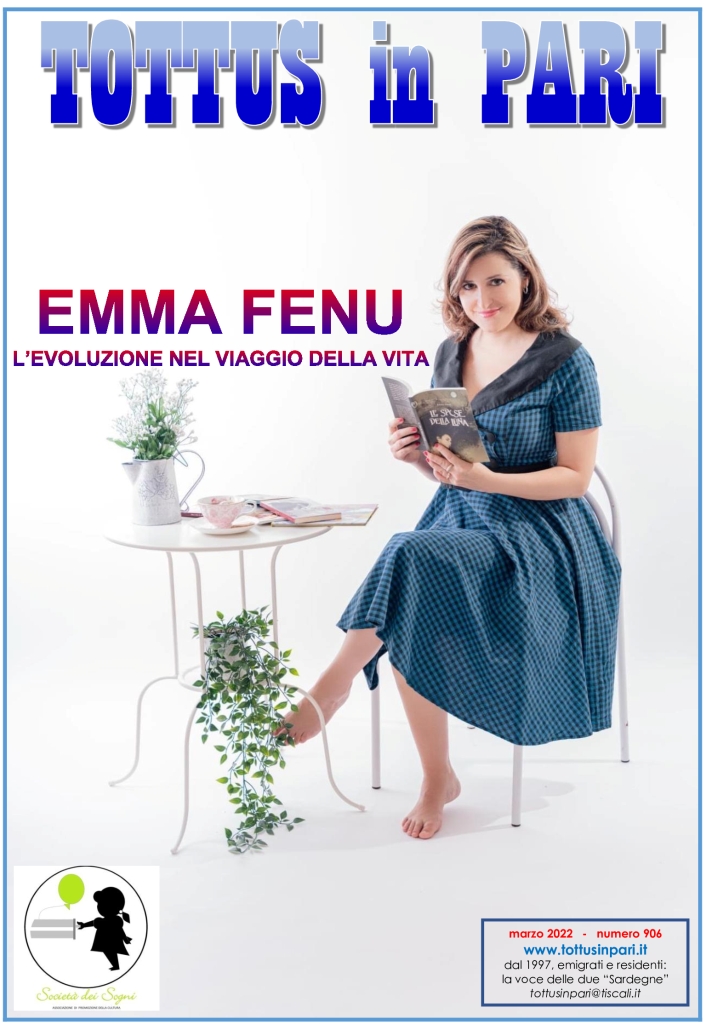di Antonio Mannu – Progetto Migrazioni
Questa pagina, già pubblicata sul quotidiano La Nuova Sardegna, nasce dal progetto: “Migrazioni – In viaggio verso i migranti di Sardegna”, un lavoro collettivo di ricerca sulla migrazione sarda. Durante lo sviluppo del progetto sono stati sinora visitati 11 paesi. “Migrazioni” è sostenuto dalla Fondazione Banco di Sardegna, dalla Provincia di Sassari, dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi e dalla Visual E di Sassari. Al progetto è dedicato un sito web: www.deisardinelmondo.it
«La salvaguardia di una lingua è importante e qui, in Nuova Zelanda, la conservazione del Maori è stata presa in seria considerazione». Sofia Manai, 14 anni, è nata ad Auckland il 24 marzo 1999. È figlia di Franco, oristanese e docente di Cultura Italiana all’Università di Auckland, e di Julie Spedding, che lavora come consulente per i dirigenti scolastici e si occupa di come migliorare prestazioni e risultati degli studenti. Sofia vive in parte con la madre e in parte con il padre e la sua compagna, Kirsten Hanna, docente universitaria di Linguistica e politiche pubbliche. Con un simile retroterra culturale, non stupisce che Sofia abbia, sulla lingua e sulla sua trasmissione, idee chiare e radicali. Per lei ogni idioma è una ricchezza, con sue caratteristiche e bellezze. Perderlo significa smarrirle. «Sono secoli di civiltà e di storia accumulati in una lingua. E la lingua influenza il nostro modo di pensare. Chi la parla dovrebbe preoccuparsi di trasmetterla ai figli». Per Sofia l’insegnamento a scuola è faccenda delicata. «In Nuova Zelanda la possibilità di apprendere la lingua maori è offerta in molte scuole. Penso sia giusto, però attualmente è poco efficace. Io, ad esempio, ne ho una scarsa conoscenza. Bisognerebbe trovare alternative all’insegnamento diretto, che aiuta ma non basta». Riguardo al sardo, per lei un’opzione potrebbe essere quella di dargli un valore maggiore, utilizzandolo per l’insegnamento di alcune materie. Ad esempio, si potrebbero fare in sardo le lezioni di geografia e storia. «È complicato – dice Sofia – ma mantenere viva una lingua non è semplice e non è a costo zero. Penso però che ne valga la pena».
La Sardegna. Sofia conosce bene la Sardegna, dove trascorre qualche mese ogni anno. E si sente un po’ sarda. «Non solo perché mio padre viene da li, ma perché, sin da bambina, sono stata esposta alla cultura dell’isola, dove ho vissuto e ho frequentato anche la scuola. La Sardegna è presente nella mia vita, ha modificato il mio comportamento, in particolare nelle relazioni con gli altri. Ad esempio, io non ho riserve verso il contatto fisico, anche nei confronti di persone appena incontrate».
Il contatto fisico. E Sofia spiega che, nella cultura kiwi, il contatto fisico è riservato alle manifestazioni di affetto profondo, alle persone con le quali si è in confidenza. «Qui, di base, non ci si sfiora proprio, al massimo ci si scambia una stretta di mano». Tra i vantaggi nel vivere a Auckland c’è la sua grande diversità culturale. «Mi piace il contributo di differenze che le tante etnie portano a questa città. Nella mia classe ci sono etiopi, cinesi, tedeschi, polinesiani e neozelandesi maori, oltre ai kiwi di origine europea come me, figlia di un sardo e di una neozelandese di origine inglese». Sofia frequenta il secondo anno delle superiori presso l’Avondale college di Auckland. L’opportunità di avere relazioni con persone di diversa cultura e origine è preziosa e le permette di confrontarsi con modi differenti di vedere il mondo.
La cultura kiwi e le altre. «Non è sempre così. Chi non è abituato a convivere con altre culture spesso vede le cose in maniera ristretta. Le diversità possono infastidire, creare distanza, piuttosto che interesse e rispetto». Per lei ogni cultura ha caratteristiche positive ma, al tempo stesso, pensa che alcuni modi di fare, che poco si adeguano a un nuovo contesto, possano e debbano mutare. Il confronto con altre culture permette poi di comprendere cosa può essere messo in discussione dei propri comportamenti, eventualmente assorbendo nuove idee e consuetudini. Uno scambio e un dialogo reciproco. «Io – aggiunge Sofia – attraverso la scuola sperimento questo confronto. Quello che insegnano a scuola ha le sue basi nella cultura del paese in cui vivi e qui è essenzialmente di derivazione europea. Ma non tutti gli abitanti della Nuova Zelanda di oggi hanno le loro radici culturali in Europa, e non mi riferisco soltanto ai maori. Auckland, ad esempio, è la città al mondo con la comunità di polinesiani più vasta di quelle che si trovano nelle principali città delle isole del Pacifico. Di questo si tiene conto ma non si fa abbastanza. Faccio un semplice esempio: in Europa, quando qualcuno ti parla, è buona norma guardare il proprio interlocutore negli occhi. Nella società polinesiana guardare dritto negli occhi è un segno di sfida e un ragazzo polinesiano non guarda negli occhi un adulto, o un insegnante: per loro è una mancanza di rispetto al limite della provocazione. Molti docenti, che non hanno idea di questa consuetudine, giudicano sfuggente e irrispettoso questo atteggiamento, mentre è esattamente il contrario. Credo sia nostro dovere conoscere le usanze dei polinesiani, capire il loro sistema di valori e come si esprime, attraverso quali atteggiamenti e gesti».
Sistema scolastico. Sofia prosegue parlando delle differenze tra il sistema scolastico italiano e quello neozelandese. Trova che programmi e metodi di insegnamento italiani siano piuttosto rigidi e che vengano assegnati molti più compiti a casa. In Italia, per lei, la scuola è considerata uno strumento di apprendimento, non di formazione. «Trovo che il sistema italiano sia più accademico di quello neozelandese e personalmente mi ci trovo bene, perché ho facilità di apprendimento e lì imparo di più. Però qui si fanno molte più attività pratiche, spesso non ci sono libri di testo da seguire e c’è più libertà per gli insegnanti». Della Sardegna le piace il cibo, il paesaggio e il mare, così diverso da quello della Nuova Zelanda. «Qui il mare è un’entità da temere. Auckland sorge tra due mari diversi: a Ovest c’è il Mar di Tasmania, molto aggressivo, con grandi onde e fortissime correnti; sul lato orientale c’è l’Oceano Pacifico, che è più tranquillo ma non scherza. La Sardegna invece è circondata dal Mediterraneo, un mare amichevole, ma da rispettare comunque. Qui, a scuola, si fanno lezioni di nuoto obbligatorie. Perché in mare non si può andare se non si sa nuotare per davvero».