di Massimiliano Perlato
Giovani, determinati con una grande passione per il canto a tenore. E lo sviluppano in Lombardia, la Regione che li ha accolti, direttamente e non, dopo aver lasciato la Sardegna. I Tenore Sos Emigrantes sono Marco Giobbo (boche) originario di Orgosolo; Istevene Pira (bassu) originario di Nuoro; Diego Meda (mesu boche) nato a Varese. Il gruppo si appoggia all’associazione culturale “Iscola e Tenore Angelo Caria” di Nuoro e si costituisce in virtù del rapporto di amicizia fraterna che si è sviluppata dopo i primi incontri nei vari circoli degli emigrati sardi. Facciamo quattro chiacchiere con Istevene Pira, leader del gruppo: “L’obiettivo dei Tenore è quello di trasmettere al di fuori del territorio di provenienza, le tradizioni sarde con l’intento di diffondere le radici storiche attraverso il canto. Il Tenore Sos Emigrantes esprime la necessità di tramandare la plurimillenaria storia del canto “a tenore”, già trasmessaci oralmente dai nostri avi ed emblema dell’espressione canora “tipica” della Sardegna”.
Riconosciuto, del resto, per la sua unicità, come “patrimonio immateriale e intangibile dell’umanità” dall’Unesco nel 2006, questo “canto” nasce, secondo alcuni studiosi, dall’esigenza di riprodurre “le voci” della Natura ed amalgamarle in un unico “suono”, senza l’ausilio di strumenti musicali, adoperando solo le corde vocali. “La riscoperta di alcuni reperti archeologici, come quella del bronzetto nuragico con il braccio in una particolare “posizione ad angolo”, la mano poggiata sull’orecchio e la bocca spalancata – ci racconta Istevene – colloca questo canto tra le radici più profonde della storia, ancor prima del periodo nuragico”.
Il Gruppo denominatosi “Sos Emigrantes” nasce in base ai racconti ed alle registrazioni storiche, si è concretizzato nell’incontro in determinate occasioni: in tutte queste circostanze, per unirsi e distrarsi nel tempo libero, si sentiva la beneamata frase ‘’ajò ca pesamus unu tenore’’ e, lì, le voci singole, di diversi paesi, si univano dando sfogo alla propria passione e seguivano il concetto base della cantata dettata dalla voce di uno specifico paese. La costruzione canora avviene in forma non schematica concependo le diversità canore e facendone un proprio bagaglio culturale, capendo che il tenore non è solo un canto, con delle voci di una eccezionale rarità, ma è tutto l’insieme crea una spettacolare armonia. Il canto a tenore, però, non è solo questo: è un ragionamento costante, un botta-e-risposta tra le voci, un dialogo interno, un racchiudersi di emozioni, e di affinità, trasmesse anche solo con lo sguardo. “Il Tenore Sos Emigrantes – precisa Pira – si impegna nella ricerca costante, al di fuori della propria Terra, delle voci emigrate, ma anche nel recuperare materiale video e audio esistente già dai primi anni ‘50. La nascita del “canto a tenore”, quale esempio del richiamo del pastore e del contadino, in determinati frangenti in cui si eseguono vere e proprie “risposte” al mondo della Natura; un’intuizione che pochi hanno concepito, ma che all’interno dell’isola esiste tutt’ora: un pastore riconosce, in mezzo a mille pecore, il proprio gregge o il proprio singolo capo di bestiame”.
Il gruppo “Sos Emigrantes” presenta, e divulga, questo canto, utilizzando, però, un concetto del tutto inusuale e che determina una complessa struttura gerarchica. La radice del gruppo “nascitura” è del tutto differente dai singoli canti provenienti dai diversi paesi sardi, incontrandosi, le voci, in un luogo di “non appartenenza”. Unite nella passione del canto, prostrano le proprie esperienze all’interno dell’amicizia che da subito si è instaurata. Questo dà l’animosità e l’accordo alla base canora, proprio come avveniva, nei tempi addietro, in occasione della transumanza (per motivi di pascolo ci si spostava in luoghi differenti), o in trincea. “Noi ci siamo ritrovati al di fuori della nostra isola per motivi di lavoro e, qui, incontrandoci in vari circoli sardi, abbiamo formato il Gruppo. Eseguiamo solitamente il tipico canto di un paese, e questo in virtù del rispetto dei “codici imposti”, secondo i quali, se la voce appartiene ad un paese, deve cantare la sua “moda” e proporre il suo “garbo”. Mentre le altre voci seguono a libera interpretazione. Quello che possiamo dire, su come attualmente è possibile conoscere ed eseguire questo canto tipico, è che noi l’abbiamo appreso, e ci è stato insegnato, per tramite dei nostri parenti, ma anche degli anziani del paese di origine, i quali, nell’unirsi nel tempo libero con la propria compagnia di amici, avevano l’abitudine di cantare, al fine di contribuire a stringere i legami sociali e tramandare a tutti questa espressione canora quale marchio culturale indelebile”.
Molte sono le teorie e gli studi a tal proposito, proprio per via delle caratteristiche distintive di questo canto; una di queste riguarda l’ambientazione sociologica in cui si colloca, e dal quale derivano le sue voci, che sarebbe riconducibile al mondo agropastorale. La particolarità non consta solo nella formazione delle voci e nella creazione dell’armonia, ma anche nel decifrare un insieme di codici che nascono nella singola cantata e muoiono con il chiudersi della stessa. Mai ripetitiva, mai costruita, bensì del tutto spontanea ed improvvisata. Il canto a Tenore è l’incontro fra l’uomo e la natura. Bisogna dire che l’ambiente di Sardegna è ricco di sonorità singolari e particolari, come quella del vento che soffiando trova sbocco tra gli alberi, i muri ed i ruscelli. Il fragore dell’acqua impietosa, quando sgorga da un ruscello in piena in periodi costernati di piogge e cambi stagionali; il passaggio dall’inverno alla primavera, dove le nevi si sciolgono tra le montagne, dando così vigore alle sorgenti; il cinguettio degli uccellini, il gracidare delle rane, il frinire dei grilli e delle cicale, il ronzio delle api, ma anche il belare delle pecore ed il muggire dei buoi. Il silenzio della ‘campagna’, dipoi, fa percepire un suono, poetico e sentimentale, e forgia soprattutto il carattere, nel concepire l’agreste quale modalità di vita.












































































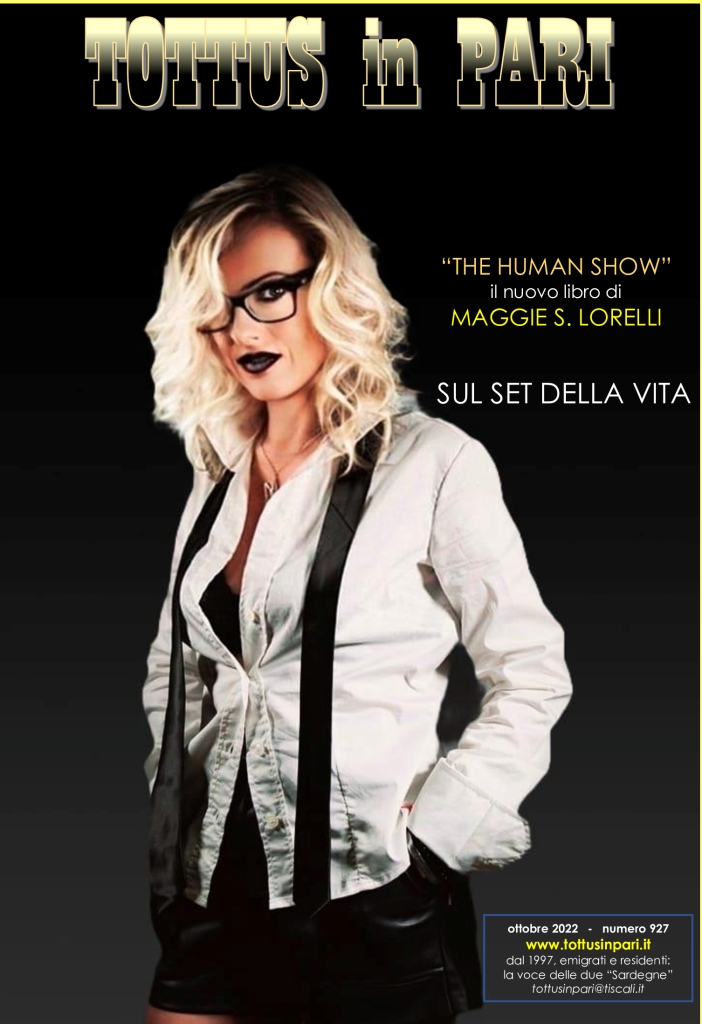

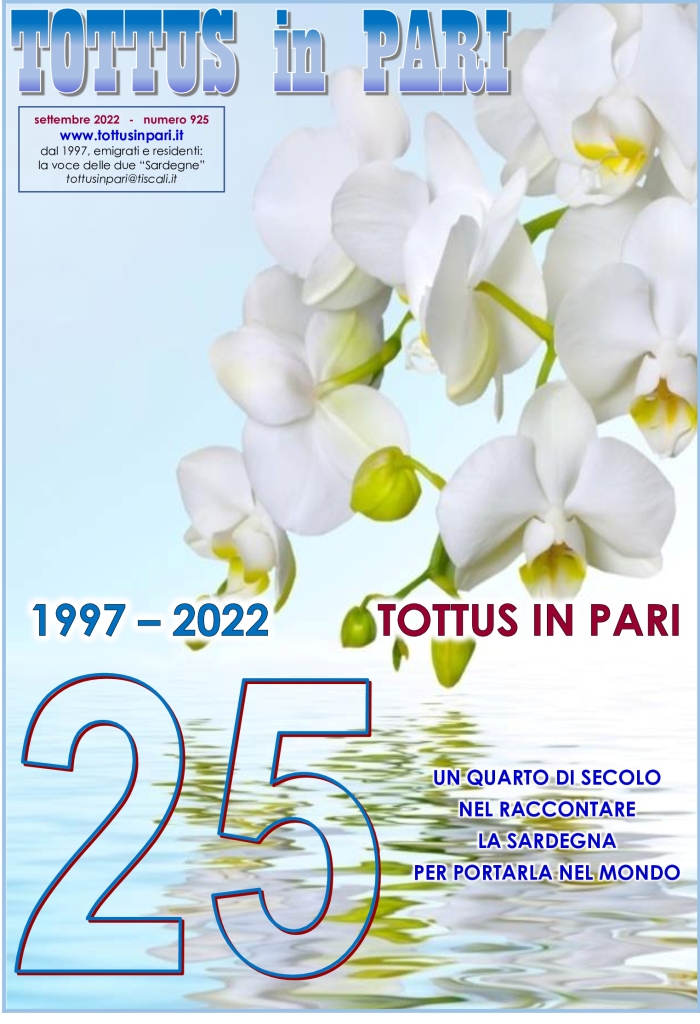



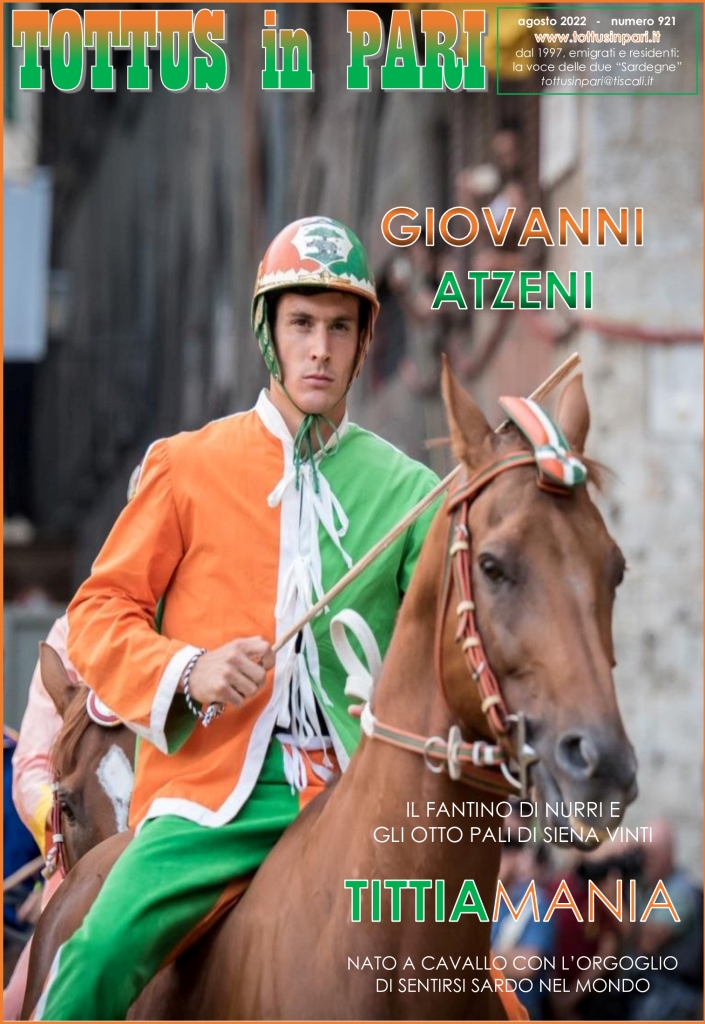


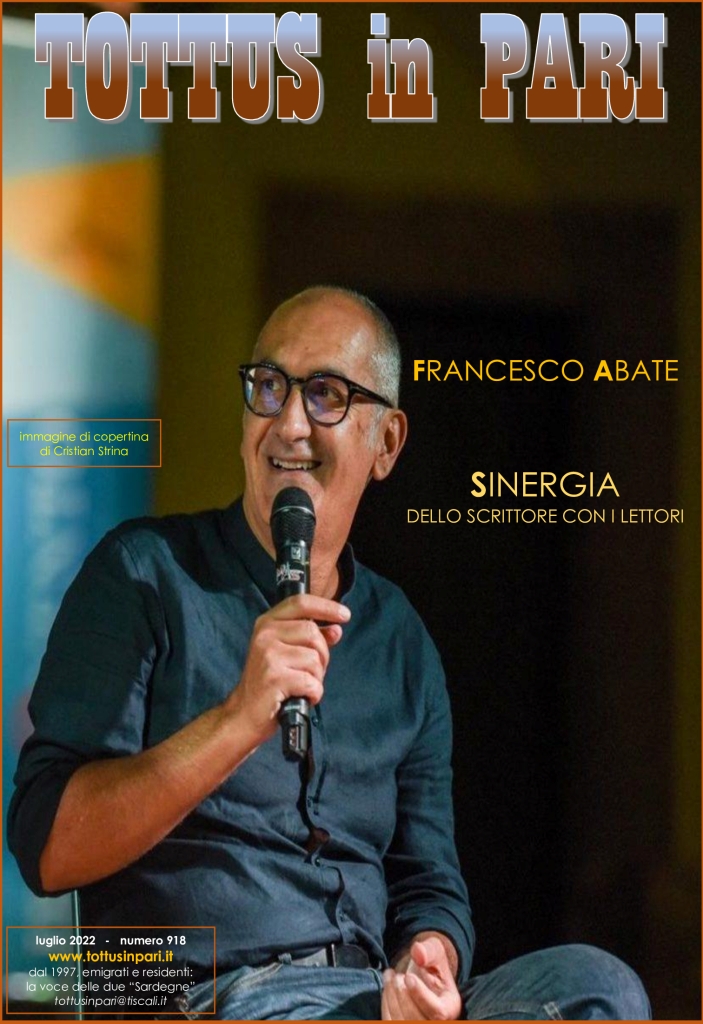


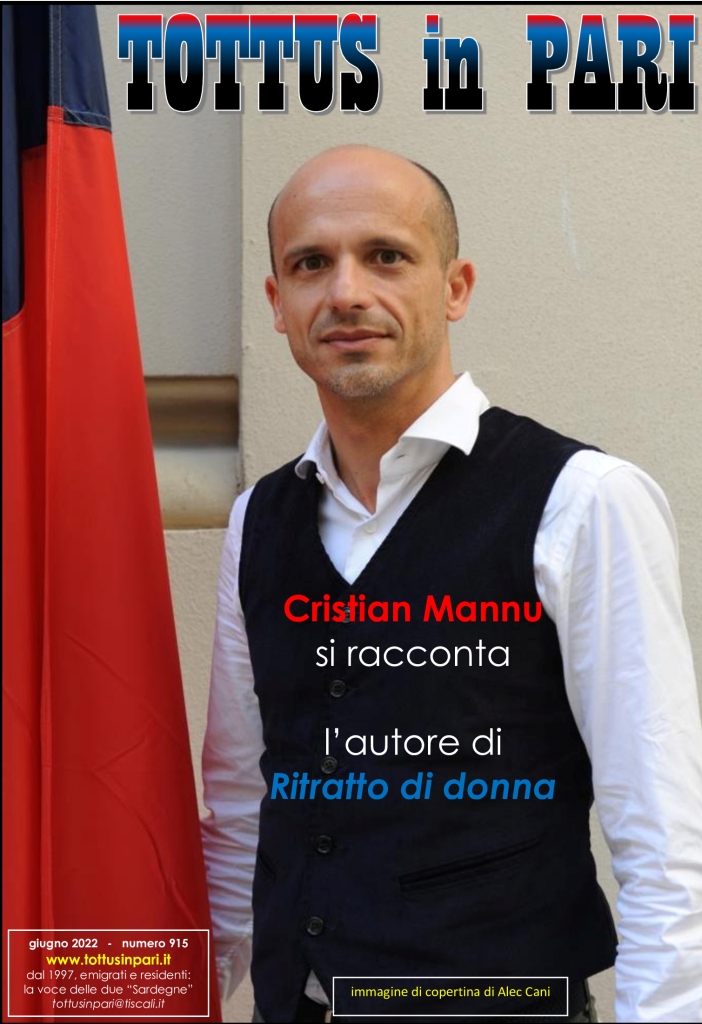

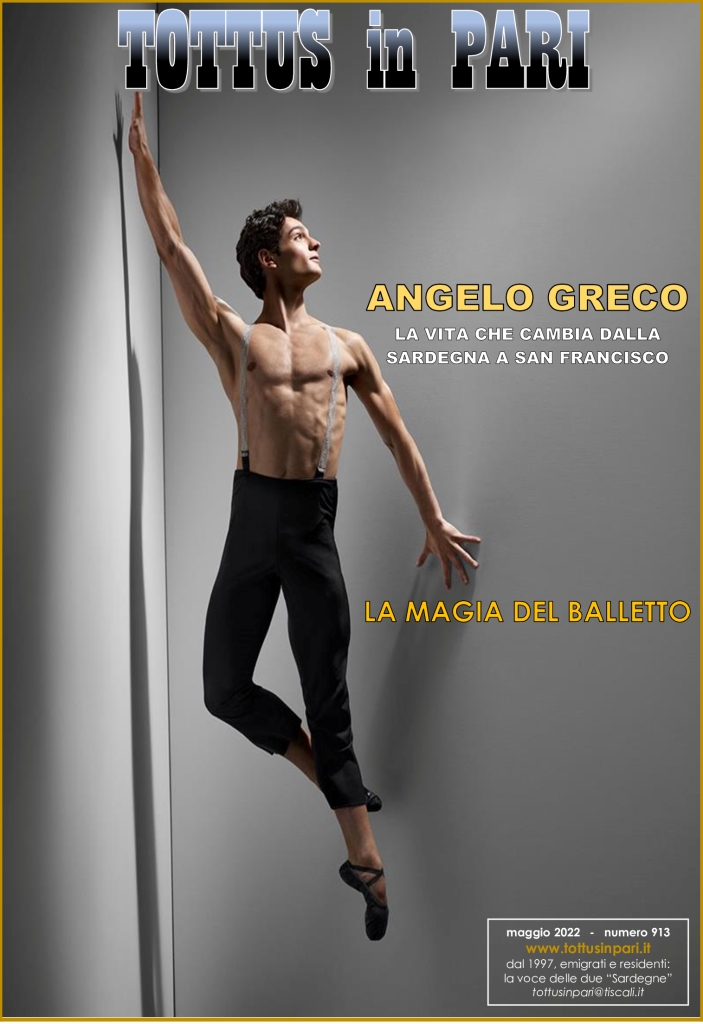
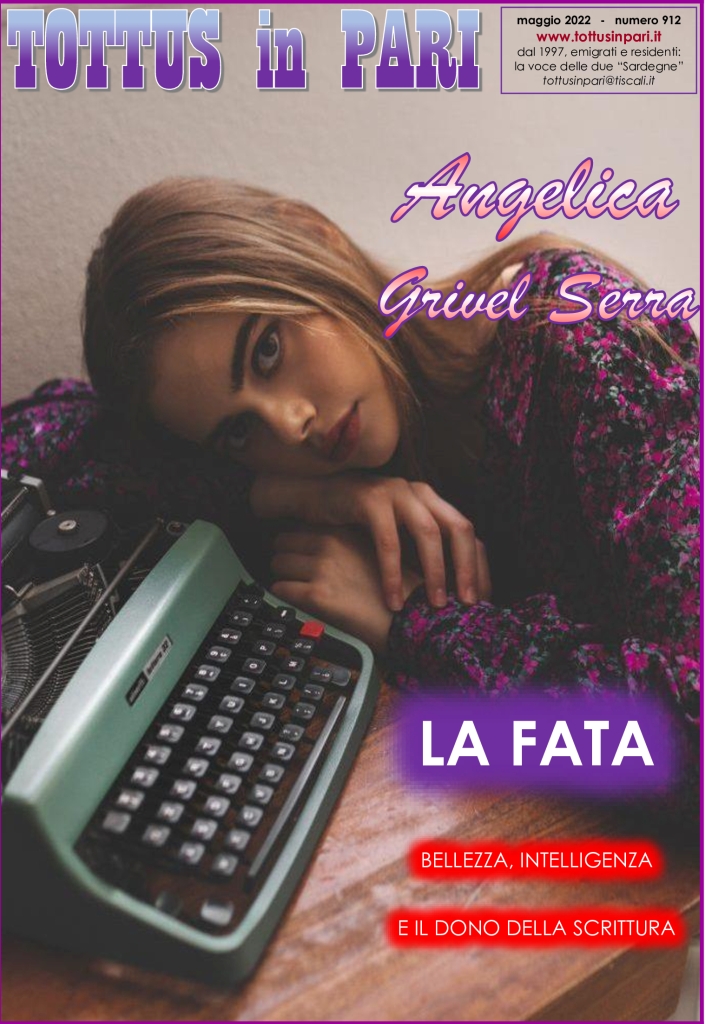

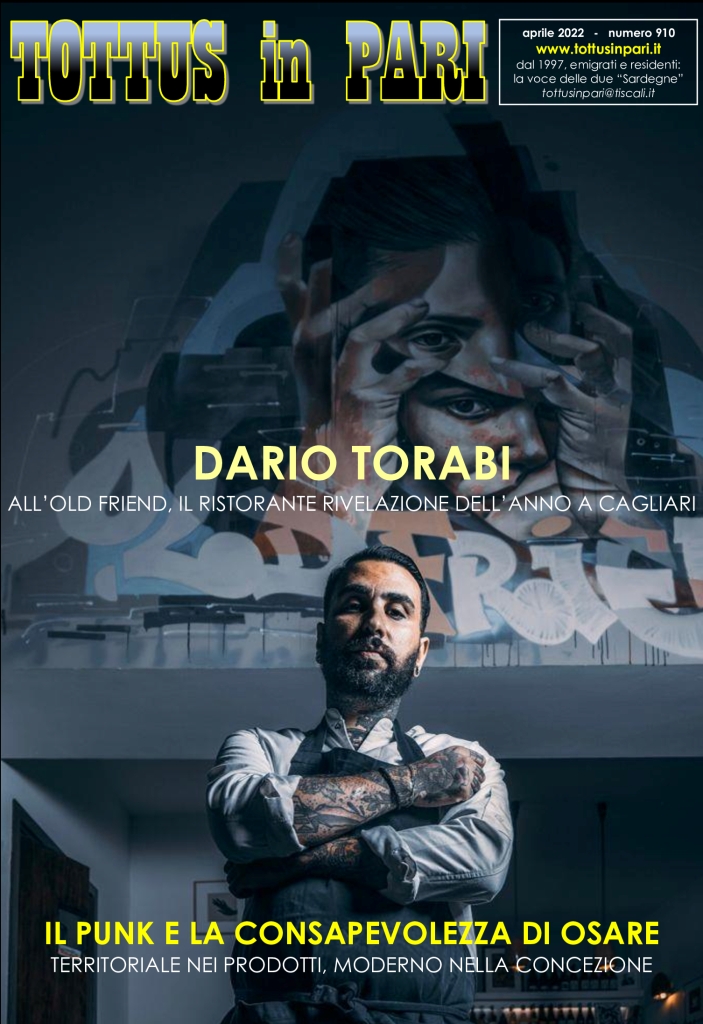

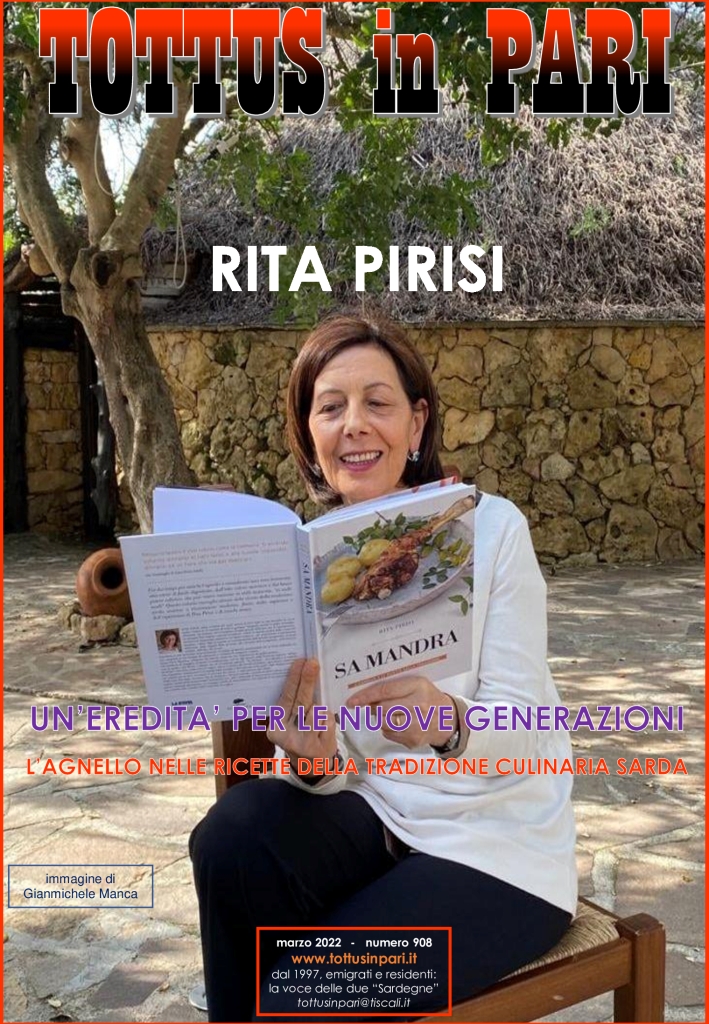
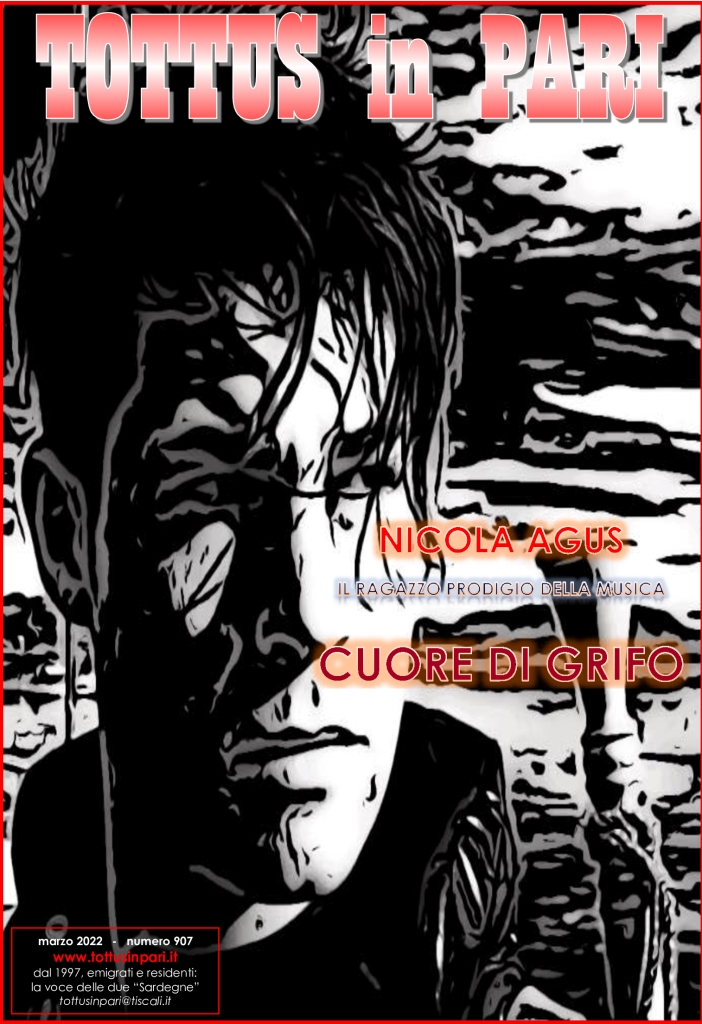
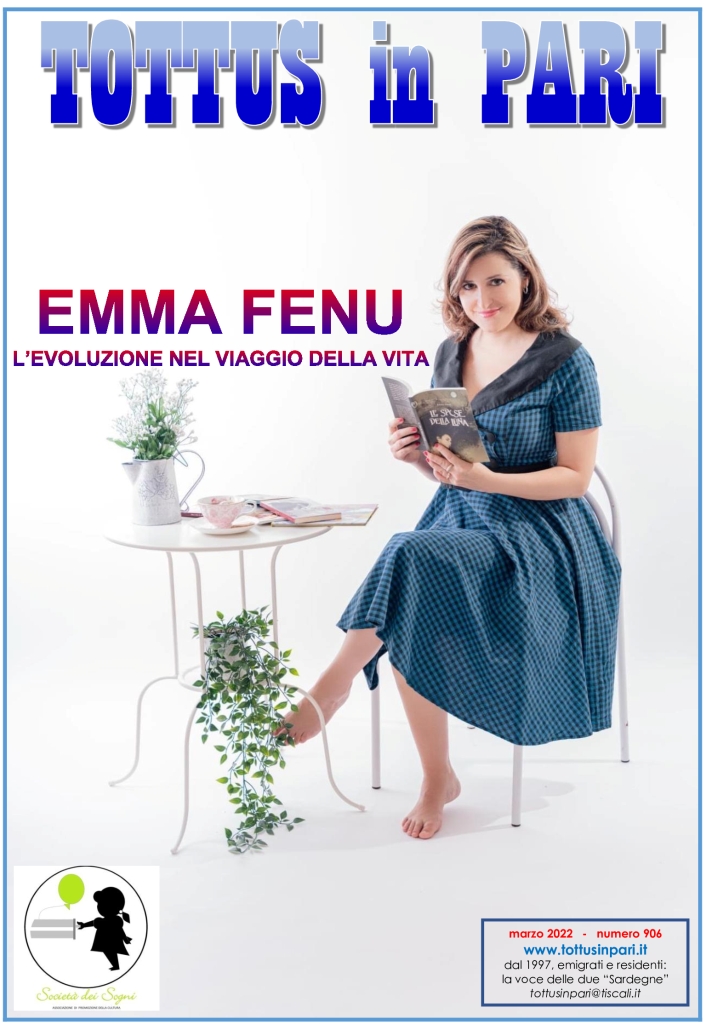


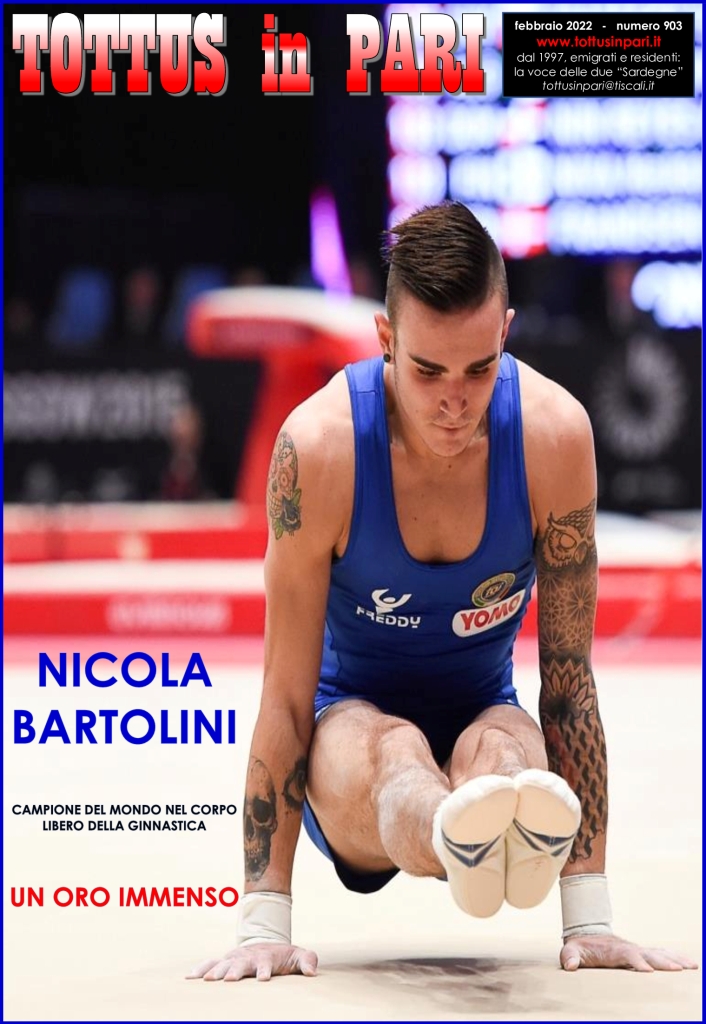


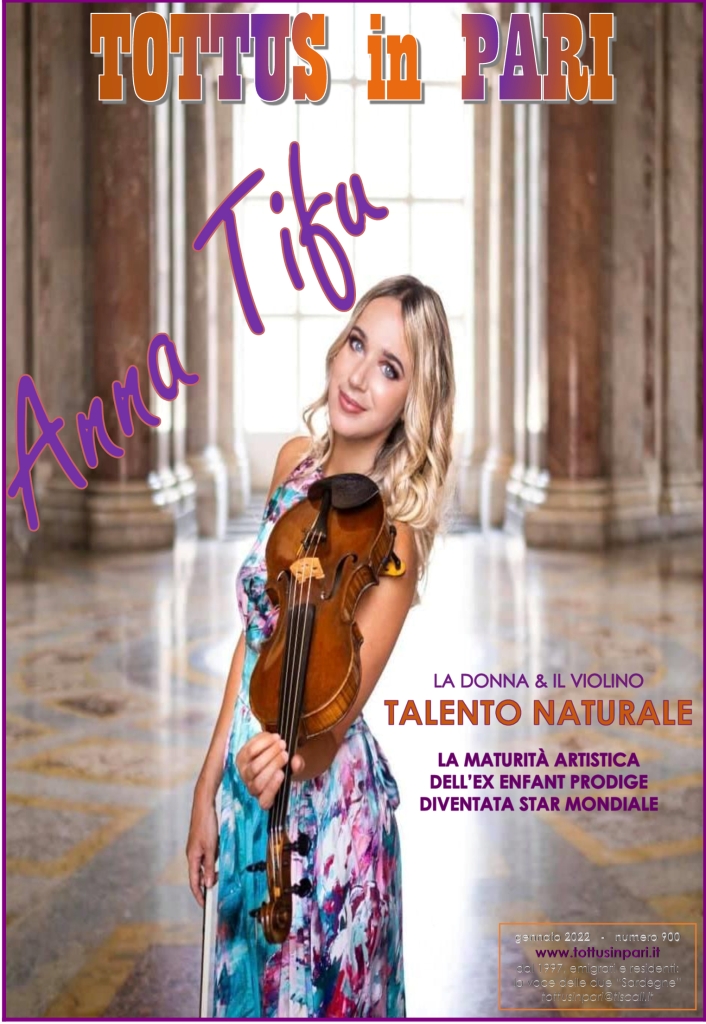

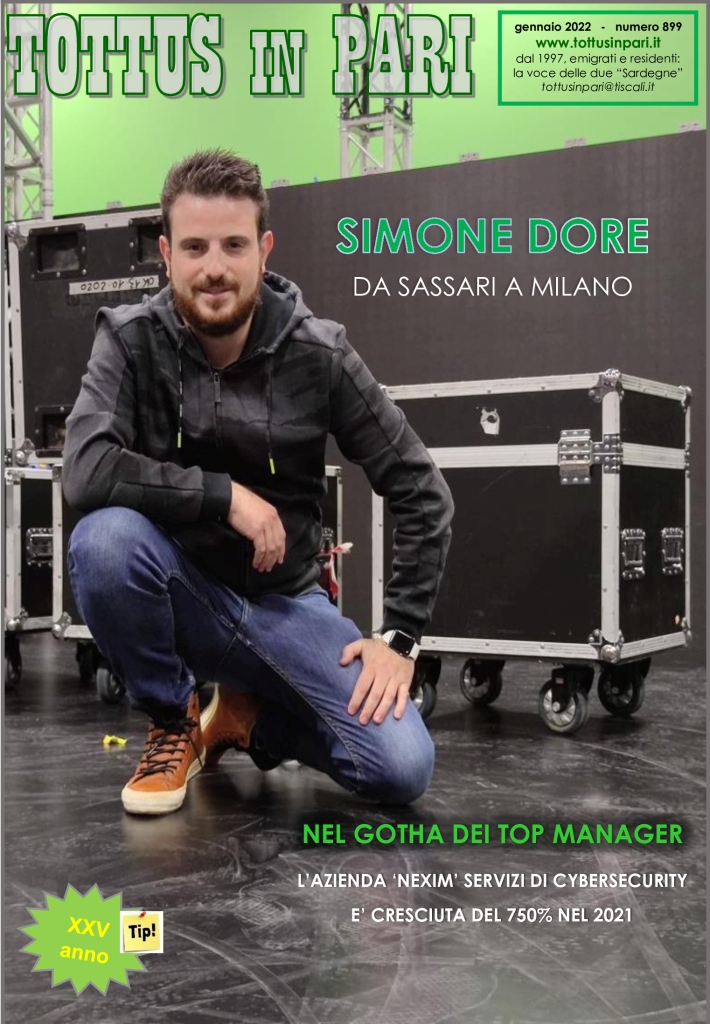
Un gran bell’articolo, ma meritano un "davvero" bravi, bravi i Tenores Sos Emigrantes., considerando anche,che provengono da diversi posti. Un piccolo appunto che mia moglie mi dice di far presente a Massimiliano è, che Andrea è come lei Demuru. Saludos a totus Pino.