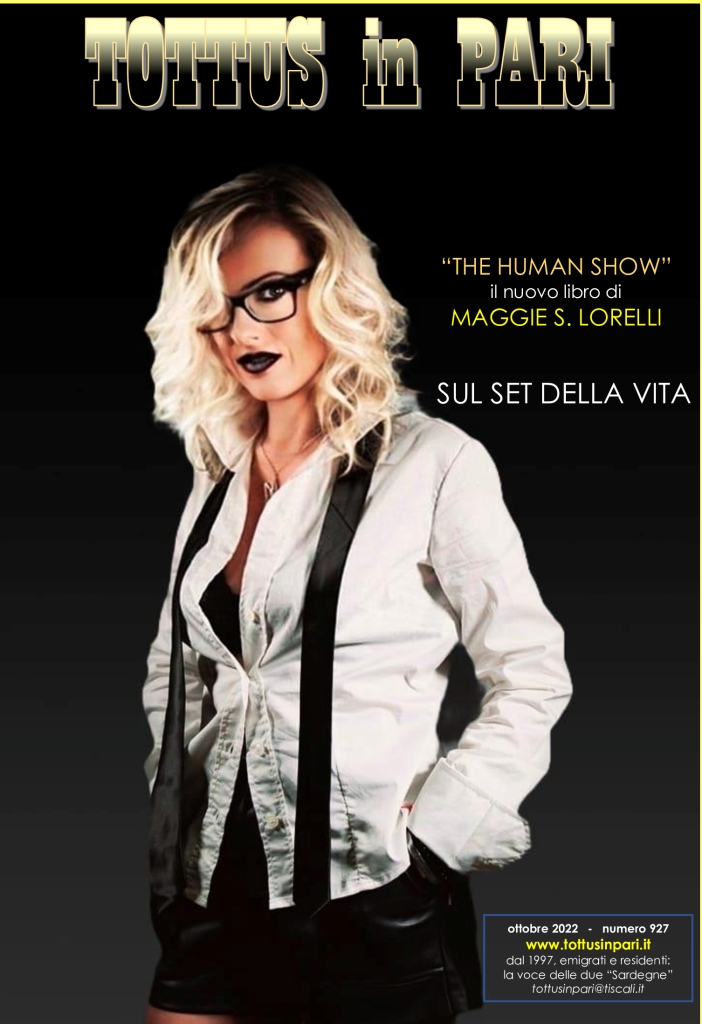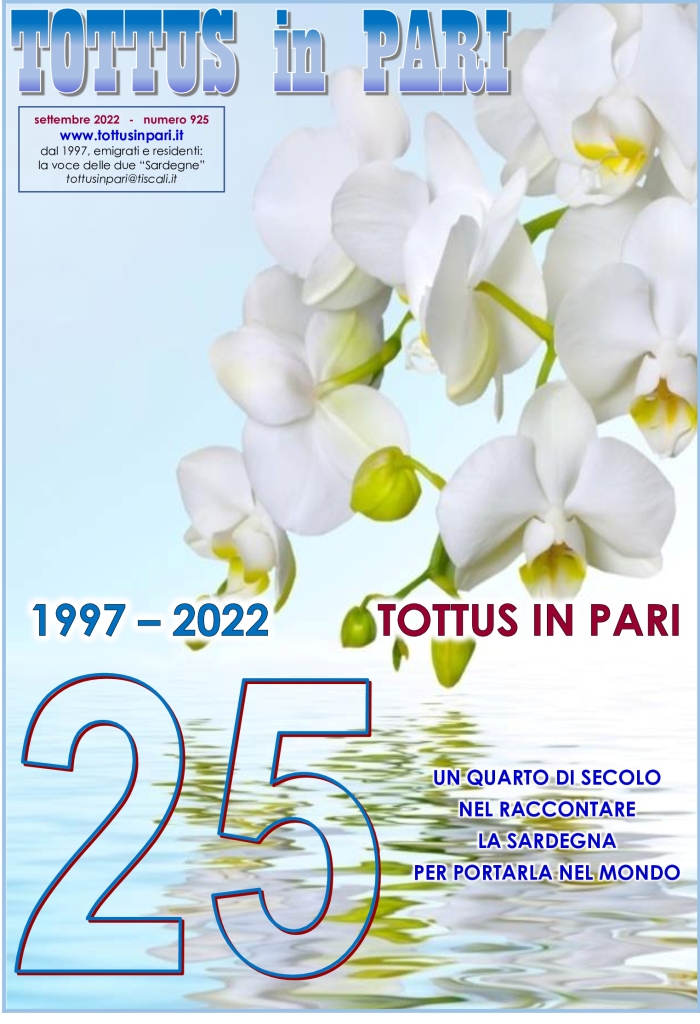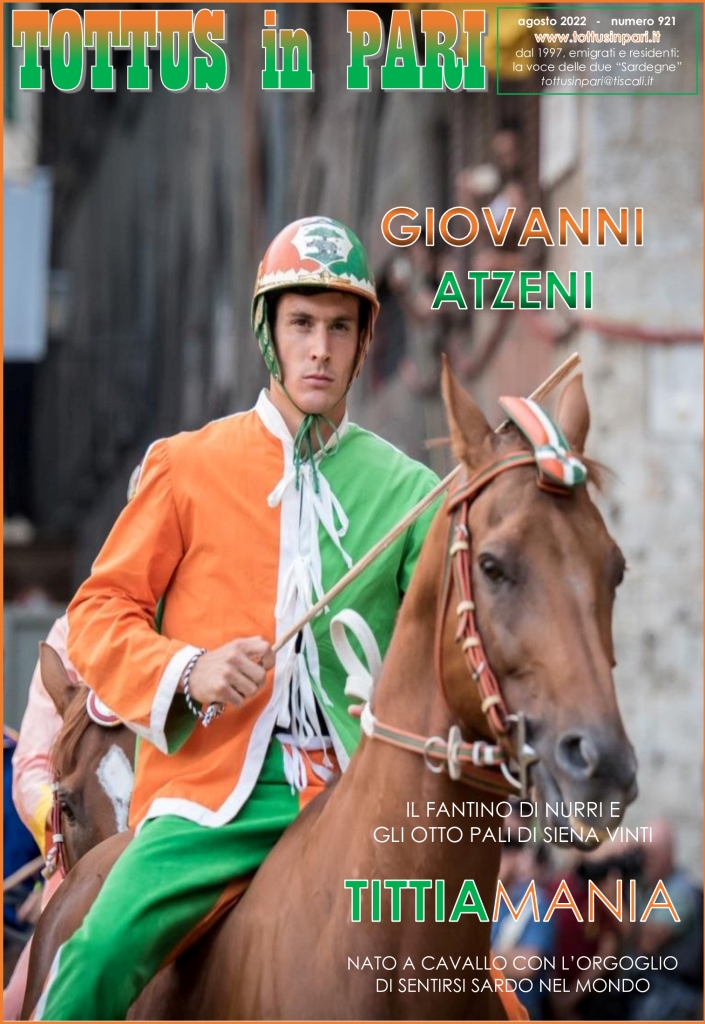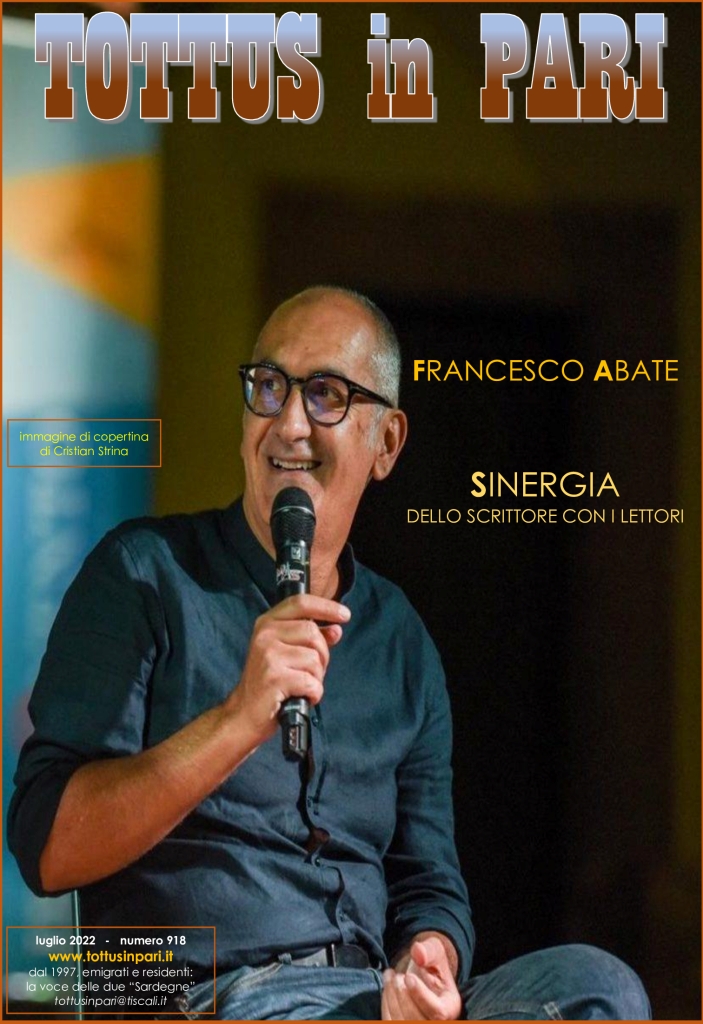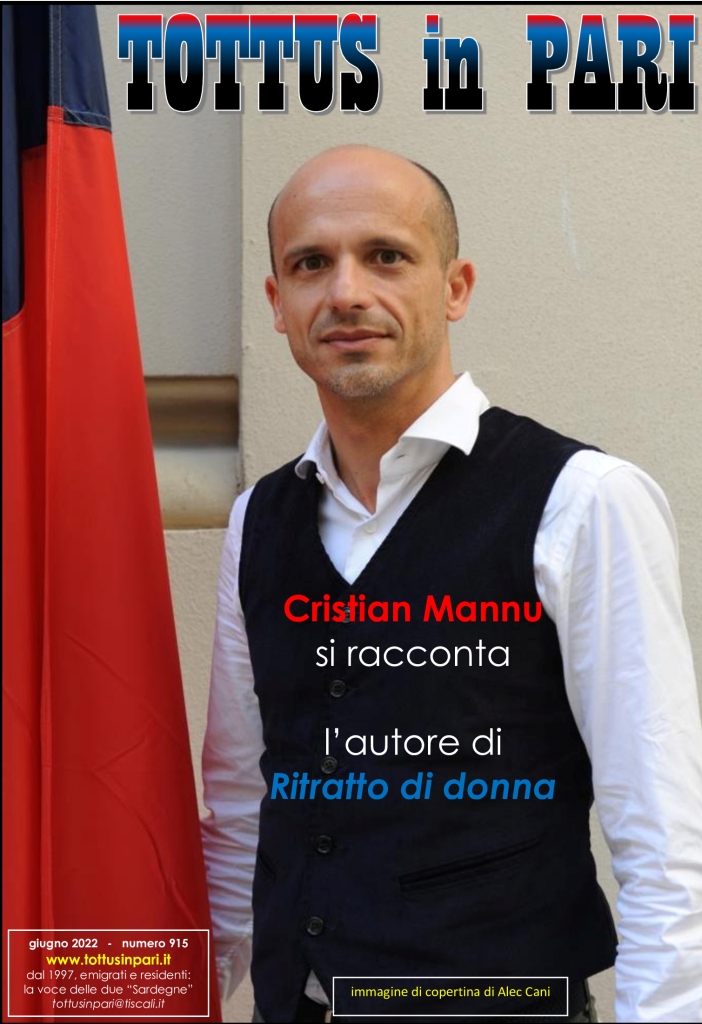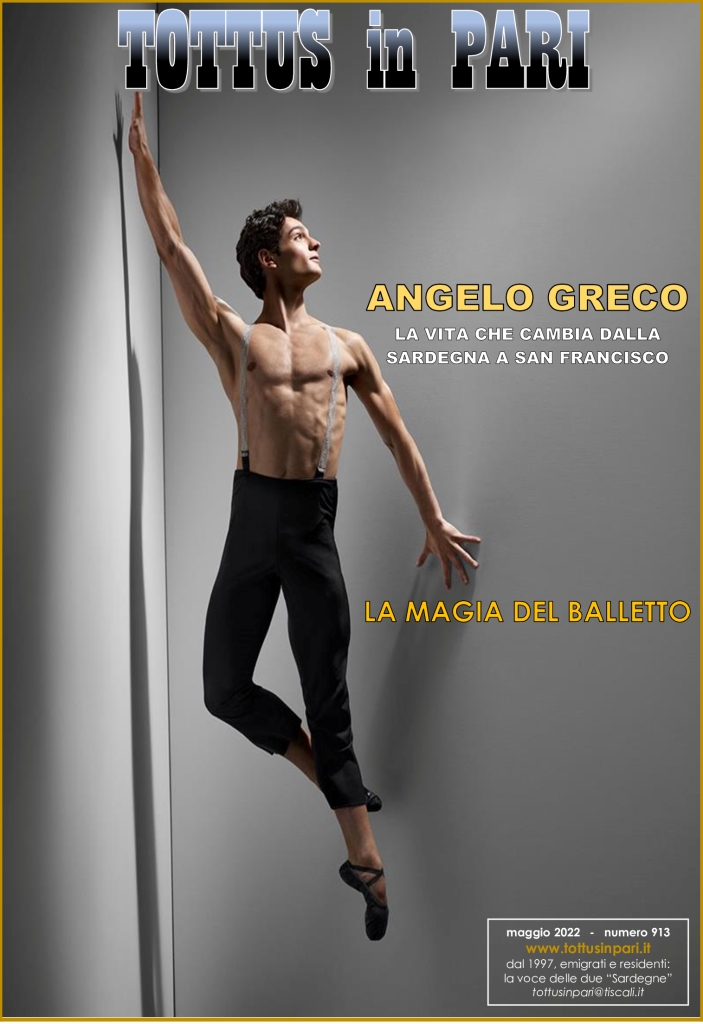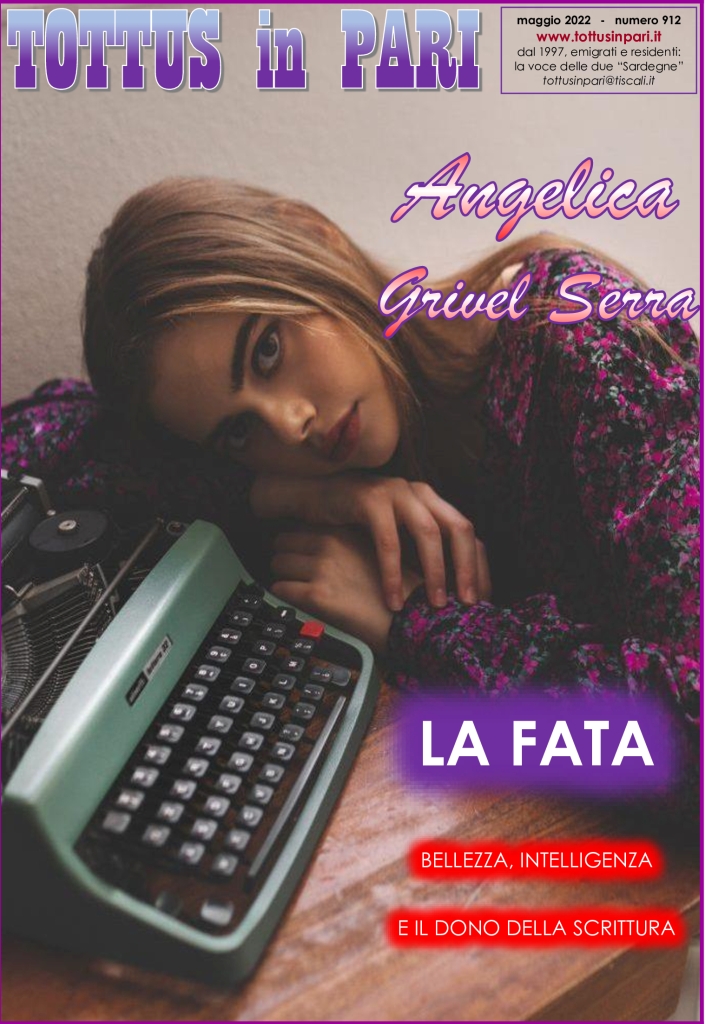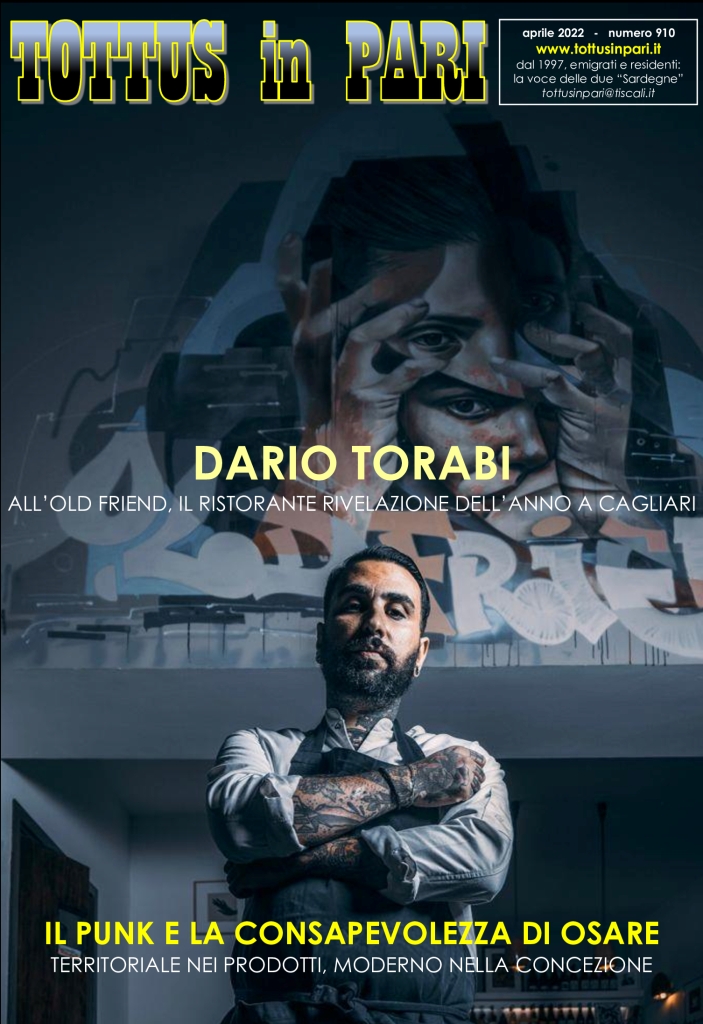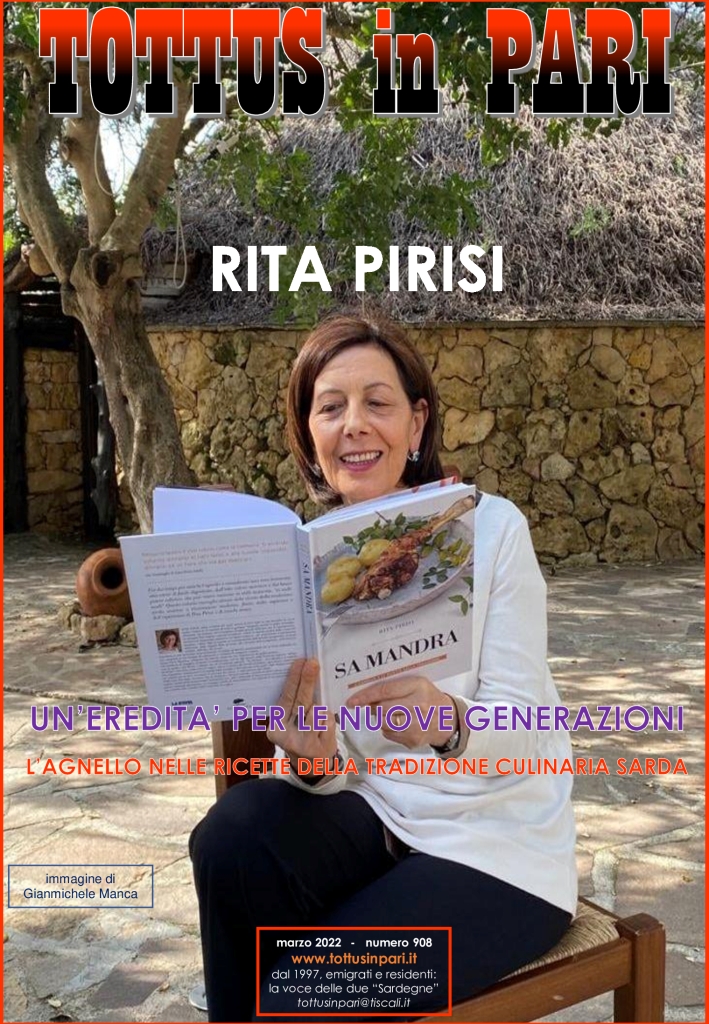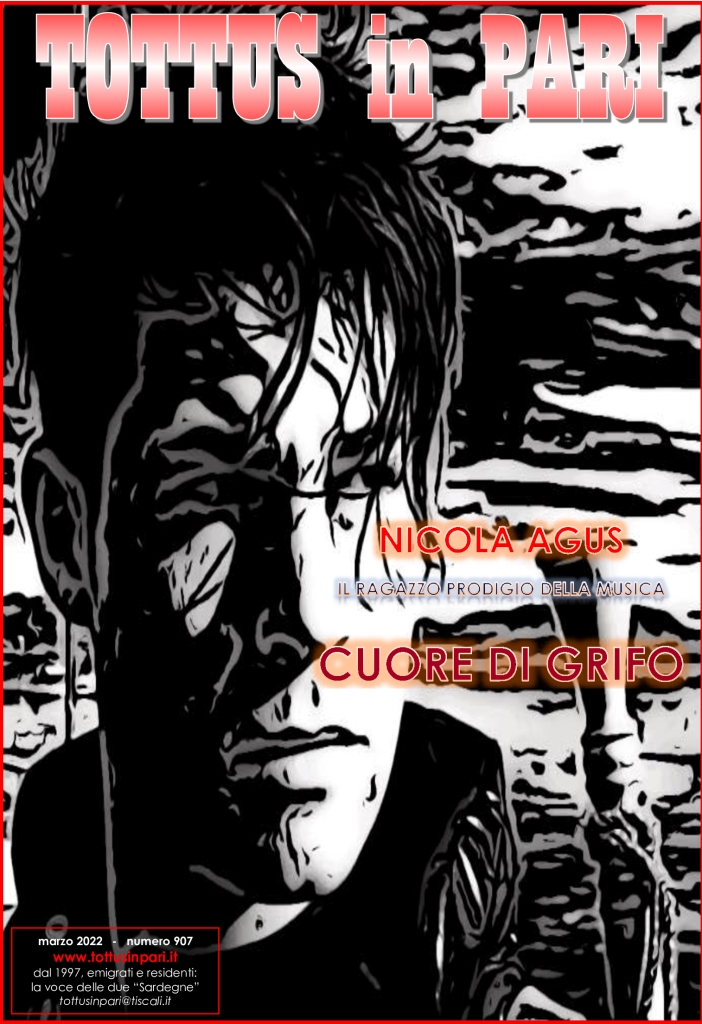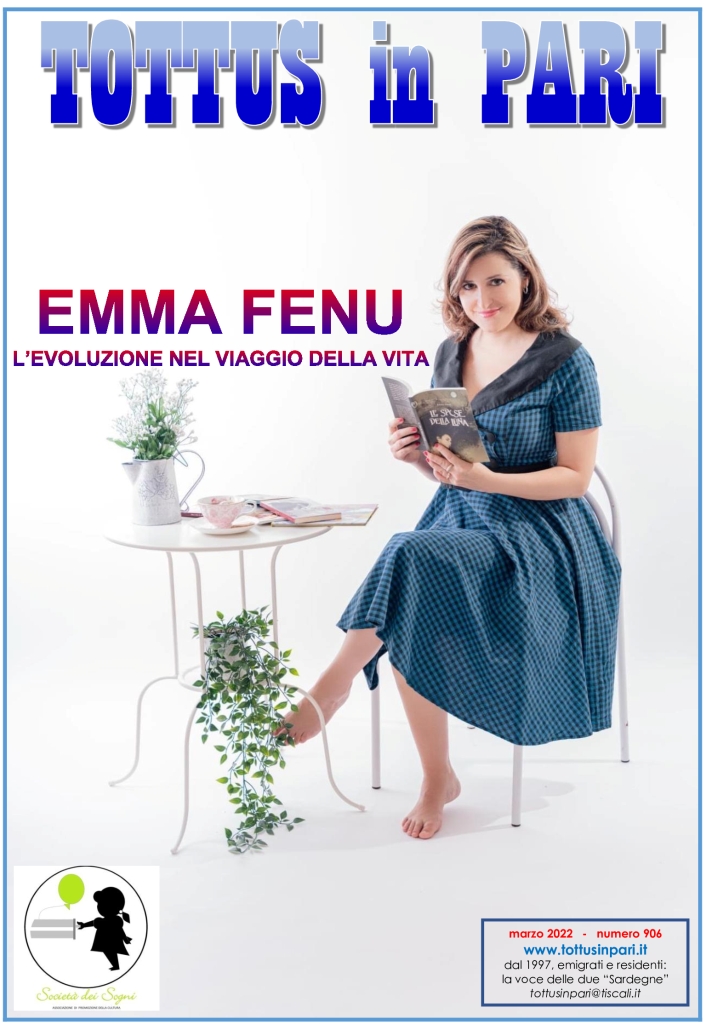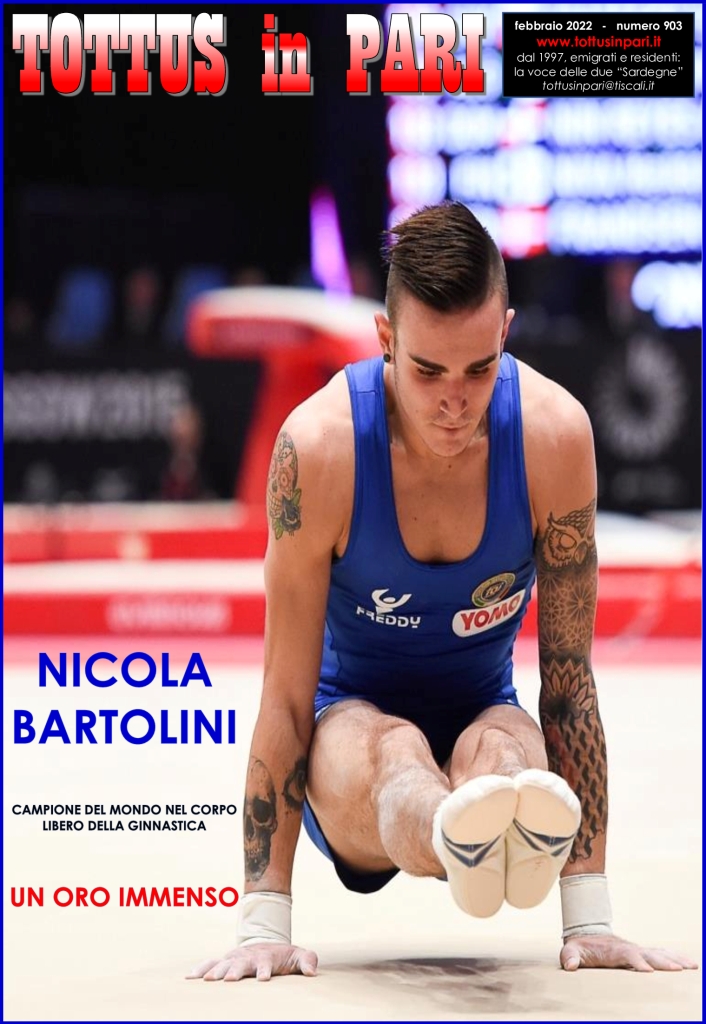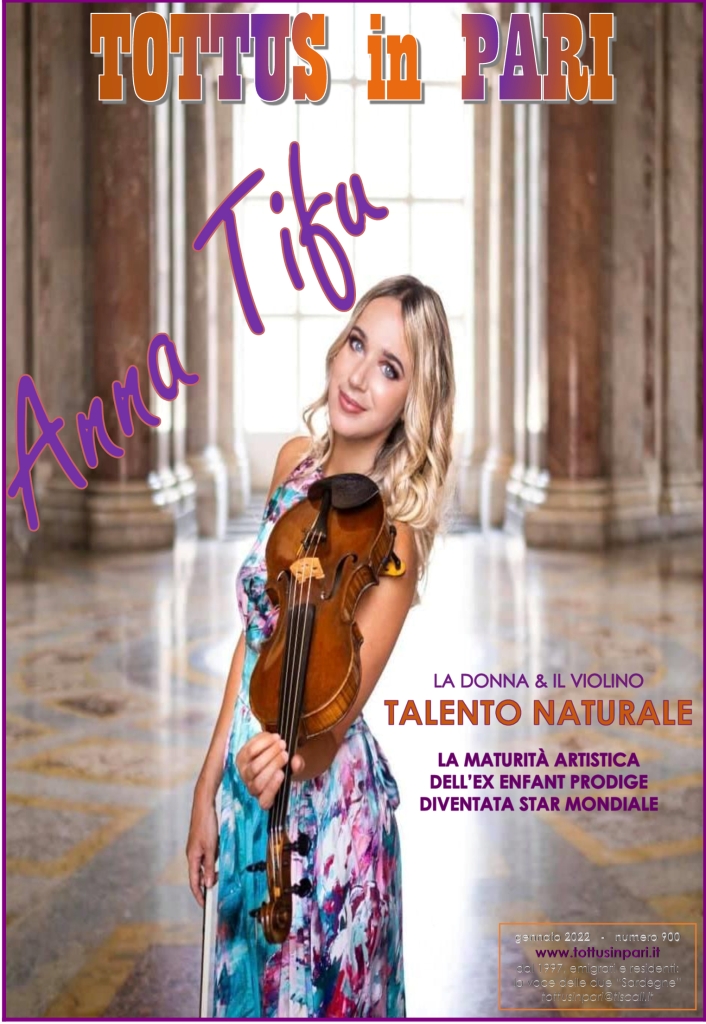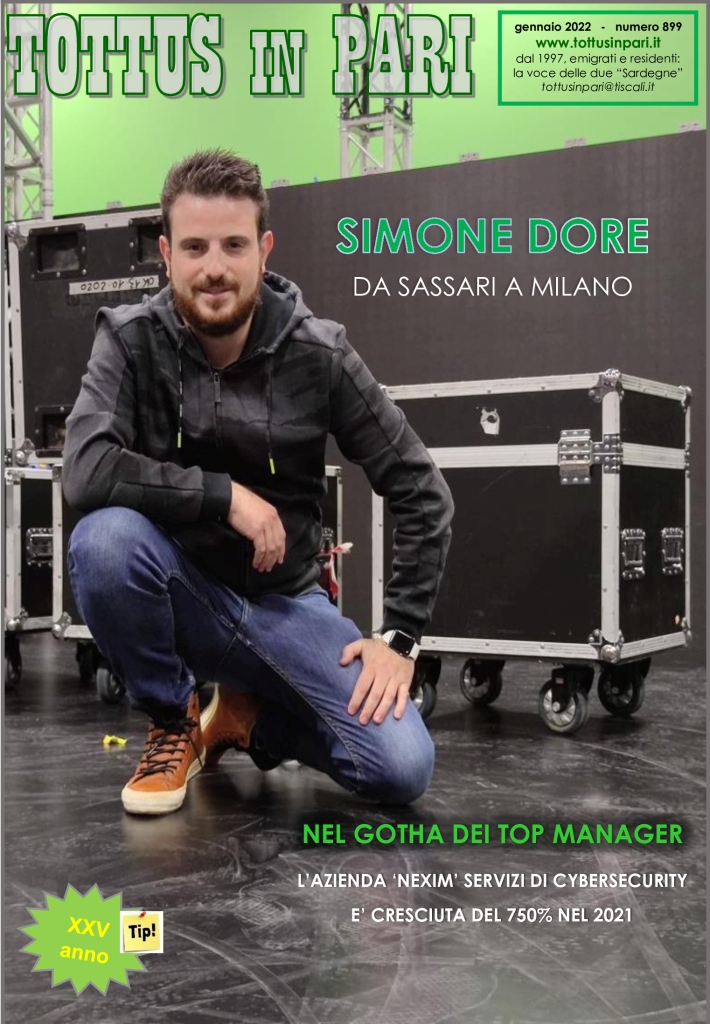di Giovanni Mameli *
Negli anni successivi alla sua scomparsa, avvenuta nell’isola di San Pietro nel 1995, su di lui si sono tenuti convegni e tavole rotonde in diverse località della nostra regione. In concomitanza con la pubblicazione di libri postumi (romanzi, raccolte di racconti e scritti giornalistici). O in occasioni di anniversari relativi alla sua biografia. Insomma su Sergio Atzeni ormai si è detto e scritto moltissimo, collocandolo in una posizione di assoluto rilievo nell’ambito della narrativa sarda del Novecento. Il primo convegno su questo scrittore fuori dall’Isola si è tenuto l’anno scorso a Pavia, presso la Biblioteca universitaria (Salone teresiano), con la partecipazione di diversi studiosi per lo più di estrazione accademica. Adesso sono stati pubblicati gli "Atti" contenenti le diverse relazioni, che possono essere letti anche da quanti non hanno seguito i lavori di questo importante seminario di studi. Il cui titolo suonava "Sergio Atzeni (1952-1995), un classico della nuova narrativa sarda". Chi in futuro si occuperà dell’autore dell’Apologo del giudice bandito e di Bellas mariposas, per citare soltanto due dei suoi titoli, non può fare a meno di scorrere attentamente questo volumetto, col marchio di sette sponsor che hanno finanziato il seminario in questione. Dopo le introduzioni di Gesuino Piga e Paolo Pulina (del circolo culturale "Logudoro" di Pavia), sono riportate le relazioni di Antonietta Dettori, Mauro Bignamini, Flavio Santi, Gianluca Bavagnoli e Giovanni Strinna (con in appendice una lezione di Nicola Tanda, basata su un approfondito esame delle opere di Sergio Atzeni, tenuta sempre all’Università di Pavia l’otto giugno del 1996). Quale immagine globale emerge di questo scrittore, dopo aver letto tutte le relazioni su aspetti specifici delle sue opere, pubblicate in vita o apparse postume? I punti fermi sono almeno tre: un approccio alla scrittura che simula l’oralità con risultati molto convincenti (si pensi in particolare a quel gioiello di sperimentazione linguistica che è Bellas mariposas ). L’affinamento del mestiere attraverso l’esercizio quotidiano della traduzione, svolta professionalmente dopo che Sergio Atzeni lasciò l’Isola e il suo lavoro precedente, che non lo appagava più sul piano intellettuale. Poi c’è il ruolo fondamentale di capofila di una generazione di scrittori sardi venuti dopo di lui, che in una misura maggiore o minore gli hanno riconosciuto questo ruolo di apripista e si sono riconosciuti nella necessità di mescolare lingua italiana e codici espressivi sardi (in particolare il campidanese). Sergio Atzeni fu senza alcun dubbio un innovatore, che aveva alle spalle un filone di narratori del passato ai quali, per sua stessa ammissione, doveva molto. Si pensi a un autore da lui amato come Salvatore Cambosu (in particolare per un libro importante come Miele amaro). Lo sperimentalismo di questo scrittore, prematuramente scomparso nell’estate del 1995, gli ha consentito di avere un largo successo di critica nell’Isola e nella penisola. Ma come spesso succede per chi innova, sul piano tematico e stilistico, il consenso del pubblico non è stato ampio. Sergio Atzeni è ancora un narratore di nicchia, ma ha un seguito di lettori forti che conoscono tutte le sue opere (una delle quali, Il figlio di Bakunìn, è stata portata sullo schermo dal regista Gianfranco Cabiddu).
Nella relazione di Giovanni Strinna (A boxi beccia, finzas tropu, Canti e rapsodia nella Cagliè di Sergio Atzeni) viene messo in risalto un elemento importante. Cioè, lo scrittore nelle sue pagine cerca spesso movenze musicali, tipiche della lingua cagliaritana e della poesia popolare cittadina. Non a caso apprezzava molto i Muttettus pubblicati da Raffa Garzia, di cui recensì la ristampa apparsa nel 1977. Questo perché secondo lui, in molte liriche, si trova la visione del mondo dei piani bassi della città.
In un’intervista rilasciata a Gigliola Sulis, a proposito del valore e della bellezza dei muttettus, Sergio Atzeni dichiarava: «Li farei studiare e cantare ai bambini delle elementari, in modo che, anche crescendo, non perdano del tutto la lingua, ma ne conservino almeno le autorità». Che Atzeni amasse la musica, dei generi antichi al jazz, è documentato in tutti i suoi romanzi. La considerava una fonte di emozioni, un tramite che lega l’uomo alla donna, ed entrambi inestricabilmente alla natura.
•· Unione Sarda