
di ALESSANDRA GUIGONI
Grazia Deledda amava cucinare per la propria famiglia, era una conoscitrice della cucina ed era una bongustaia; oggi sarebbe stata una foodie? In una lettera chiama la sua passione “il piacere della mestola”, dall’arnese di legno che si usa in cucina per rimescolare i cibi nelle casseruole.
Deledda era prolifica anche nello scrivere missive private e ci ha lasciato un epistolario formidabile; in un’altra lettera dichiara divertita che un messo dell’ambasciata di Svezia si recò nel suo appartamento di Roma e le comunicò, era novembre 1927, il conferimento del premio Nobel per la Letteratura, facendole un galante baciamano; la sua mano doveva odorare di cipolla, scrive Deledda, in quanto poco prima era in cucina e stava preparando il pranzo.
Indimenticabili, nelle epistole, anche i cenni delle merende a Cervia, località romagnola dove aveva una villetta, che erano a base di pane e lardo. E poi ancora Grazia fa cenni veloci ai pranzi a base di carne, tra cui osso buco e arrosto, tagli che acquistava da un certo Felicetti a Cervia. Era ghiotta anche di pesche ed altri frutti emiliano-romagnoli a tal punto da chiamare la regione “paese del Bengodi”. Nei romanzi ambientati in continente come Annalena Bilsini la scrittrice mostra di conoscere bene anche la cucina popolare della Penisola, come la polenta, che era più tipica dell’Appennino che della sua Barbagia.
Nata e vissuta sino a 30 anni a Nuoro, dopo il matrimonio con il continentale Palmiro Madesani era andata a Roma, dove aveva apprezzato la città, i suoi salotti letterari e la sua cucina. In una lettera indirizzata ai figli il giorno dopo aver vinto il premio Nobel cita espressamente Sora Nina, la vinaia romana che forniva casa, ironizzando sulla leggerezza delle bibite servite alla regale cena di gala svedese, rispetto ai vini a cui la coppia era piacevolmente abituata.
Sulla gastronomia sarda ha lasciato pagine memorabili, diamanti incastonati nelle pagine dei suoi racconti e dei suoi romanzi dimostrando una profonda conoscenza e una innata curiosità verso la manualità di alcune preparazioni, come certe paste e dolci e verso la ritualità di alcune pietanze. Come il castello di croccante (gattò), che veniva preparato come dono di nozze, era l’equivalente dell’odierna torta nuziale, che Grazia descrive in diverse opere, come ne La via del male: “Era la vigilia delle nozze di Maria. La facciata e le stanze della casetta erano state imbiancate e messe a nuovo. Nel focolare e sui fornelli le caffettiere grillavano, nelle stanze superiori della casa spandevasi un forte profumo di dolci e di liquori; sui tavolini, sui letti, sulle sedie, su tutti i mobili stavano grandi vassoi contenenti torte dai vivi colori e gattòs, specie di piccole costruzioni moresche di mandorle e miele. Nel cortile e nelle stanze terrene era un continuo viavai di gente; ogni momento il portone s’apriva per lasciar entrare donne in costume che recavano sul capo torte e gattòs”.
Lo sguardo di Deledda si appunta su tantissimi cibi sardi, difficile darne conto ma un’altra descrizione memorabile riguarda s’aranzada, dolce delicato e raffinato, composto da scorza di arancia candita, scagliette o mandorle intere, secondo il paese, nonpariglia colorata. L’origine del dolce risale al Trecento italiano. Troviamo infatti una ricetta molto simile in un codice anonimo veneziano.
Nel romanzo Cenere troviamo un cenno di ingredienti e preparazione. È la prima volta nella storia della gastronomia sarda che viene citato per iscritto questo dolce: “Rientrato a casa Anania riferì ogni cosa a zia Tatàna, mentre la donna, seduta davanti a un braciere, preparava un dolce di scorze d’arancio, mandorle e miele da portare in regalo ad un importante personaggio cagliaritano”. Anche in questo caso si tratta di una preparazione laboriosa e con ingredienti di pregio, che costituiva perciò un cibo solo festivo e/o un prezioso dono.
Deledda è visibilmente affascinata da quella che viene definita la “pasta più rara del mondo” su filindeu, spaghetti sottilissimi “filati” a mano, stesi su tre strati sovrapposti, fatti essiccare al sole, poi usati spezzati in una minestra a base di brodo di pecora e formaggio pecorino. Già su filindeu cita nella sua opera etnografica, le Tradizioni popolari di Nuoro, soffermandosi anche sull’occasione e modalità di consumo: “Le feste più caratteristiche di Nuoro sono senza dubbio quelle schiettamente popolari come Valverde, Itria, San Sebastiano, Sant’Agata, eccetera […] Tutto il grano accumulato vien ridotto in pane ed in minestra, una specie di minestra detta “filindeu”. È una minestra tutta particolare a queste feste; pare un grosso velo e il suo nome forse significa “filo di Dio”. Il giorno della festa, in locali appositi, tutte le famiglie accorse ascoltano la messa e poi preparano il pranzo e mangiano in comune. Ricchi pastori offrono per voto intere vacche. Il pranzo consiste in carne e nel “filindeu”, che viene condito con formaggio fresco e che riesce una minestra densissima e squisita. Tutte le vivande vengono benedette. Il “filindeu” lo si ritiene quasi miracoloso e viene recato agli ammalati”.
Il filindeu, allora come oggi, veniva offerto in occasione del pellegrinaggio alla chiesa campestre di San Francesco di Lula (NU). “Nessuno” prosegue la scrittrice “può esimersi dall’assaggiarli perché si dice che altrimenti San Francesco si offenda”. A rinforzare la tesi del piatto magico racconta del precipizio chiamato “il fosso della sposa”, poiché, secondo una leggenda, una sposa nuorese recatasi alla festa di San Francesco di Lula non solo non volle mangiare del filindeu benedetto “ma lo derise come una cosa schifosa, perciò al ritorno precipitò da cavallo e cadde nel dirupo che poi prese il suo nome”.
La pasta l’aveva stregata. Ad esempio nel romanzo La fuga in Egitto descrive tutta la sequenza della preparazione dei caratteristici gnocchi rigati a forma di conchiglia che nella penisola chiamano gnocchetti sardi e nel sud Sardegna si dicono “malloreddus”: “Tagliò una fetta della pasta e arrotolandola e tirandola la ridusse a una lunga biscia bianca che il coltello si affrettò a tagliare in piccoli pezzi come si trattasse davvero di una bestia pericolosa. Poi i piccoli pezzi scavati con l’indice come lunghe conchiglie formarono gli gnocchi: il loro esercito ben schierato sull’asse e ricoperto dalla tenda di una salvietta”.
Deledda è stata pioniera anche nel rimando e descrizione di molti cibi. I letterati coevi, poco pratici di cucina, cosa da donne, citano meno e con meno perizia e particolari i piatti sardi. Deledda invece, pratica di cucina, si “sporca le mani” e ci lascia un piccolo tesoro: i primi riferimenti scritti nella storia della gastronomia sarda di tante preparazioni tipiche, ancor oggi tradizionali.
Come le celebri seadas, che Deledda descrive come “piccole schiacciate di pasta e formaggio fresco passato al fuoco. Vengono fritte” “o le casadinas (schiacciate di pasta), che corrispondono alle pardulas del sud Sardegna, “dentellate, con gli orli rivoltati e contenenti del formaggio fresco impastato con sale e zafferano” o ancora le cattas, che corrispondono alle zeppole del carnevale, che tratteggia come “Originalissime […] degne di qualsiasi mensa signorile. Si fanno con la pasta lievitata, di fiore di farina. Ben gramolate, impastate con uova, con due o tre patate ben pestate, con un po’ di anice in minima quantità, e il tutto rammollito con del latte. Si depone la pasta così fatta in un recipiente ben coperto, accanto al fuoco, e si lascia fermentare per qualche ora. Occorrono due persone per friggere queste frittelle. Una le dispone, plasmandole con le mani in varie forme, l’altra deve badare che non si abbrucino, sull’olio bollente, rivoltandole ed estraendole con uno spiedo sottile. Vengono servite calde, o semplici o infarinate di zucchero o spalmate di miele caldo”. Solo nel Secondo Dopoguerra inizieranno ad essere pubblicate le prime ricette sarde scritte e dovremo arrivare agli anni ’70 del XX secolo per vedere finalmente i primi libri di ricette, che consegnano alla scrittura un patrimonio enorme ma sino a quel momento prettamente orale.
Intanto Grassiedda, come veniva chiamata affettuosamente in famiglia, che sin da ragazza apparecchiava e preparava il caffè, altra sua passione, aveva già scritto alcune pagine immortali sulla gastronomia, oltre che aver vinto il Nobel per la letteratura, a tutt’oggi unica scrittrice italiana, a distanza di quasi 100 anni.











































































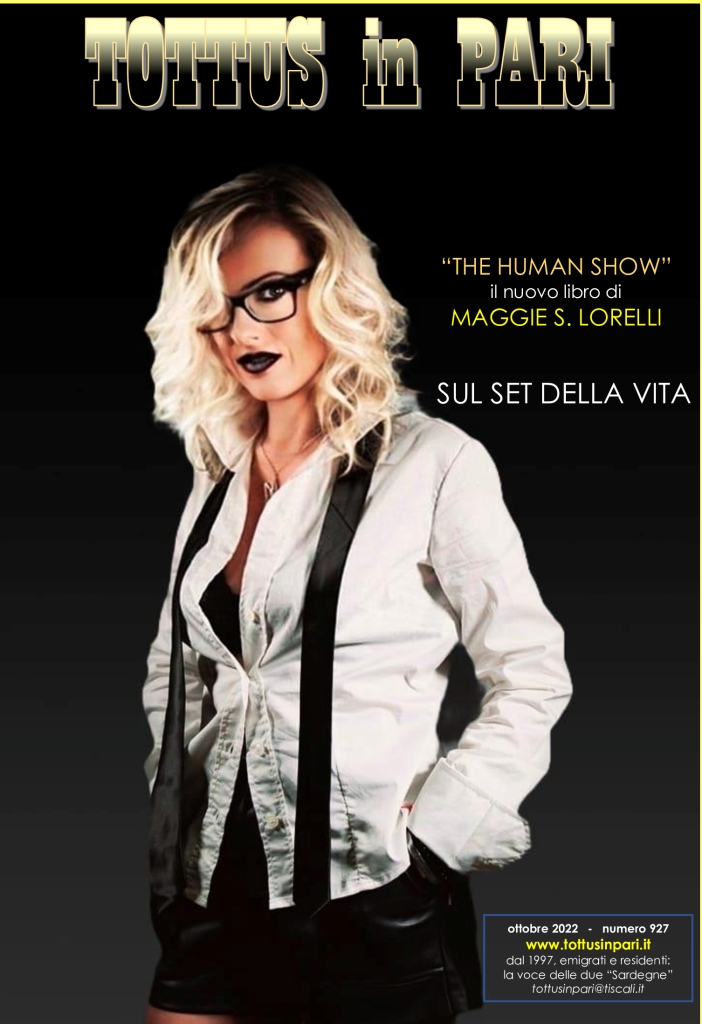

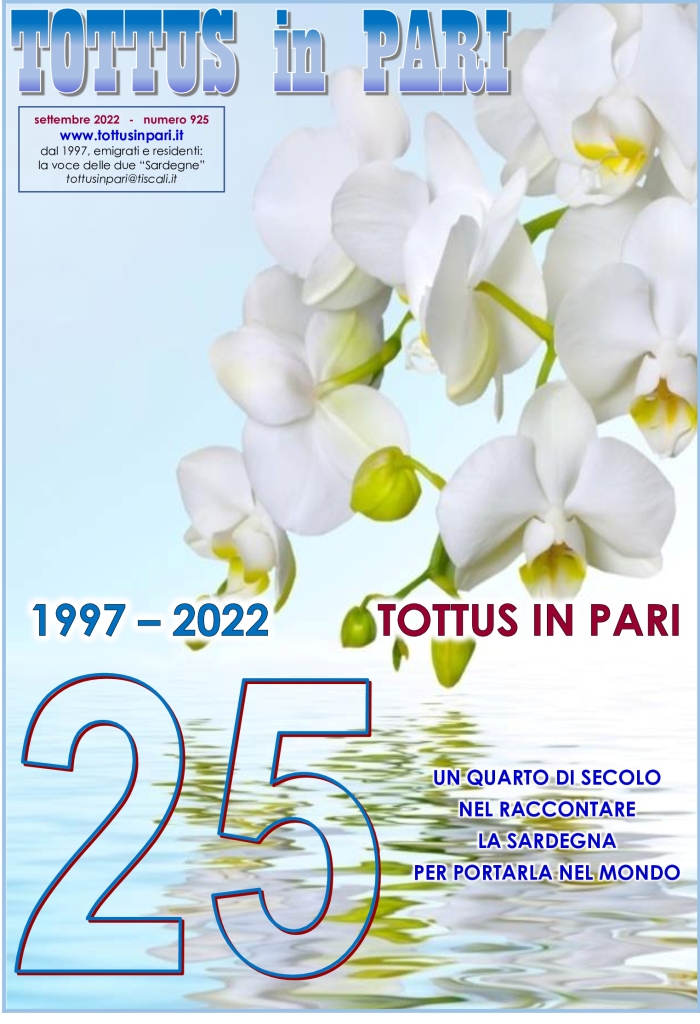



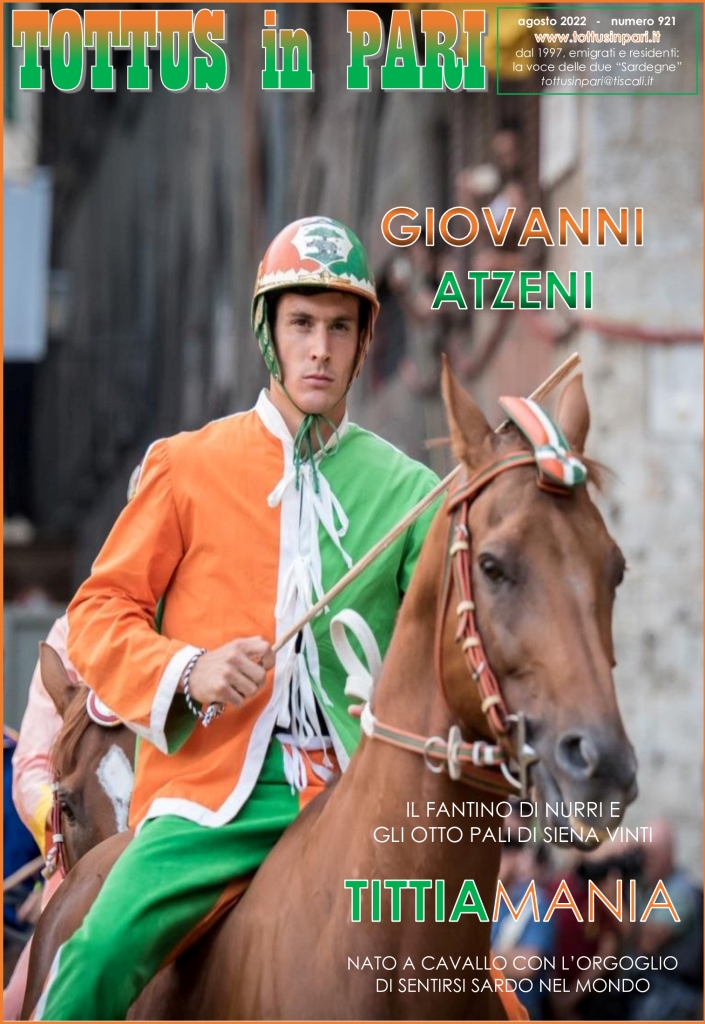


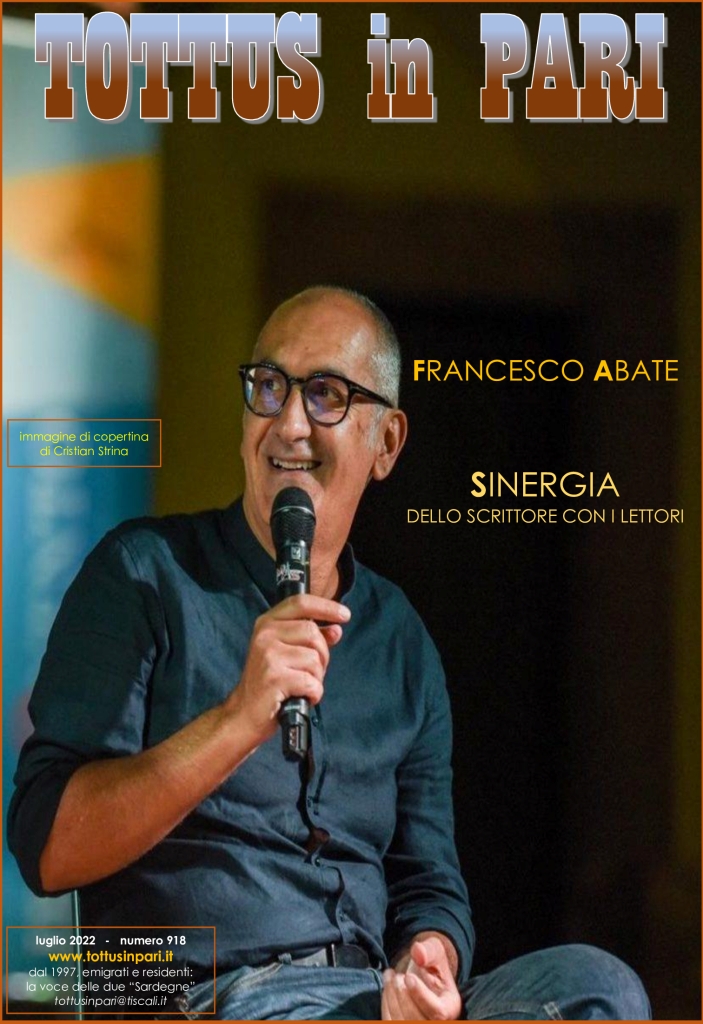


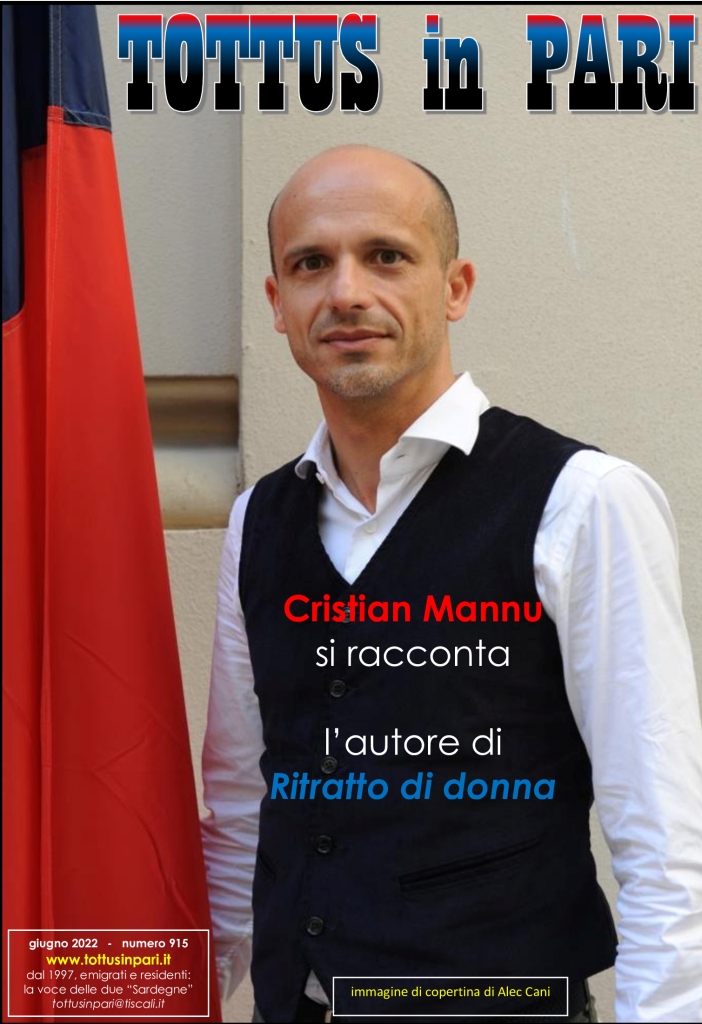

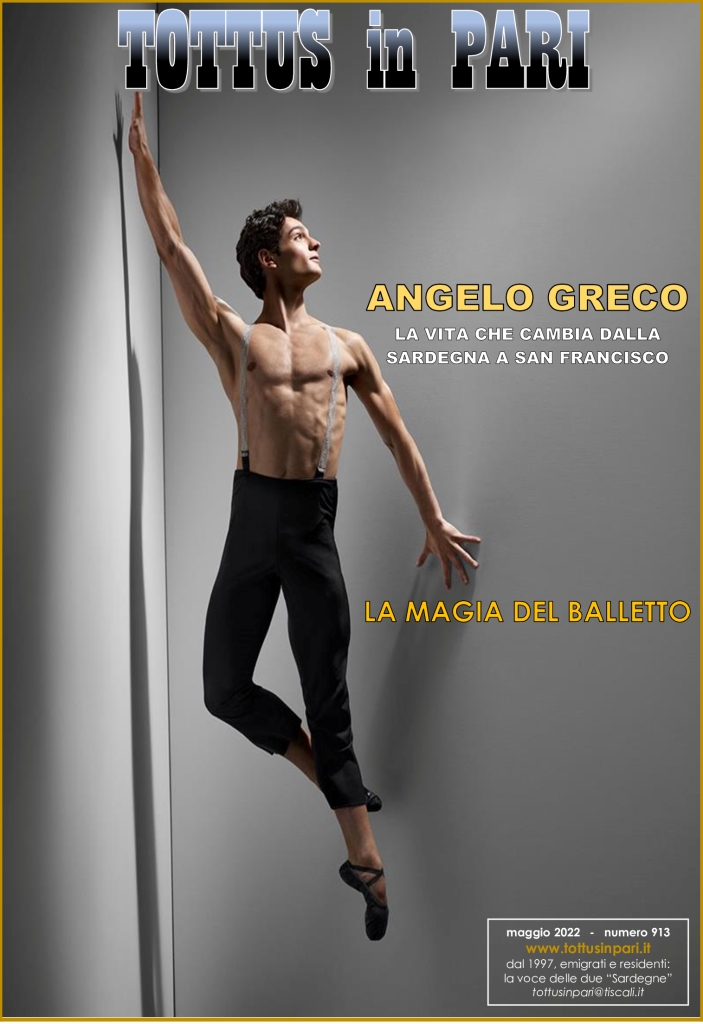
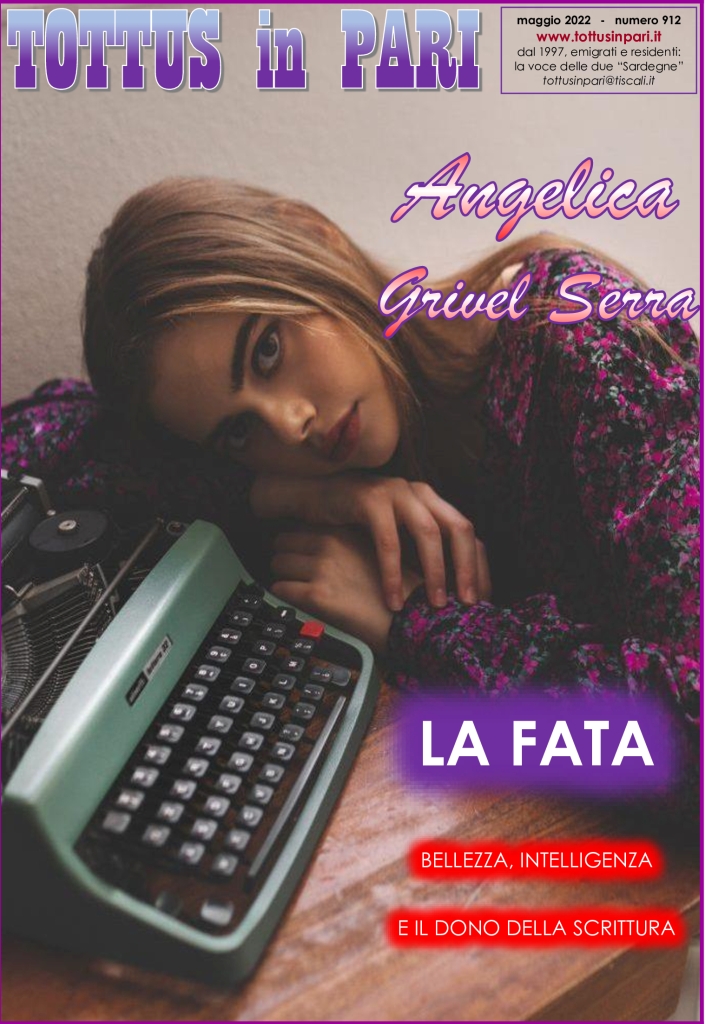

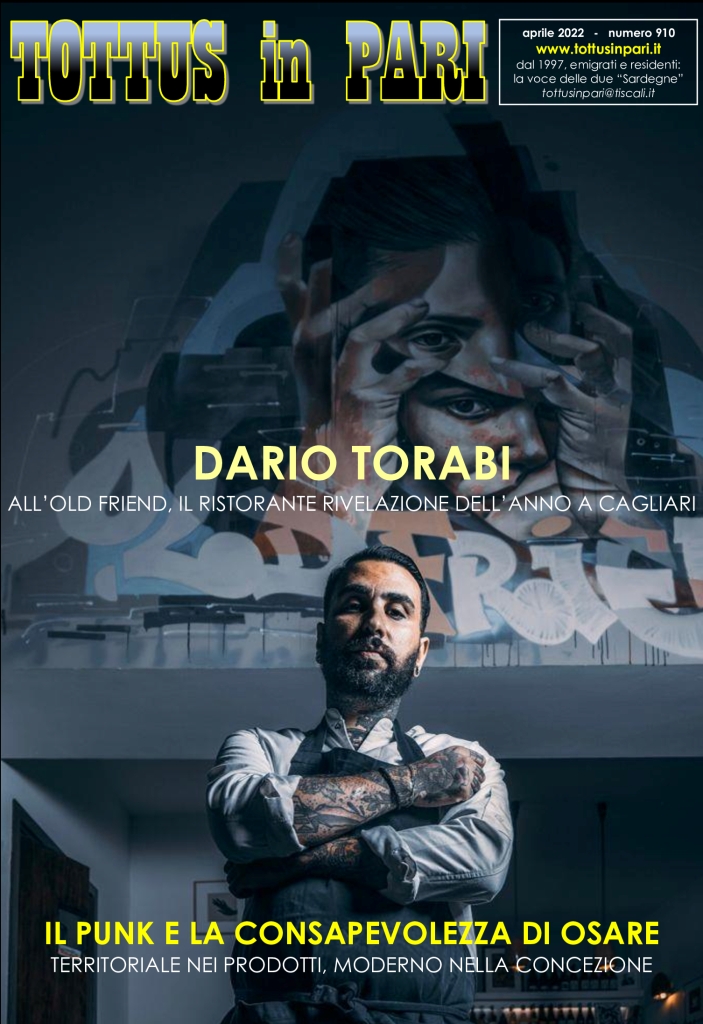

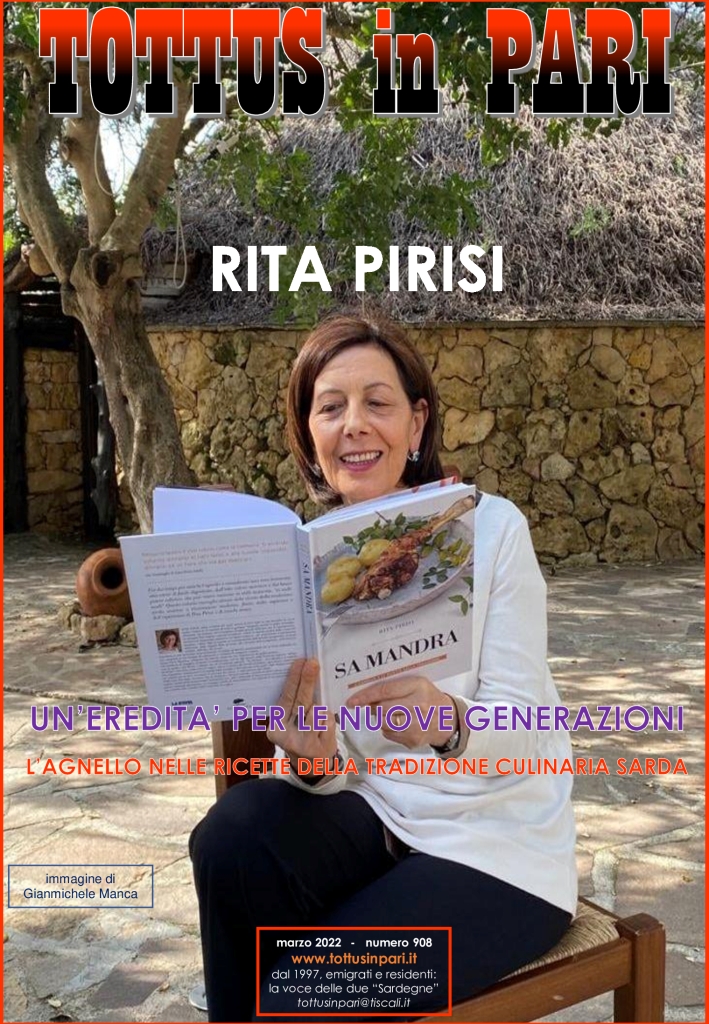
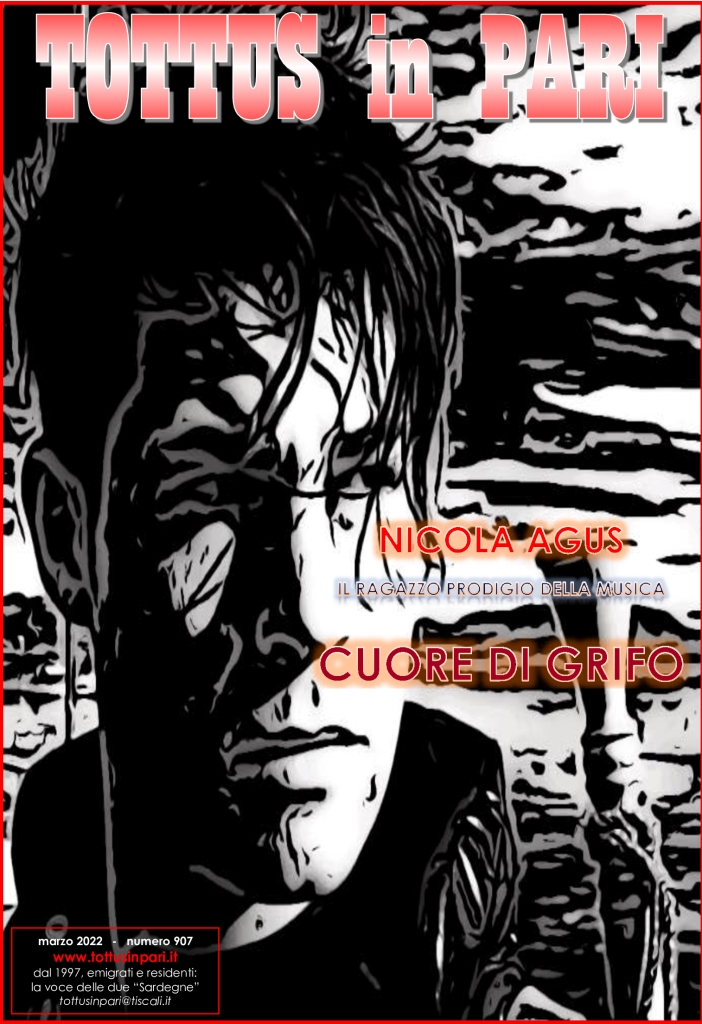
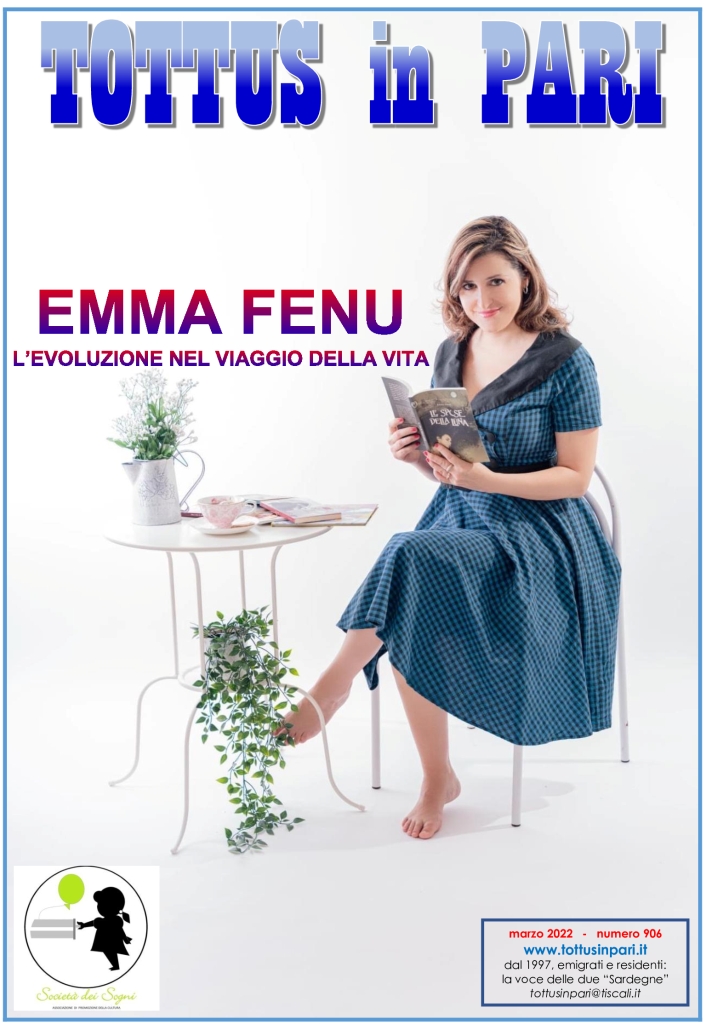


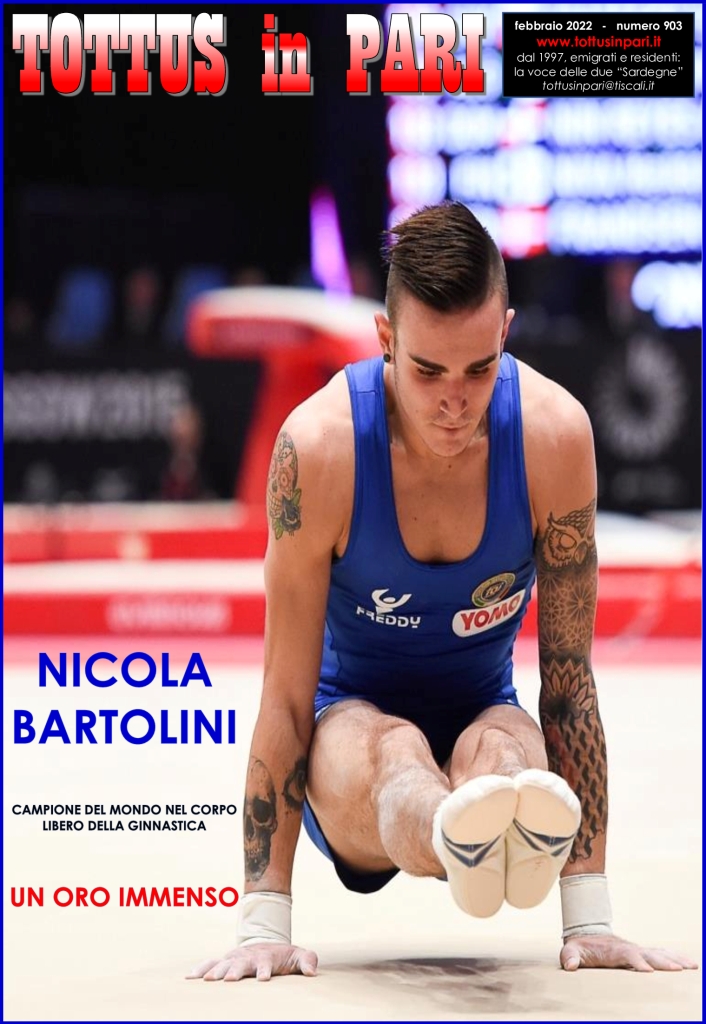


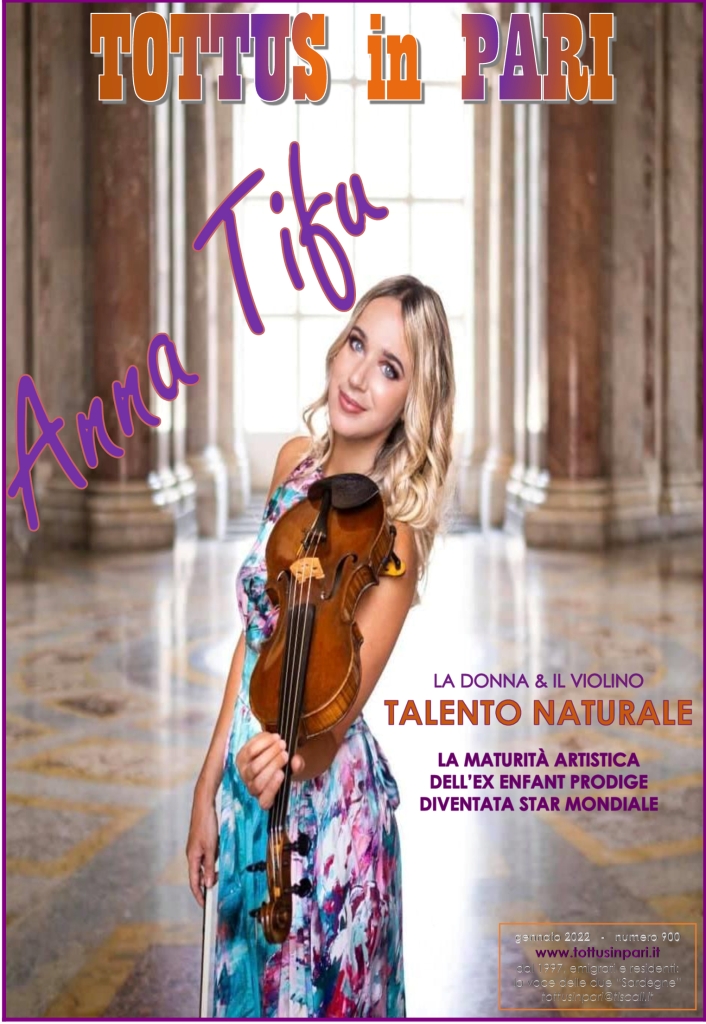

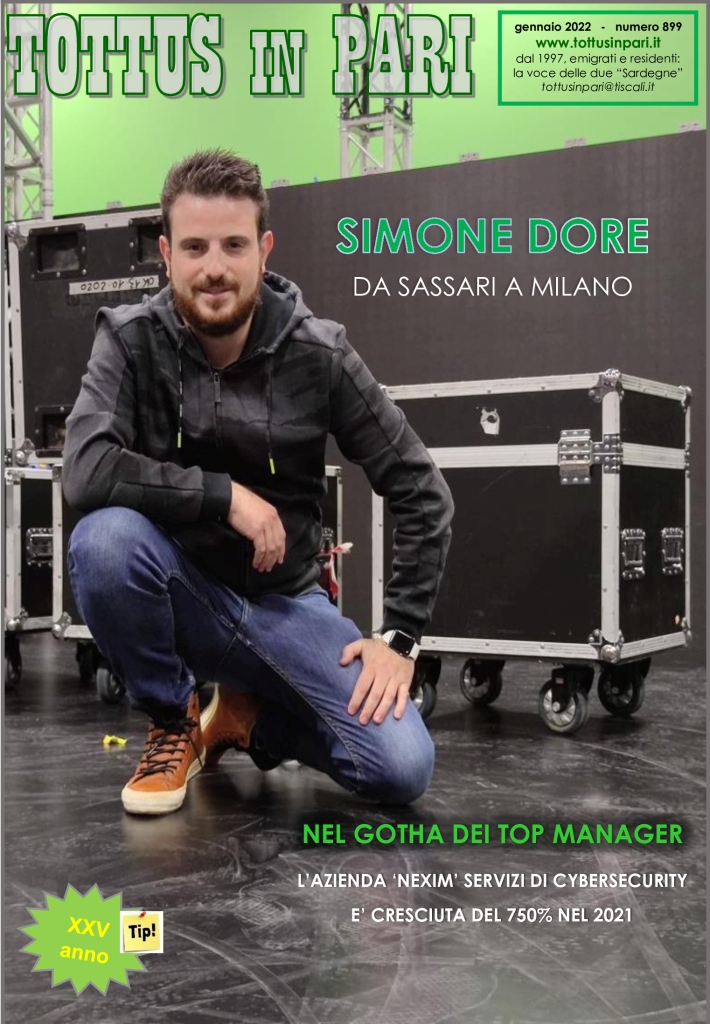
Bell’articolo. Grazie
Grandissima Grazia Deledda !!