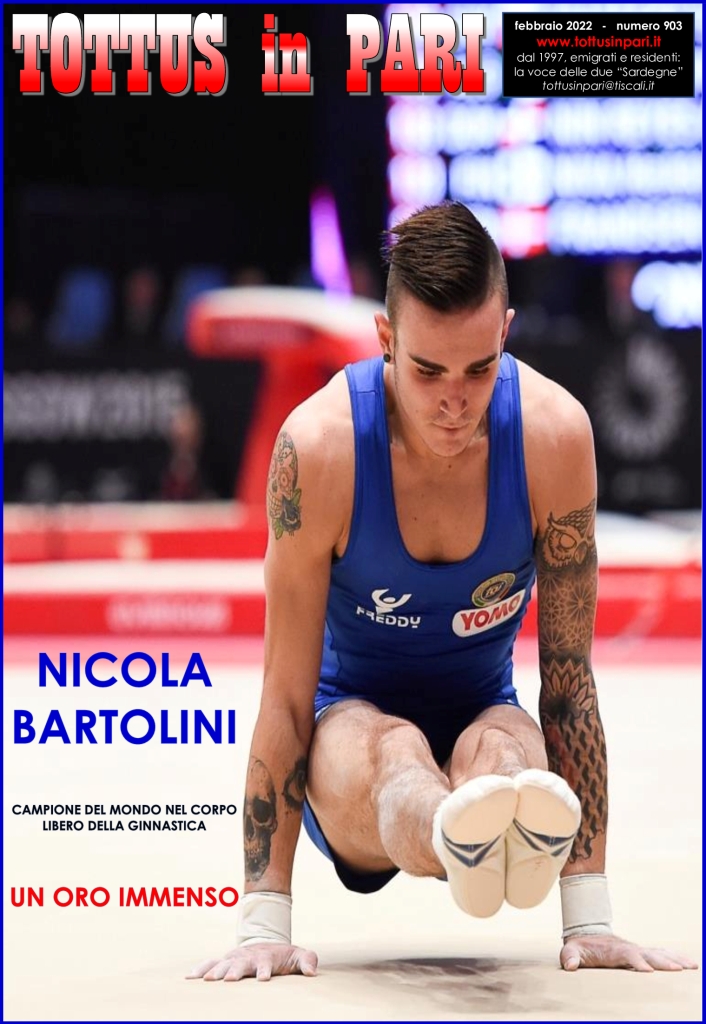di Giuseppe Sanna
L’emigrazione sarda si colloca, all’interno della più generica e mai risolta "questione meridionale", nonostante le sue caratteristiche strutturali si discostino da quelle del fenomeno migratorio comune nelle altre regioni del Mezzogiorno. Il ritardo con il quale il suo processo ha avuto inizio rispetto al resto del sud, ha determinato infatti particolari modalità di sviluppo. Inoltre l’aumento graduale del flusso migratorio, che ha raggiunto i massimi valori negli anni precedenti il primo conflitto mondiale, assume importante rilievo trattandosi della regione con la più bassa densità demografica. Queste dinamiche, apparentemente paradossali, confutano i ben noti schemi interpretativi che legano l’emigrazione ad un eccessivo carico demografico e le assegnano una presunta funzione equilibratrice tra popolazione e territorio. Per quanto concerne l’analisi più specifica dei flussi e della loro entità, gli storici concordano nel far risalire le prime consistenti ondate migratorie agli ultimi anni dell’Ottocento. Il Crespi afferma al proposito che l’emigrazione abbia rappresentato per l’isola "un fenomeno di scarso rilievo sino all’ultimo decennio dell’Ottocento". Prima di questa data, la media annua degli espatri non raggiunge le 100 unità, mentre nei 5 anni successivi si registra un incremento che nel 1899 arriva a 1.110 unità. Nel venticinquennio fra il 1876 e il 1900 il totale degli emigrati sardi viene calcolato in 8.132 unità (con una media di 325 emigrati l’anno). Nei primi anni del Novecento si continua con un andamento ascendente (tra il 1901 e il 1915 gli espatri dall’isola raggiungono le 89.624 unità), fino ad arrivare nel 1913 a 3.988 emigrati verso l’Europa, 7.130 verso l’America e 1.147 verso Africa. Le terribili annate di siccità che colpiscono l’isola negli anni 1912-1914 e l’afta epizootica (cui fece seguito una forte moria di bestiame) accelerano un processo già in atto. Durante il primo conflitto si registra una sensibile diminuzione degli espatri, che riprendono, anche se in minore misura, nel periodo postbellico. Negli anni Trenta la grave crisi economica, l’attuazione di leggi limitative (come quelle che negli USA istituirono le "quote" di immigrati) e la politica di contenimento attuata dal regime fascista in Italia ostacolano la ripresa del flusso migratorio, che subisce un successivo arresto negli anni del secondo conflitto mondiale. Il periodo immediatamente successivo alla guerra registra un nuovo incremento delle partenze, che porta in breve tempo all’esplosione della cosiddetta "nuova" emigrazione negli anni Cinquanta. Merler parla, rispetto alla prima fase, di un’emigrazione di modesta consistenza, non solo se paragonata a quella delle altre regioni, ma soprattutto in rapporto all’esodo massiccio degli anni successivi "in cui lo sviluppo spalanca le porte della Sardegna ad una ben più ampia emigrazione e ad un mito che è fatto al contempo di industrializzazione ed emigrazione". È opinione comune che questa prima ondata possa essere spiegata da motivazioni di natura essenzialmente economica. Le condizioni di vita e di lavoro erano estremamente misere; i salari bassissimi, incapaci di soddisfare i bisogni primari e ulteriormente sviliti dai continui aumenti del costo della vita. La crisi economica affondava le sue radici nei provvedimenti legislativi adottati nell’Ottocento per adeguare le condizioni della produzione isolana a quelle nazionali. La legge delle chiudende (1820), l’abolizione dei diritti di ademprivio e di cussorgia (1865), l’istituzione dell’imposta unica fondiaria e del catasto (1851-1865) imposero alla popolazione un’iniqua e pesante pressione fiscale, aggravando ulteriormente una situazione già difficili. Una particolare importanza è attribuita dagli storici alla politica protezionistica di fine Ottocento, che comportò la perdita del mercato, cui si aggiunse la crisi mineraria del settore piombo-zincifero. L’agricoltura sarda, basata sulla coltivazione di grano e vite, risentì fortemente del crollo del prezzo del frumento e della diffusione della filossera. La stessa nascita dell’industria casearia aggrava, secondo Gentileschi, la situazione di lavoro degli agricoltori, a causa della conversione a pascolo di terre arabili, e alimenta una forte emigrazione soprattutto verso il Nord Africa, che si intensifica fra il 1906 e il 1907. In effetti l’introduzione di nuove strutture produttive è accompagnata da fenomeni di forte emarginazione. L’inasprimento del conflitto sociale, che ne deriva, sfocia in violenti scontri con le forze dell’ordine, fra i quali gli eccidi di Buggerru (1904) e Cagliari (1906) sono gli episodi più gravi. Possiamo dunque affermare che l’emigrazione di quegli anni è un fenomeno essenzialmente rurale, che Nereide Rudas definisce un "processo di espulsione coatto". Anche per quanto riguarda le destinazioni, l’emigrazione sarda marca un’inversione di tendenza rispetto a quella meridionale, privilegiando come sbocco principale il bacino mediterraneo e, in modo particolare, il continente europeo. Nel 1909 su 100 emigrati che lasciano la regione il 54,2% si reca in Europa o nel bacino del Mediterraneo, il 12,5 negli Stati Uniti, lo 0,4 in Brasile, il 32,6 in Argentina e lo 0,3 in altri paesi. Nello stesso periodo il Mezzogiorno alimenta un flusso transoceanico pari all’88,8% delle partenze totali(di cui il 59,2% verso gli Stati Uniti)15. Rispetto all’emigrazione estera le partenze verso l’Argentina meritano un particolare commento. Se vengono paragonate alla grande corrente migratoria nazionale, gli espatri sardi appaiono di scarso rilievo rispetto al cospicuo contributo di regioni come il Piemonte (che per il periodo compreso tra 1876-1925 invia 368.400 unità), la Calabria (288.700), la Sicilia (242.000) e la Lombardia (227.000). Tuttavia, se si considera l’emigrazione sarda in relazione all’isola, e non alle altre regioni italiane, e se si esamina "l’attrazione esercitata dall’Argentina, proprio nel primo periodo di forte emigrazione, allora le conclusioni potranno anche essere diverse". Infatti, sempre per gli anni sopra considerati, la Sardegna registra un esiguo numero assoluto di emigrati (20.900 unità). Tuttavia l’incidenza del flusso verso l’Argentina sull’emigrazione totale dall’isola raggiunge il 17% e quindi supera la media del Meridione collocandosi al sesto posto dopo Marche (38,0%), la Liguria (32,5%), la Calabria (27,6%), la Basilicata (21,5%) e il Piemonte (19,3%) tra le regioni con la più alta percentuale di partenti verso il Plata. In questa prima fase si rileva chiaramente il maggiore contributo dato all’emigrazione dalla parte nord-occidentale dell’isola. Si possono individuare nel Logudoro, Meilogu, Monteacuto, Planargia, Montiferru, Marghine e Goceano, le regioni dell’isola maggiormente colpite. Prendendo in considerazione la media annua del triennio 1908-1910 sulla popolazione del 1911, Cagliari registra un’incidenza migratoria sulla popolazione dello 0,3%, il comune di Ozieri, il più colpito, ha invece una percentuale del 2,2% (50.390 abitanti, 1.101 emigrati). "Ma altrettanto interessante – continua Zaccagnini – è analizzare i valori assoluti dell’emigrazione e considerare quanti comuni ne siano stati colpiti: nel circondario di Cagliari solo il 50%, laddove nell’intera provincia di Sassari tale percentuale sale al 96% e ben tre circondari (quelli di Ozieri, Sassari e Tempio Pausania) raggiungono il 100%: in tutti i comuni è stato registrato almeno un emigrato in media nel triennio". Altra caratteristica del tutto isola
na è l’estrema povertà della tipologia migratoria. "Aprioristicamente – scrive Lei Spano – può dirsi che l’emigrazione sarda, essendo la meno illuminata ed essendo stata l’ultima ad arrivare nei centri di lavoro, abbia trovato le peggiori condizioni di ambiente e di salario". Anche la media delle rimesse pro-capite degli emigrati sardi è, infatti, nettamente inferiore a quella del Mezzogiorno. Lungi dal risolvere le drammatiche problematiche della realtà sarda, i flussi migratori contribuiscono soprattutto allo spopolamento di intere zone e all’abbandono sempre più massiccio delle campagne. L’incidenza, che l’esodo ha in termini di costi umani e sociali, è particolarmente negativa, non tanto per la sua entità, quanto per il sintomo che esso rappresenta. La Sardegna lamentava infatti non l’eccesso, ma la scarsità di popolazione. La preoccupazione per lo spopolamento è avvertita dalla stampa isolana fin dai primi anni del Novecento. Le cronache interne dei quotidiani principali trattano, quasi quotidianamente, la problematica del triste esodo. Le ricerche demografiche degli anni successivi dimostrano d’altronde che le aree maggiormente colpite dall’emigrazione sono quelle in cui l’età media della popolazione è la più alta. La popolazione che non emigra nota con ansia il continuo innalzamento degli indici di vecchiaia dei propri comuni. Venendo a tempi più recenti, il 1953 segna il principio di una nuova fase dell’emigrazione sarda, differente sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Essa mostrava "dimensioni più ampie e aspetti più complessi e sociologicamente più ricchi sotto il profilo della valutazione del comportamento dei gruppi sardi". A partire dagli anni Cinquanta l’isola è interessata da un esodo massiccio, che risulta ancora oggi difficilmente quantificabile in base ai dati statistici disponibili. Infatti, sebbene per la "nuova" emigrazione si disponga di documentazione più precisa, sembra difficile definirne con esattezza la vera entità. Le diverse metodologie d’indagine risultano, per motivi diversi, strumenti imperfetti. Comunque, pur considerando i limiti delle metodiche utilizzate e il fatto che l’emigrazione sarda sfugga a stime precise, emerge chiaramente che fra il 1953 e il 1971 si è sviluppato un fortissimo flusso migratorio che coinvolge circa un terzo della popolazione. Si ritiene che per il solo periodo compreso fra il 1955 e il 1971 il numero degli espatri sia pari a 400.982, risultato ottenuto sommando l’emigrazione nazionale (307.759) a quella estera (93.223). Tali cifre sono, però, solo indicative di un fenomeno ben più vasto, dal momento che considerano unicamente l’emigrazione "controllata" ed escludono dalle stime le partenze "libere", che assorbivano invece la maggior parte delle partenze verso l’estero. La corrente migratoria sviluppatasi tra il 1953 e il 1959 non ha origine rurale. Il nuovo fenomeno, almeno nei primi anni, non è l’espressione della crisi del mondo contadino ma, al contrario, parte dai centri industrializzati del Sulcis-Inglesiente. Il calo del prezzo di piombo e zinco e la diminuzione dello smercio del carbone del Sulcis sul mercato italiano ed europeo sono le cause principali della crisi mineraria di quegli anni e delle successive partenze. L’iniziale matrice operaia di fine anni Cinquanta è ridimensionata quando la spinta migratoria diviene più generale e coinvolge nuovi ceti. A partire dai primi anni Sessanta l’esodo interessa nuovamente la realtà rurale e contadina raggiungendo, nel 1962, il massimo della sua espansione. Il bracciantato agricolo disoccupato o sottoccupato non trova infatti più sbocco lavorativo nei complessi industriali del bacino minerario. Ma già dal 1966 la crisi che ha colpito la pastorizia determina la partecipazione ai flussi migratori delle realtà più interne e isolate come le Barbagie e la Baronia, sino ad interessare il massiccio del Gennargentu. La fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta segnano un forte calo del fenomeno che rimane di proporzioni modeste anche per tutti gli anni Ottanta. Al processo di spopolamento prodotto dal movimento migratorio si accompagnava, in questi decenni, un marcato sviluppo dell’urbanesimo che, provocando l’eccessiva concentrazione nei capoluoghi di provincia, contribuisce a sovvertire il disegno demografico e a deteriorare il rapporto città-campagna. Anche se questa "nuova" emigrazione appare come un fenomeno generalizzato a tutte le aree dell’isola, coinvolgendo soprattutto le zone più povere dall’economia ancora prettamente pastorale. Le perdite più intense si registrano in alcuni comuni del Logudoro, Meilogu, Goceano, Barbagie, Marmilla e Trexenta. Nella Sardegna meridionale l’esodo colpisce maggiormente le aree collinari e montuose attorno al Campidano, nonché le zone minerarie come il Gerrei e il Sulcis-Iglesiente, dove i comuni di Arbus, Buggerru, Gonnesa e Carbonia soffrono in modo particolare la crisi del settore minerario. Le aree di sbocco di queste correnti migratorie sono principalmente le regioni nord-occidentali dell’Italia e i paesi membri dell’allora CEE. La tendenza è chiaramente quella di privilegiare le aree metropolitane. In Italia Roma, Genova, Milano e Torino vedono la nascita di numerose colonie sarde. Tra queste città Torino è senza dubbio quella che accoglie la maggiore emigrazione isolana: oltre 70.000 immigrati sardi nei primi anni Settanta. L’emigrazione nel triangolo industriale è costituita per la maggior parte da manodopera poco qualificata, assorbita "secondo modalità produttive di tipo subordinato". Si differenzia da questa tipologia la corrente verso la capitale, prevalentemente costituita da un ceto medio impiegatizio, inserito nel settore burocratico-terziario. Infine, nonostante Roma assorba circa l’82% dell’emigrazione sarda nel Lazio, si rileva un esodo di pastori verso questa regione, parte di un peculiare movimento che coinvolge, oltre le campagne laziali, le zone centro-settentrionali italiane (in modo particolare quelle toscane). Per quanto riguarda l’emigrazione estera, l’Europa rimane la meta privilegiata dai sardi e all’interno di questa i paesi del MEC raccolgono la maggior parte del flusso migratorio (circa l’80%). Tra il 1962 e il 1966 la Repubblica Federale Tedesca assorbe circa la metà degli emigrati sardi in Europa e la Svizzera un quinto. Le migrazioni transatlantiche e mediterranee, principalmente verso l’Africa settentrionale, diminuiscono notevolmente, mentre restano del tutto esigui i flussi verso Asia e Oceania. Azzardando un’analisi complessiva delle caratteristiche socio-demografiche dell’emigrazione sarda, si rilevano alcune importanti caratteristiche, Un primo elemento, messo in rilievo da tutti gli studiosi, è la giovane età dei migranti: essa rivela allo stesso tempo "un’innaturale distribuzione delle classi d’età non tutte equamente rappresentate". La fascia d’età con la più alta densità è quella dai 20 ai 40 anni ed esclude le componenti più anziane e quelle più giovani. Altro fattore strutturale della popolazione migrante è la forte partecipazione femminile non solo in quanto unità interne ad un nucleo familiare, ma come lavoratrici autonome. "Fra le donne emigrate fuori della Sardegna il 27% era in condizione professionale, contro l’11,5% per quelle che non si erano allontanate dalla loro provincia di nascita e il 16,8% per quelle che erano emigrate all’interno della regione. (…) Contemporaneamente mutava per le donna la posizione nella professione, poiché il lavoro diventava in misura sempre maggiore alle dipendenze di altri anziché indipendente, man mano che aumentava il raggio dello spostamento". Il livello di scolarizzazione degli emigrati sardi è generalmente
inferiore a quello della popolazione di accoglimento. Questo comporta spesso fenomeni di emarginazione e lavori subalterni, sovente rifiutati dalla popolazione indigena. Solo dopo il 1963-1964 si parla di un’emigrazione "più motivata e qualificata", anche se il numero di diplomati e laureati rimane nettamente minoritario. L’esame delle caratteristiche socio-demografiche evidenzierebbe infatti una matrice prettamente economica anche per questa seconda fase migratoria, tanto che la maggior parte degli studiosi individuano l’origine dell’emigrazione nel permanere delle condizioni di sottosviluppo. Tuttavia, ve ne sono alcuni di diverso avviso come Aldo Aledda che, riprendendo le posizioni precedentemente espresse da Pietro Crespi, pone l’accento su importanti cambiamenti culturali avvenuti nella società sarda e sul rifiuto di soffocanti modelli culturali paesani. "Non voglio sottovalutare il peso dei fattori economici – scrive Aledda – sul fenomeno migratorio, che in ogni caso rimangono rilevanti. Piuttosto mi sembra importante sottolineare la spiegazione di quanto è avvenuto in chiave di rifiuto dei modelli culturali imperanti nell’isola fino all’ultimo dopoguerra. Tra essi va logicamente fatto rientrare il dato economico, ma come parte generale di un modello che entrava in crisi. (…) La situazione economica ha funzionato più che come fattore di espulsione come polo di attrazione. L’emigrazione, infatti, è stata orientata dalla nascita di nuovo mercati del lavoro a seguito del riassetto dell’economia occidentale nel dopoguerra". Le motivazioni addotte dalla Rudas per confutare questa linea interpretativa di matrice socio-culturale appaiono, però, particolarmente efficaci: "Se è corretto osservare che nel processo emigratorio attuale confluiscono componenti psicologiche, sociali, ecc. è però giusto riaffermare che non per questo l’emigrazione è un atto di scelta e di libertà. Deve, infatti, essere riconosciuto nella situazione di base del migrante un bisogno ‘aperto’. E anche se tale bisogno non è necessariamente riconducibile a una pura spinta economica, ma può essere più o meno colorito e integrato da motivazioni psico-sociali e culturali, resta tuttavia il fatto che, a monte di tali motivazioni e nel quadro entro cui esse si collocano, vi è una condizione generale di arretratezza e di insufficienza dei contesti di partenza, che non permette il soddisfacimento del bisogno stesso, non consentendo in ultima analisi, al migrante di autorealizzarsi nel suo luogo di origine". Del resto, l’apertura culturale di quegli anni e la conseguente necessità di modelli culturali e stili di vita differenti, per quanto importanti, sembrano insufficienti per spiegare le cause di un fenomeno di massa come l’emigrazione. Le direttrici migratorie sono sempre state strettamente legate all’evoluzione economica. Non a caso, il periodo di emigrazione più massiccia coincide con il varo e l’attuazione del Piano di Rinascita per la Sardegna, che ha avuto risultati aleatori e assolutamente inefficaci nei settori maggiormente in crisi. "L’intensità e la geografia dell’emigrazione – scrive Pinelli – nel periodo 1961-1971, in cui il Piano di Rinascita ha avuto attuazione, mostrano chiaramente quali ipotesi di sviluppo sono fallite: l’esodo ha riguardato le zone a economia estrattiva e agro-pastorale, in cui sono mancati gli interventi già previsti come necessari, risparmiando le uniche zone che hanno avuto uno sviluppo ulteriore, che sono quelle che già erano in condizioni migliori, in cui si sono concentrati gli investimenti industriali. Queste hanno avuto una forza di attrazione sulle aree più depresse che però non ha frenato l’emigrazione dalla Sardegna, anzi probabilmente la ha incentivata, aggravando il contrasto fra modi di vita legati ad economie, organizzazioni sociali, culture troppo diverse per poter coesistere senza che la più debole entrasse in crisi". La mancanza di ogni prospettiva di sviluppo economico nei settori fondamentali della produzione è stata la spinta, che più di ogni altro condizionamento culturale, ha messo in atto un processo irreversibile che ancora oggi spopola la Sardegna. A partire dai primi anni 90, infatti, il movimento migratorio è ripreso con forte intensità e come fenomeno generalizzato. Risulta difficile dare una stima esatta dell’emigrazione degli ultimissimi anni, ma la recente pubblicistica sindacale e la stampa parlano di circa 3.000 partenze annue.