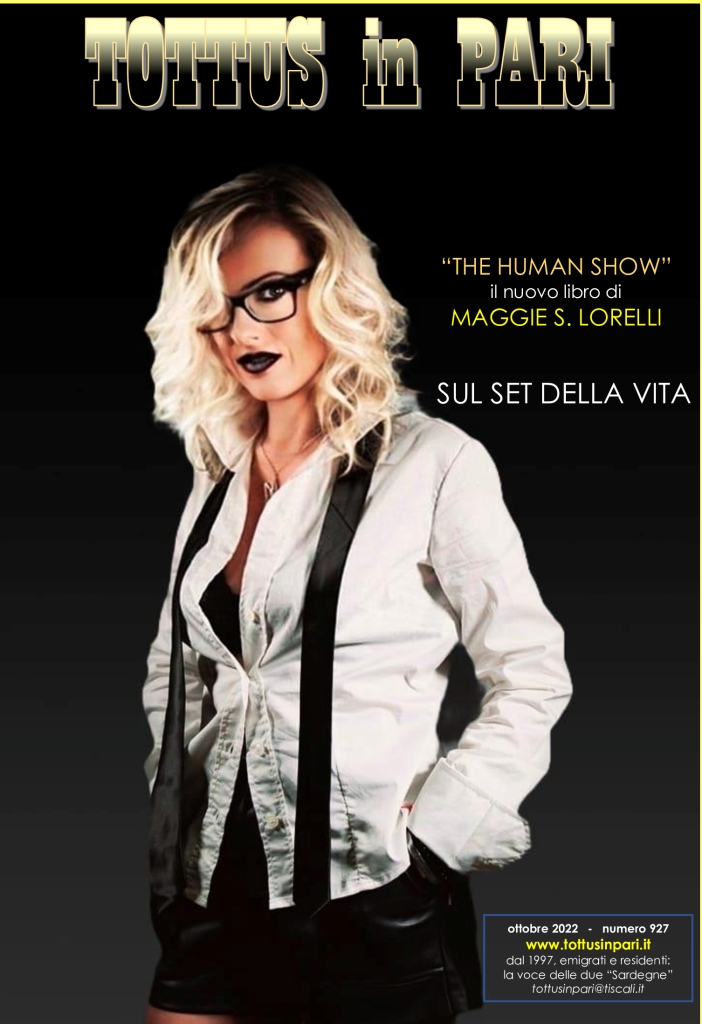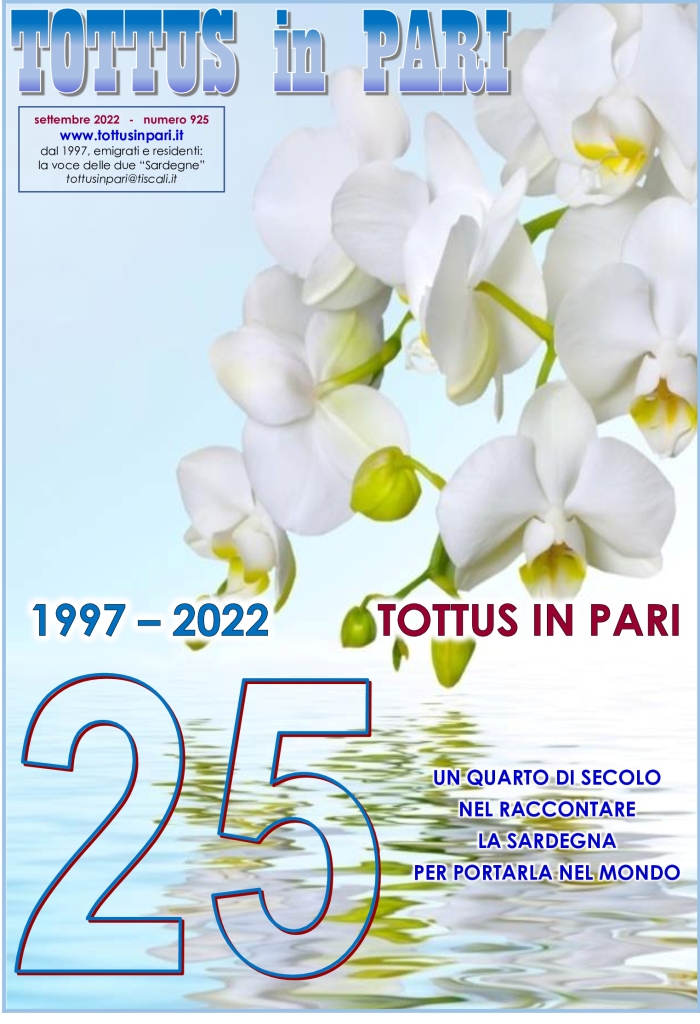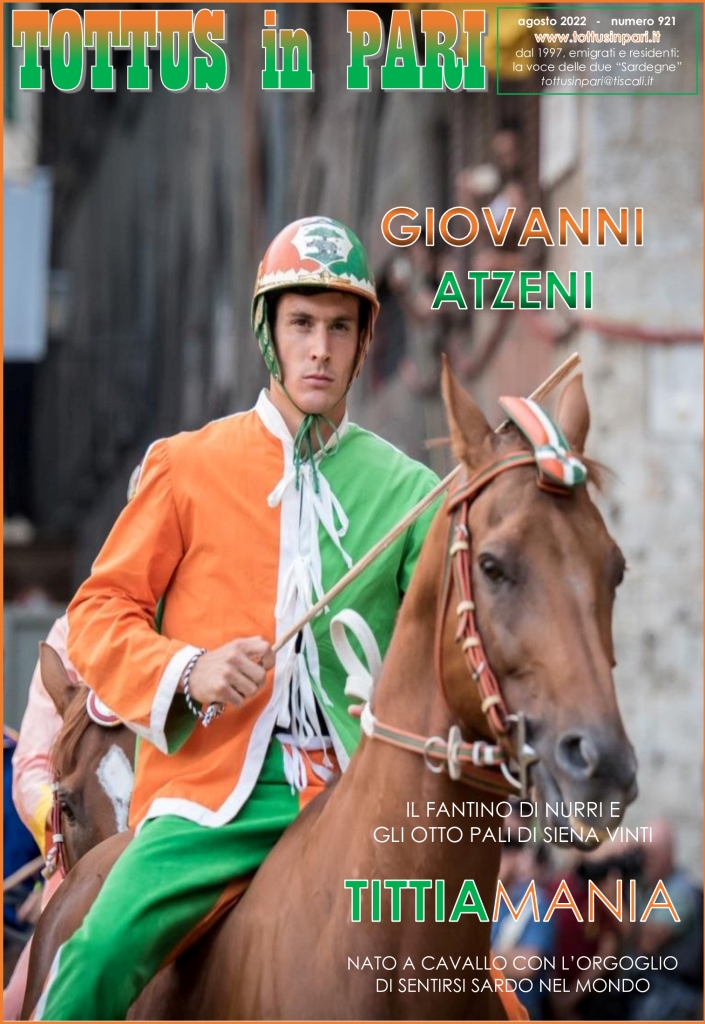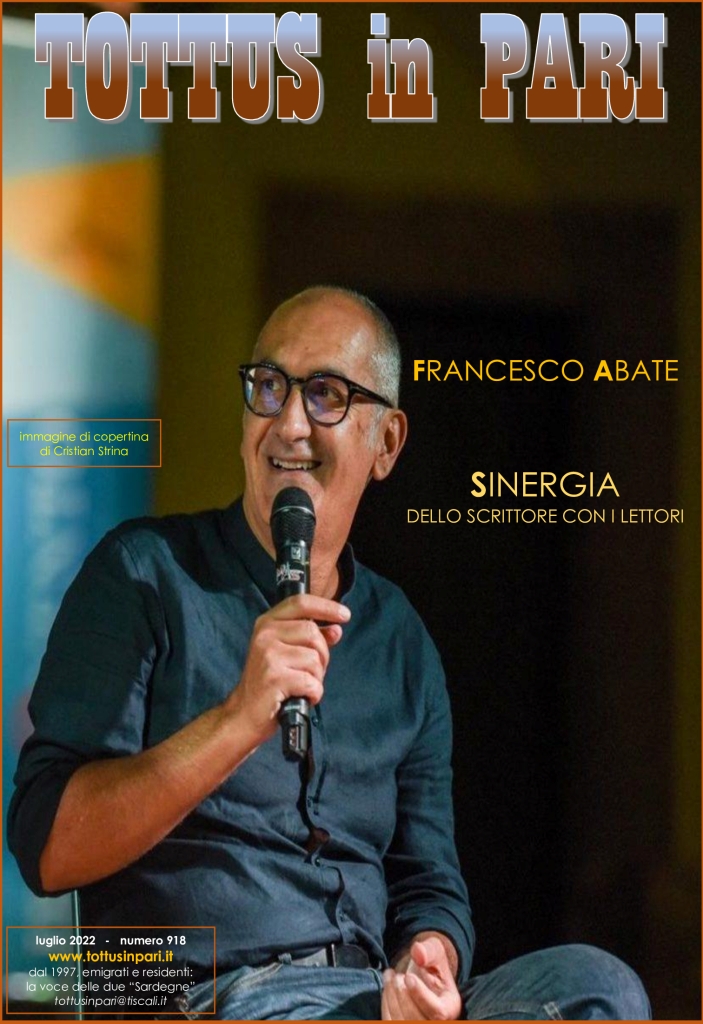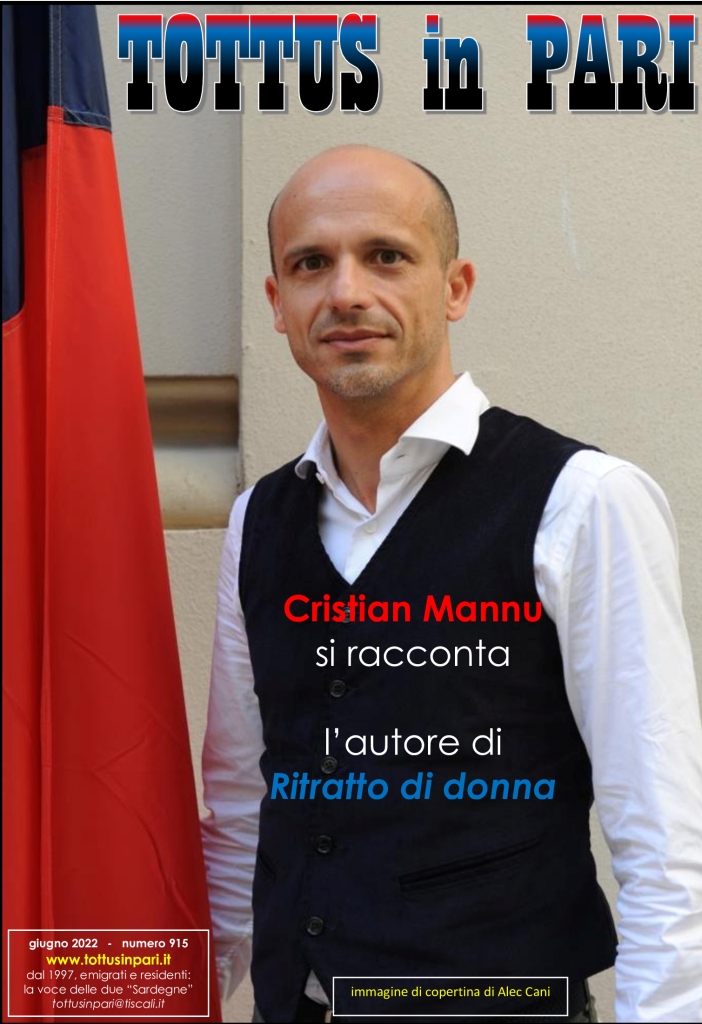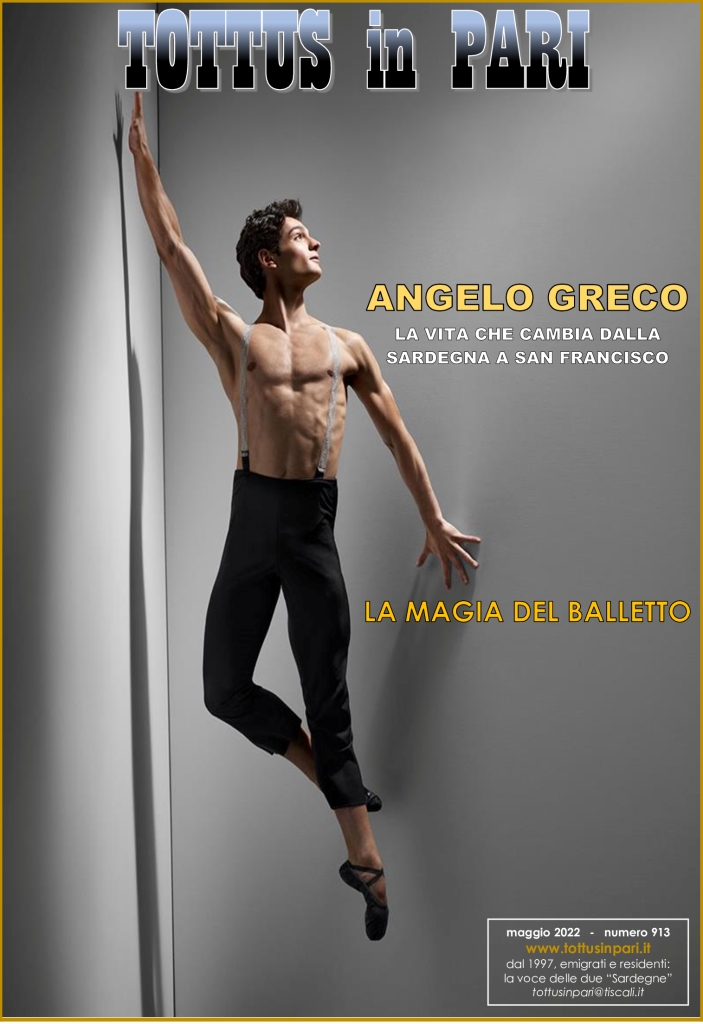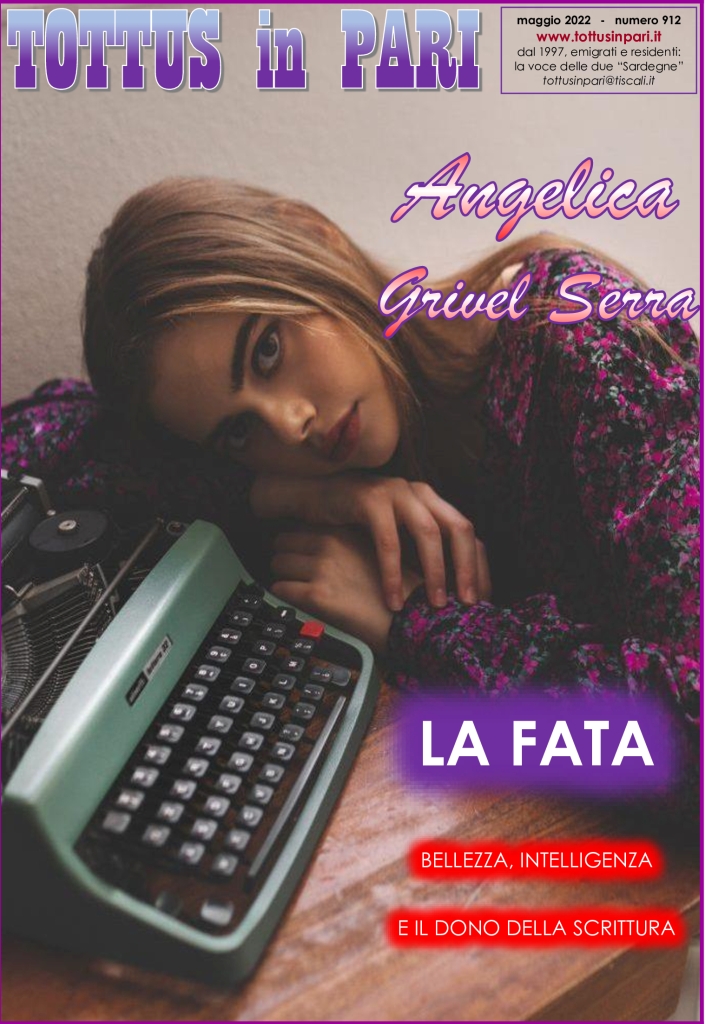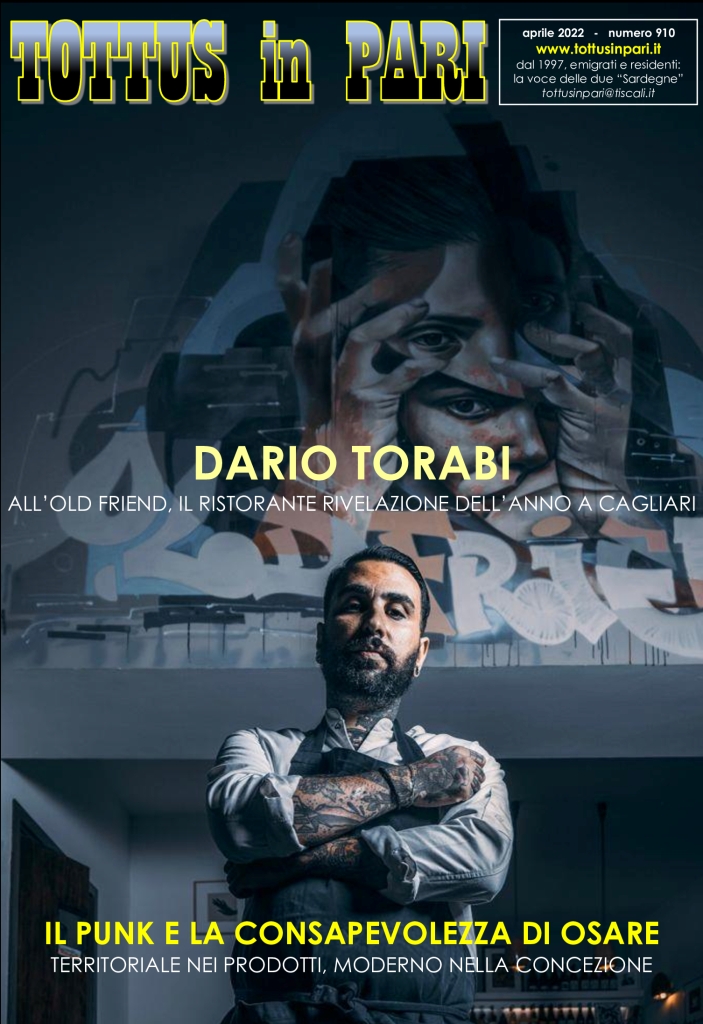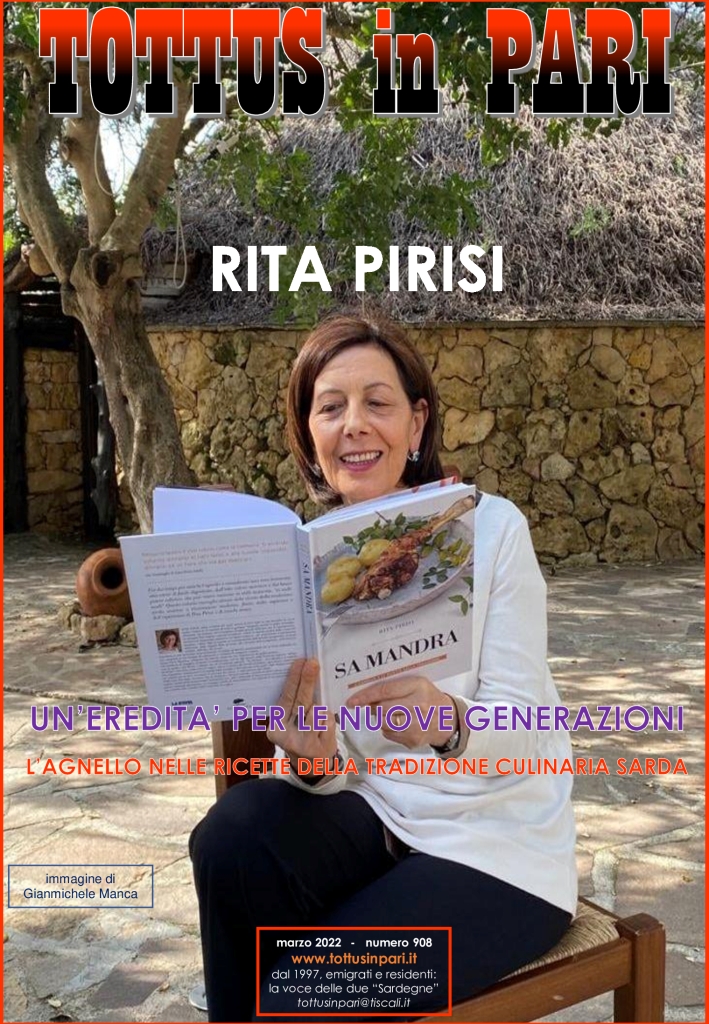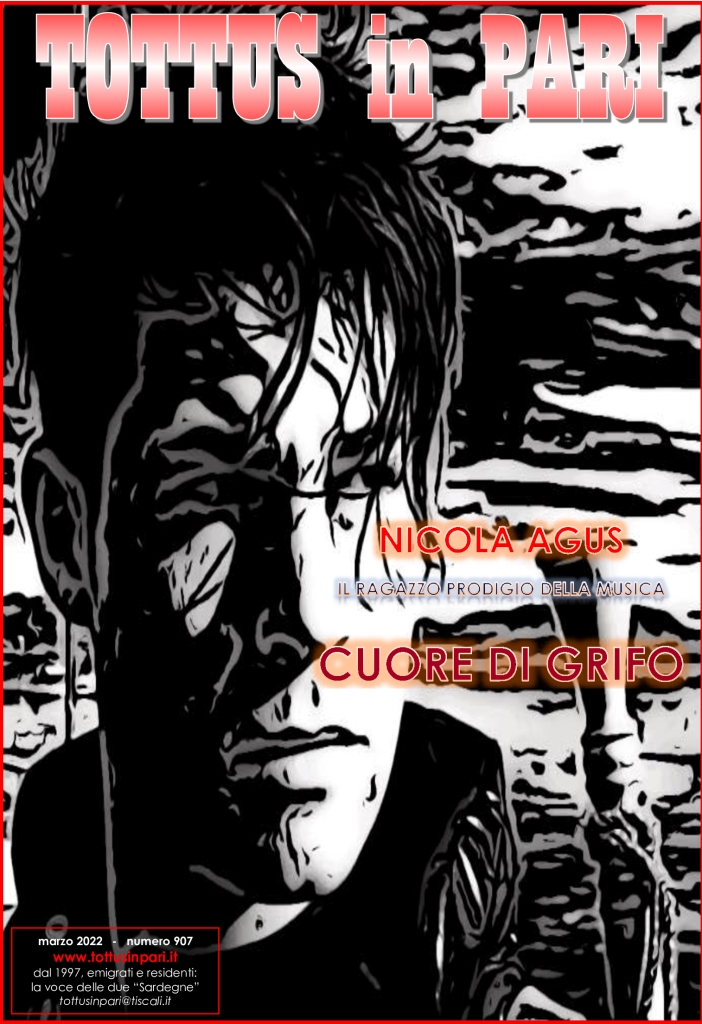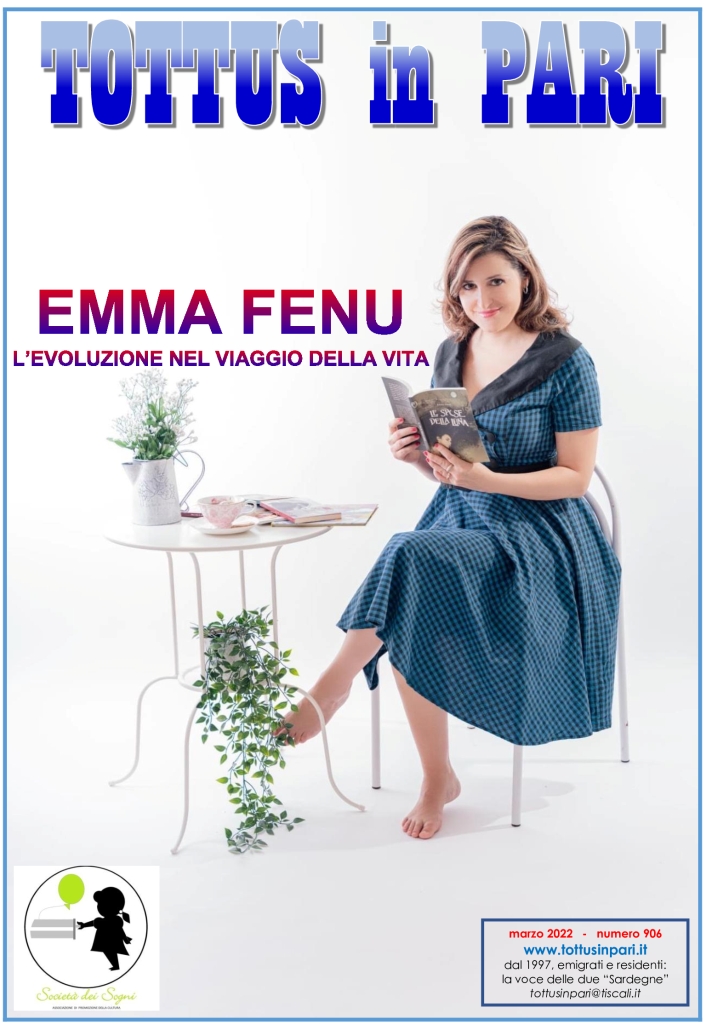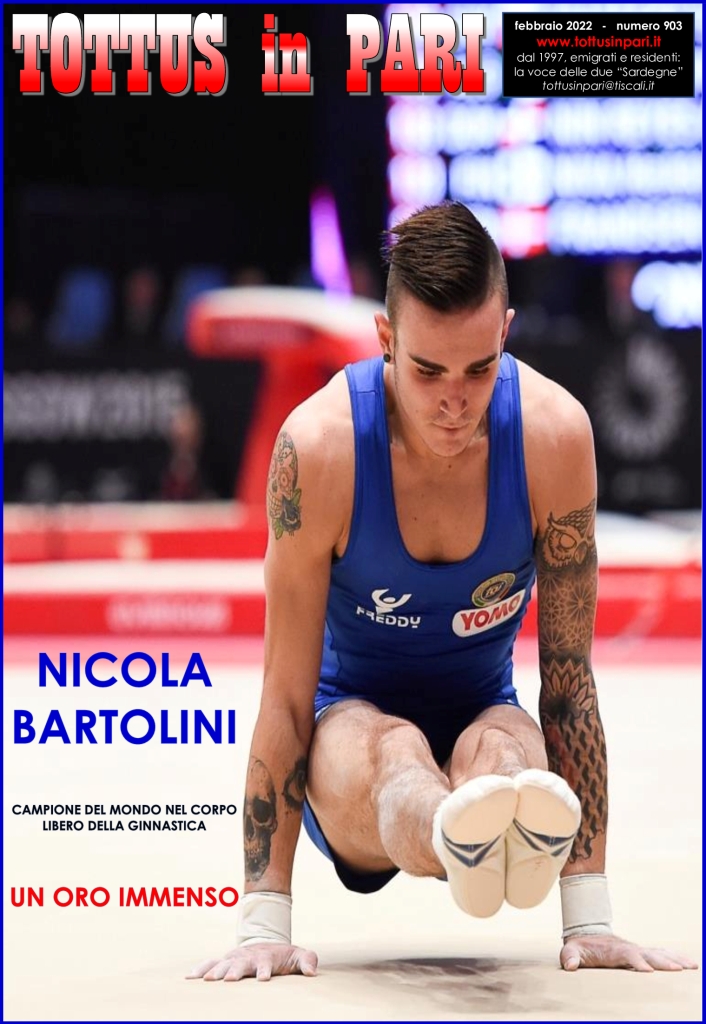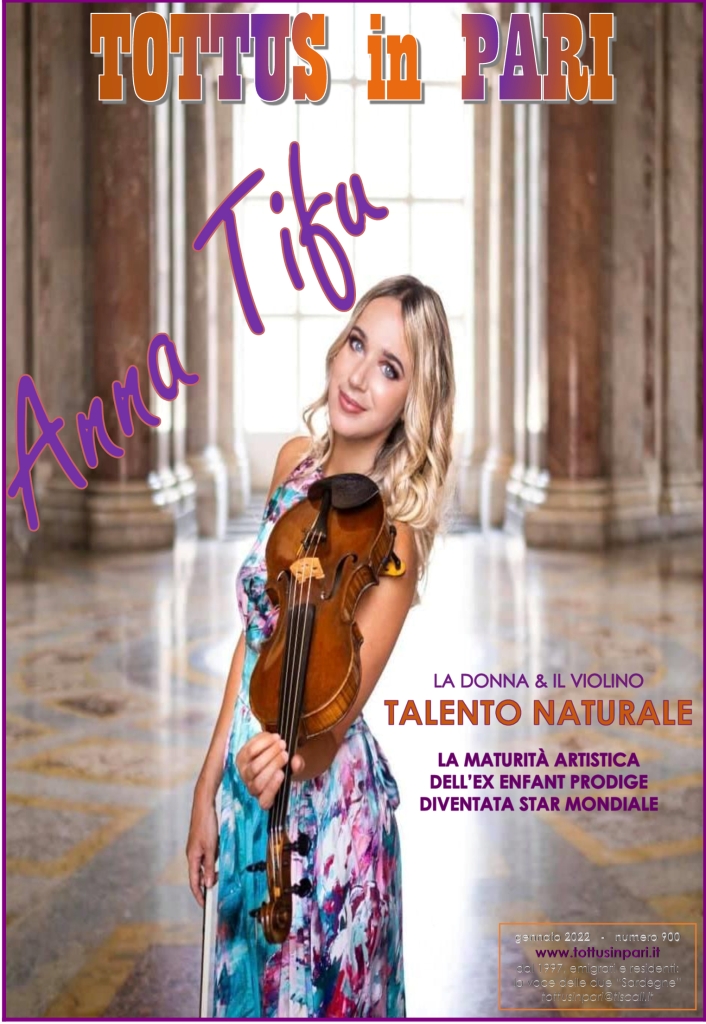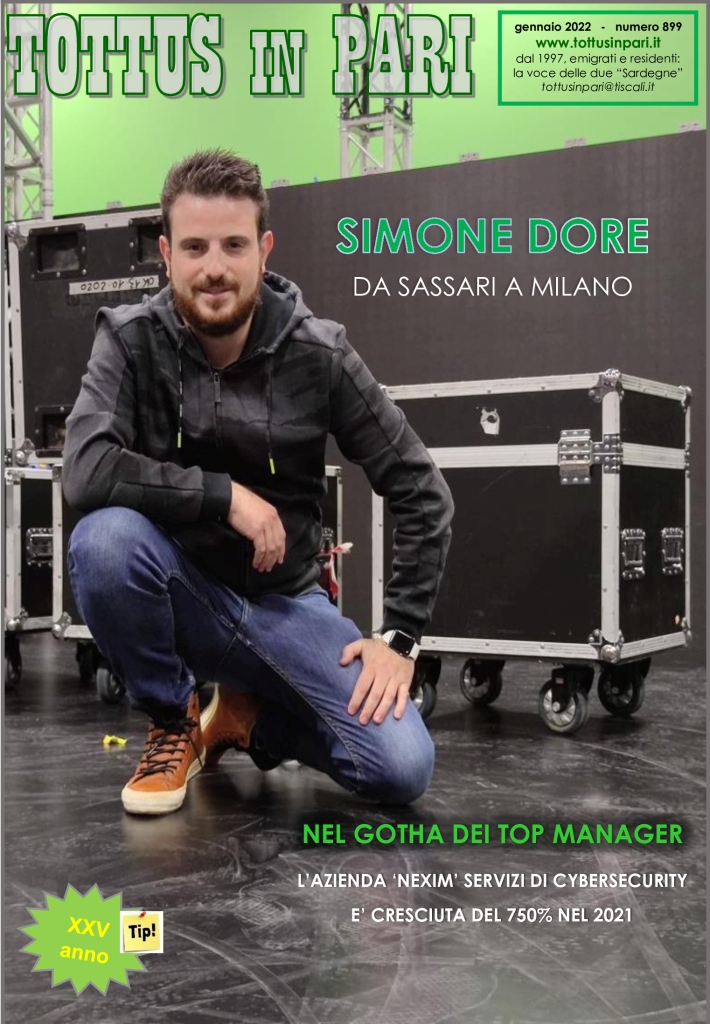di SERGIO PORTAS
Non è un caso che il regista Salvatore Mereu prenda spunto da un scritto di Antonio Cossu: il vento e altri racconti, per il suo “Bentu”, questi un intellettuale a tutto tondo, di Santulussurgiu, venutosi in continente a laurearsi, lui del’27, finì a lavorare insieme a quel gruppo di scrittori, artisti ( c’era anche l’oranese Nivola) che gravitavano intorno al sogno di Adriano Olivetti: un mondo in cui il capitale non si facesse predatore onnivoro del plusvalore operaio con l’intento di restituire un “quid” significativo del suo prodotto a coloro che più avevano contribuito a formarlo: in stipendi adeguati, asili e scuole per i figli dei dipendenti, ma anche cultura spesa a piene mani, per tutti. E Cossu rientrato in Sardegna scrisse in giornali e fondò riviste ( il Bogino, La grotta della vipera, tra gli altri) dove firmarono articoli i maggiori pensatori sardi del periodo. Sempre avendo nel cuore il suo Montiferru, la San Leonardo di Sete Fuentes. Il mondo sardo che nel dopoguerra andava mutando pelle come un serpente, bruciandosi al fuoco di una modernità più subita che agognata, smarrendo lingua e dubitando della bontà dei fondamenti che sinora l’avevano retto, nel bene e nel male. Il contadino che aspetta il vento per poter trebbiare il suo grano, tagliato a falce, ha il volto di Peppeddu Cuccu, che ha la fortuna di potersi guardare da bimbo in “Banditi ad Orgosolo”, seppure nel bianco e nero di De Seta, che gli serve da clessidra per misurare quanto il tempo ha potuto scavare di rughe il suo viso di vecchio. Mai un sorriso in “Bentu”, non riesce a strapparglielo neppure la vitalità dei dieci anni di Angelino, Giovanni Porcu, il nipote che dal paese viene a portarsi via il latte, e in cambio fa da postino e da sorvegliante per conto della moglie, che il vecchio non ne vuole sapere di lasciare il campo e l’aia, e solo si accudisce magri pasti fatti di pane e ricotta e di spaghetti poco conditi, fatti bollire in una pentola al fuoco del camino. Non c’è energia elettrica nella casupola misera in cui si muove, né acqua corrente ovviamente, i servizi igienici è ridicolo solo pensarli, hai tutti i campi solo per te alla bisogna, tutti gli altri contadini se ne sono andati. Di loro solo il ruggito di una mietitrebbia che arriva da San Luri, nientemeno, testimonierà che sono tornati a finire il lavoro nei loro campi, gialli di grano a vista d’occhio, che si spartiscono la metà del creato con un cielo di implacabile azzurro. Di nubi neanche l’accenno, la calura implacabile non fa muovere un filo di erba. Secca. Un albero solitario nel mezzo della campagna attira con la sua ombra sin la cavalla del vecchio, che se ne scappa anche essa alla ricerca di una brezza che le scompigli la criniera. “Tortorella” si chiama, e tocca ben custodirla, che ha il vizio di mangiarsi anche il grano. Raffaele e Angelino si parlano in sardo, Angelino quello del campidano di Cagliari, Raffaele farfuglia una parlata del capo di sopra, dice “abba” per acqua, ma l’uno capisce il dialetto dell’altro ( per la gente del continente ci sono i sottotitoli provvidenziali) e dall’andare degli avvenimenti capisci che è giusto così, che i suoni e le voci che intercalano la narrazione non possono che accompagnare quella natura debordante che faceva da coperta alla Sardegna della metà degli anni ’50. Lo scalpitare del cavallo, l’urlo della civetta di notte, notti di buio assoluto se la luna era latitante, la candela che agisce da unica fonte di luce la macchina da presa che a stento riesce riportare uno spicchio di realtà, tinteggiando la scena con esiti di quadro caravaggesco, facendoti intendere utensili e mobili per come l’ombra preponderante se li inghiotte e li nasconde, letto e lenzuola compresi. Tutto di una povertà sconcertante, se paragonata all’abbondanza di oggi, Raffaele non ha ricambi per i suoi vestiti e meno male che il fiume non è lontano e che, vero omaggio della natura, vi si possono pescare persino le anguille, non le ha mai mangiate le anguille Angelino, la cui camicia servirà da rete improvvisata per poterle riportare a casa. “S’appu portau su ‘entu e is ousu” (Vi ho portato il vento e le uova) gli dice comparendo nel presto del mattino e trovando ancora a letto Raffaele: “Pesadindi”, alzati! permettendosi un “tu” assolutamente poco usuale se viene da nipote a nonno a cui si doveva dare del assolutamente del “voi” (il mio babbo così usava col suo). Gli promette addirittura di potergli portare il vento, in cambio il permesso di montare “Tortorella”, lui che per ora, quando viene a portarsi via i recipienti pieni di latte, deve montare a cavallo di un asino e soggiacere all’andamento dell’animale, che della lentezza ha fatto la sua ragione di essere nella competizione per la continuazione della vita. Ma si sa che i giovani, gli adolescenti in particolare, è correre che vogliono, ogni eroe, ogni moschettiere del re, ogni principe senza terra, lo si è da sempre visto e dipinto su di un destriero al galoppo, gli asini sono per le donne, per i Sancio Panza, Don Chisciotte impossibile non vederlo che in sella a Ronzinante. A fendere il vento che muove le pale dei mulini. Quel vento indispensabile per separare i chicchi di grano dalla pula; a “bentulare” andavano in molti, prima che le trebbiatrici si prendessero il campo, letteralmente, come pure a trebbiare, nonno Cherchi che in miniera a Montevecchio aveva lasciato la funzionalità di una gamba, ne aveva ricevuto in compenso non so ben quale somma di danaro, utile comunque a comperare due pezzi di terra, al di fuori del paese di Guspini, in “Sa zeppara”. E una carretta e un cavallo. E si era dovuto convertire a contadino. Mamma Pinuccia ( e i miei cugini Augusto e Tullio,ancora bimbi) tutti dovevano contribuire alla raccolta del grano, le strade di campagna polverose d’estate, i piedi scalzi che affondavano sino alle caviglie. “Quella polvere calda di sole” mi diceva mamma, che allora era appena adolescente: “Allora il grano era tutto”. E tutto è ancora oggi per una buona fetta di popolazione che abita questo nostro pianeta, quando da Russia e Ucraina smette di arrivare mercé la follia di una guerra di invasione, lo spettro della fame si materializza per milioni di persone. Ha fatto un film “a sottrarre” il regista di Dorgali, a differenza del suo penultimo “Assandira”, fiume che disperdeva la sua acqua in troppi rivoli, in questo lungometraggio “corto” (dura 70 minuti) la vera sfida è stata quella di “filmare il vento”. E’ presente a Milano, cinema “Mexico” il 28 di settembre, spiegando al pubblico che applaude a fine proiezione, che il film nasce come esito naturale da una esercitazione di laboratorio dell’Università di Cagliari, dove insegna, e si può leggere ad apologo di sfida tra uomo e natura. Peppeddu Cuccu non è un attore professionista, anche se è stato presente in due altri lavori di Mereu, nel corto “Transumanza” e, sempre interpretando “un vecchio” in “Sonetaula”, tratto dal bel libro di Peppino Fiori. Oltre al vento, continua Mereu, protagonista è la luce, di notte e di giorno. E che il cinema guardi anche alla pittura ( riguardo ai chiari-scuri di Caravaggio) non è una novità. Nella mia cinematografia lo scontro tra civiltà e passato è molto presente e a cose fatte scopro che ci sono cascato dentro anche questa volta. Ho usato apposta un linguaggio “arcaico” il dialetto del posto dei primi anni ’50, e allora l’italiano lo parlavano in pochi. Certo far recitare i protagonisti in sardo è scelta radicale, che confina il film in una nicchia di minoranza in Italia. La difficoltà di poter sperimentare nel nostro paese ha fatto sì che dal terzo film che ho girato è stato quasi necessario che divenissi produttore di quelli che avrei fatto dopo. Non nascondo che ci voglia un certo coraggio. Comunque volevo provare a raccontare il mondo da cui provengo. In un certo senso “il vecchio” mi somiglia. Ho la medesima forma di caparbietà nel fare le cose che mi interessano veramente. E mostrare al pubblico di oggi, che il senso del tempo vive in maniera diversa, un tempo a cui non siamo più abituati, quello dell’attesa. Questo film si deve approcciare come un fiume per sentire il suono dell’acqua. Sottolineando che siamo solo ospiti di un mondo in prestito che dovremo consegnare ai nostri figli e nipoti. Questo saper aspettare in serenità è un sapere che, non so dire perché, non è passato alle generazioni che hanno seguito la mia. Il bimbo, Angelino nel film, è stato scelto perché parlava correntemente il dialetto sardo, e poi aveva “una faccia antica”. Farlo recitare è stato abbastanza semplice, come se si trattasse di un gioco. I due protagonisti dovevano “scoprire” il film giorno per giorno, senza occuparsi di trama o copione. E anche la lavorazione ha dovuto adattarsi alle esigenze dei due, Peppeddu ha una certa difficoltà a reggere una giornata di lavoro quando il sole scalda a 40 gradi. Sono comunque contento di occupare seppure una ultima posizione tra i film italiani che hanno fatto scuola nel mondo. E da buon erede di quella cultura sono convinto che trovare gli interpreti “giusti”, è metà del lavoro che ti accingi a fare. Molte delle scene notturne sono illuminate da una sola candela, quando abbiamo provato ad accendere una luce artificiale, l’artifizio si è subito palesato. Non nascondo di essere molto legato a questo mondo che ci siamo lasciati alle spalle. Perché l’ho vissuto: mio zio era pastore e allevatore. Non cavalco l’esotico, e continuo a vivere in Sardegna perché non so concepire di poter abitare in un altro spazio. E sento la necessità di provare a salvare le piccole culture da una globalizzazione che è “mietitrebbia che tutto livella”. Di Franco Scataglini, poeta di estrazione proletaria, autodidatta, marchigiano, mancato nel ’94, il frammento di una sua poesia che sembra parlare di “Bentu”: “Sul mare del frumento/ dulceza e nostalgia/ de nave senza scia/ chi rivedrà più el vento?”.