
di MASSIMILIANO PERLATO
È nata a Nuoro il 27 settembre 1871. Iniziò giovanissima l’attività letteraria. Già a 17 anni pubblicava i suoi racconti su una rivista di moda e a 21 scrisse il primo romanzo Fior di Sardegna. Da allora pubblicò molti romanzi, quasi uno all’anno, tradotti in tutte le lingue, che le dettero la celebrità mondiale. Il più illustre è sicuramente Canne al vento, un titolo che ricorda la terra di Sardegna, isola battuta dai forti venti che giungono dal mare. I temi del romanzo sono la fragilità umana davanti al mare e il destino che travolge impietosamente gli uomini come “deboli canne”. Tutte le sue opere descrivono, in maniera realistica, i paesaggi, i costumi e i caratteri tipici della Sardegna, terra che dà vita dura e lavoro aspro e che splende di una primitiva e incontaminata bellezza. Nel 1926 le fu assegnato il Premio Nobel per la letteratura: una delle poche donne al mondo cui sia toccato questo riconoscimento. La narrativa di Grazia Deledda si basa su forti vicende d’amore, di dolore e di morte, nelle quali domina il senso religioso del peccato e la coscienza dolorosa di una inesorabile fatalità. Altra costante è l’intensa comunione tra luoghi e figure, tra stati d’animo e paesaggio, che è quello aspro della nativa Sardegna, ma non rappresentato secondo i moduli del naturalismo regionale né con la fantastica coloritura dannunziana, bensì rivissuti miticamente.
Pochi romanzieri italiani contemporanei operarono instancabilmente come Grazia Deledda. Una cinquantina di volumi, dai rozzi tentativi di adolescenza, agli scritti della maturità e della vecchiezza sempre più tersi. Altrettanto pochi autori suscitarono nella critica opinioni tanto divergenti. “D’una mediocrità esasperante le novelle” giudicò Renato Serra nelle ‘Lettere’; e quanto ai romanzi concesse che “nelle pagine sempre mediocri, è un che d’umano e sincero, una certa ingenuità che la rende noiosa e la fa rispettare”. Soggiungendo tuttavia: “È lo scrittore che più si presterebbe ad essere trattato seriamente”. Per un altro critico, il sensibilissimo Attilio Momigliano, la Deledda è invece “un grande poeta del travaglio morale, cui l’avvenire serberà il posto che finora non gli fu assegnato… Nessuno, dopo Manzoni, ha arricchito e approfondito come lei, in una vera opera d’arte, il nostro senso della vita”.
Emerge un mondo barbarico e primitivo, governato da leggi morali immutabili, Grazia Deledda fu spesso rimproverata per una certa immobilità e ripetizione, sia per ciò che concerne la scelta di motivi dalla vita nella provincia sarda, sia nei riguardi del loro trattamento artistico. Del tutto formata essa apparve la prima volta in ‘Elias Portolu’ (1903) che rimane fra i suoi romanzi più schietti. Ma pochi anni dopo, e decisamente Nel deserto (1911), già s’era provata a trasferire i suoi provincialismi fra la borghesia di Roma, in tutt’altre occupazioni che rustiche e boscherecce. Il fondo della Deledda è istintivo, pressoché incolto. Le sue predilette frequentazioni della Bibbia, di Omero, dei romanzieri russi, di Manzoni e Verga, stanno nella sua esperienza più come un fatto vissuto che come un fatto letterario. La lettura dei suoi romanzi ha bisogno di continuo d’essere difesa dal disturbo che le proviene da pagine ed episodi troppo approssimativi ed inferiori. E richiede tuttavia, al medesimo tempo, un’esperta attenzione, quanto più il mondo d’affetti e d’immagini della scrittrice, nell’intima natura, è sotterraneo, sfumato. Lo conferma la sua vita di massaia, la rudimentale preparazione, la casalinga sobrietà delle preferenze, l’assoluta estraneità alle conventicole e alle mode. Tutte le fatiche di mero carattere letterario cui ella può avere atteso, si riducono a qualche trascrizione di canti popolari sardi.
Per Grazia Deledda, l’influsso della Sardegna e del dialetto isolano si limita ad un apporto non tanto di forme sintattiche e di vocaboli, quanto di temi, costumi, leggende, proverbi. Del suo mondo, la Deledda cominciò a scrivere in una lingua che conosceva bene e in cui ha fatto maturare il suo talento con assiduo esercizio. Eppure la Sardegna di Grazia Deledda a nessuno parve poco accettabile come ai sardi. Non perché la Deledda l’avesse diminuita o calunniata. Ma l’aveva come recisa alle radici, e trasportata in un clima deformante e allucinante, che, a chi leggesse con i presupposti naturalistici, e con un po’ di gelosia regionale, doveva sembrare né più né meno che un clima di melodramma. I tre romanzi ‘Elias Portolu’ (1903), ‘Colombi e sparvieri’ (1912) e ‘Canne al vento’ (1913, di tutti i suoi romanzi, alla Deledda il più caro) stanno certamente fra il meglio che la scrittrice creò nella prima metà della sua laboriosa carriera.

In ‘Canne al vento’ il protagonista è il servo Efix che nella casa delle dame Pintor, Ruth, Noemi, Ester, riesce a tenere in vita l’antica dignità a prezzo di grandi fatiche e di una devozione senza fine alle padrone. Egli coltiva l’ultimo podere rimasto, e con i proventi mantiene le sorelle. Due, Ruth e Ester, ormai rassegnate in un malinconico limbo di memorie e di antiche tradizioni, Noemi invece ancora ricca di sangue giovane e ribelle, chiusa in sdegnosa solitudine. In passato una quarta sorella, Lia, si era rifiutata all’egoismo del padre che teneva segregate le figlie e era fuggita in Continente. Alla fuga aveva assistito, testimone silenzioso ed innamorato, Efix, colpevole involontario della morte del padre che aveva tentato di fermare la figlia fuggiasca. Nessuno è al corrente del segreto: la morte del padre è stata attribuita a disgrazia. Ora, morta Lia, torna nella casa materna Giacinto, il figlio di lei. Nella vecchia casa irrompono ricordi, risentimenti, speranze, passioni dimenticate. Giacinto fa una vita dissipata, finisce per ridurre alla rovina le zie. Quando se ne va per cercare lavoro, le vecchie zie sono costrette a vendere il podere a Don Predu, cui Noemi, soggiogata da un rapporto di amore-odio per il nipote, ha rifiutato la mano. Dopo l’allontanamento dalla casa che egli crede maledetta per il delitto di cui si accusa, Efix troverà la pace solo il giorno delle nozze di Noemi, e muore lo stesso giorno. A Ester aveva detto: “Siamo canne, e la sorte è il vento!”, e alla sua risposta del perché del destino, Efix aveva risposto:” E il vento perché? Dio lo sa!”. Ma almeno altrettanti romanzi, dello stesso periodo, verrebbero a collocarsi sul medesimo piano, o appena al disotto; come Cenere, Nostalgie, L’edera, senza escludere che, in qualche particolare invenzione o in talune pagine, sembrano persino sopravanzare, ma per poi crollare. Così accadde per L’incendio nell’oliveto (1918), che s’avvia splendidamente ma non si sostiene, e in complesso dà un’impressione di capolavoro mutilato.
A mezzo la produzione di Grazia Deledda, come chiave di volta, è la raccolta di novelle intitolata ‘Chiaroscuro’ (1912). Fra i suoi racconti di pellegrinaggi, uno più bello dell’altro, sempre in ‘Chiaroscuro’, spicca quello della Festa del Cristo, con la cavalcata che s’incolonna dietro al vecchio prete triste e misterioso, finché sopraggiunge su un rosso puledro il giovane Istevene. Il puledro scalpita, schiuma, non vuole stare in fila, e la sua irrequietudine contagia le altre bestie. La processione è spezzata, e il vecchio prete si cruccia. A questa tempesta giù in terra, tiene bordone la tempesta nel cielo. Un diluvio costringe la carovana a rifugiarsi e pernottare intorno al fuoco, fra lo scalciare del dannato puledro nel branco delle cavalcature sonnacchiose. Poi la partenza alla schiarita dell’alba, i suoni delle fisarmoniche, l’idillio fra Istevene e la ragazza del cavallo bianco. Ma il puledro spaurisce il cavallo, e la ragazza ruzzola di sella. Alla fine, mentre il vecchio prete sta celebrando alla chiesetta del Cristo, si sparge la voce che con un calcio il puledro ha ucciso un bambino. Nella veglia al morticino, Istevene, chiamato dal prete, confessa che il puledro l’ha rubato a un usuraio. Quando Istevene esce a pigliare il puledro per renderlo al proprietario, il puledro non c’è più, se l’è portato via il diavolo. È un quadro che formicola di personaggi e colori, abbagliante come una miniatura orientale.
Paesaggio, uomini ed animali sono collegati non solo dall’atmosfera poetica, ma da un’azione multiforme che sgorga da motivazioni lontane (fra le altre il misterioso rapporto di sangue fra Istevene e il vecchio prete): un’azione che, negli inesauribili scatti e imprevisti, ha una sognante mollezza simile a quella di certe danze. Ogni volta che la Deledda prende a narrare in questo tono, è difficile che non trovi un riflesso di tali bellezze. Un che di violento ed insieme assorto, d’ardito eppur soave, induce nell’ondulazione della pagina il presentimento di novità sempre in punta di sbocciare. In questo, pochi scrittori seppero serbarsi giovani come lei, che lo fu fino all’ultima riga del romanzo ‘Cosima’, rimasto incompiuto.
All’incirca a metà della sua carriera, quando da poco aveva pubblicato ‘Chiaroscuro’ e ‘Canne al vento’, non poteva sfuggire che, nell’organismo della sua arte, qualche cosa andava modificandosi, benché di tale mutamento non fosse agevole prevedere i risultati, e nemmeno indicare approssimativamente la direzione. In ‘Marianna Sirca’ (1915) si direbbe che Grazia Deledda voglia riepilogare i grandi temi del suo giovanile romanticismo biblicheggiante: l’amore peccato, l’amore-rimorso, per approfondirne musicalmente l’espressione lirica. In confronto, per esempio, a ‘Elias Portolu’, l’azione appare sfocata. Il linguaggio cresce d’esaltazione; ma se può illuminare d’un vivido tratto qualche segreto movimento delle anime, si dimostra poi inadeguato alle esigenze di un’arte in cui avrebbero dovuto conciliarsi, anzi reciprocamente potenziarsi, analisi e lirismo. Né basta: non del tutto respinto, la Deledda ha smorzato ed oppresso d’ombre il gemmante colore di quei suoi quadri e paesi in ‘Colombi e sparvieri’, ‘Chiaroscuro’ e ‘Canne al vento’. Grazia proponeva grandi temi con effettiva passione e comunicatività, con un moralismo d’intenzioni e di derivazioni, andava sempre più risolvendo con una creatività morale che è respiro e vera poesia.
È stato detto che i personaggi della Deledda esistono appena nel lampo d’una apparizione. Ecco invece ne ‘La Madre’ (1920) che, dopo ‘Marianna Sirca’ è un’altra delle sue pitture più in nero: ecco i due protagonisti fronteggiarsi ostinatamente come in una tragedia antica, ingigantiti dalla solitudine, e incatenati sulla scena da un capo all’altro del libro. Questa storia d’un giovane parroco, ribelle al proprio voto e fatto schiavo a una donna, mentre la madre esce di senno e poi muore a causa della paura dello scandalo e a causa dell’ossessione che il figlio sia dannato. Le pagine della Deledda scorrono chiare, e ogni cosa trascorre in una corrente di emozione, più o meno vaga, più o meno realizzata, dentro una nebbia naturale di sensazioni che avvolge ogni cosa. Ne ‘Il segreto dell’uomo solitario’ (1921), e in ‘Colombi e sparvier’i ed in tanti altri racconti dell’era primaverile, la Deledda trovava e ritrovava il segreto della sua felicità più alta rifacendosi a modi trasognati, volubili. Un’insolita finezza che era fusione stilistica perfetta. Si leggeva nei suoi libri la giocosità, i colori ed un senso quasi di campagne soleggiate. Nei nuovi romanzi questi colori brillano in un’atmosfera magicamente rarefatta. Le leggi del suo comporre sembrano ormai quelle d’un musicale divertimento, con saggezza patriarcale. Un bel premio toccato alla sua bontà, alla nobiltà della sua vita, alla sua esemplare operosità. Le motivazioni del suo Premio Nobel, “for her idealistically inspired writings which with plastic clarity picture the life on her native island and with depth and sympathy deal with human problems in general”. Nell’ultimo periodo della sua vita, esce ‘Annalena Bilsini’ e Il vecchio e i bambini dove indossa i panni del vecchio che tutto sa della vita ed è indulgente verso chi la inizia. Tornano folklore sardo e solitudine della Barbagia tra indulgenza, levità e favola. L’assiste lo stile e la sorregge il realismo antico. ‘Cosima’ è l’ultimo lavoro e uscirà postumo. Grazia Deledda muore il 15 agosto 1936 a Roma, dove ha tanto vissuto. Lascia qualche scritto di teatro, poesia, saggistica, un mirabile lungo viaggio attraverso 50 opere di prosa: romanzi, novelle, fiabe.
































































































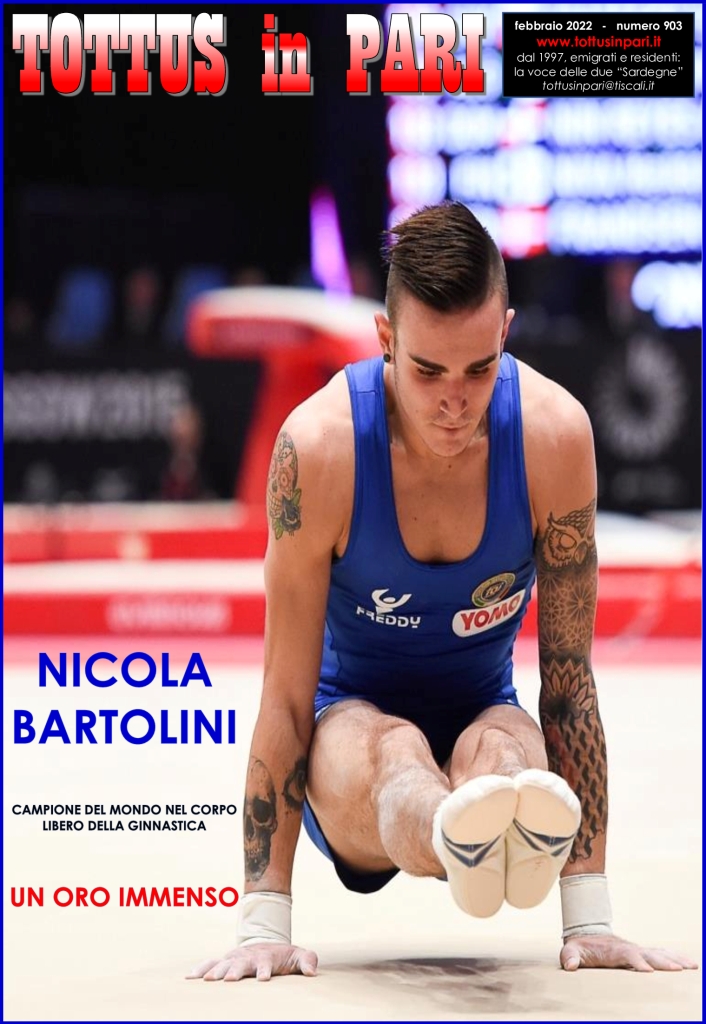








senza tema di smentita
Non era nata il 27 ma il 28.
Grandissima donna!!!