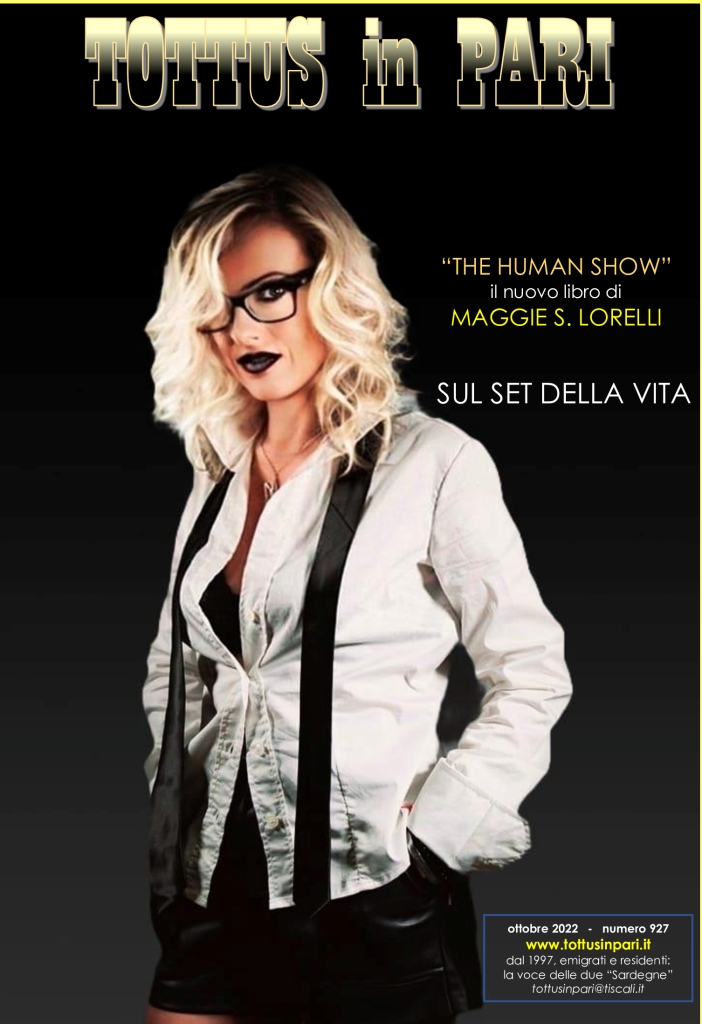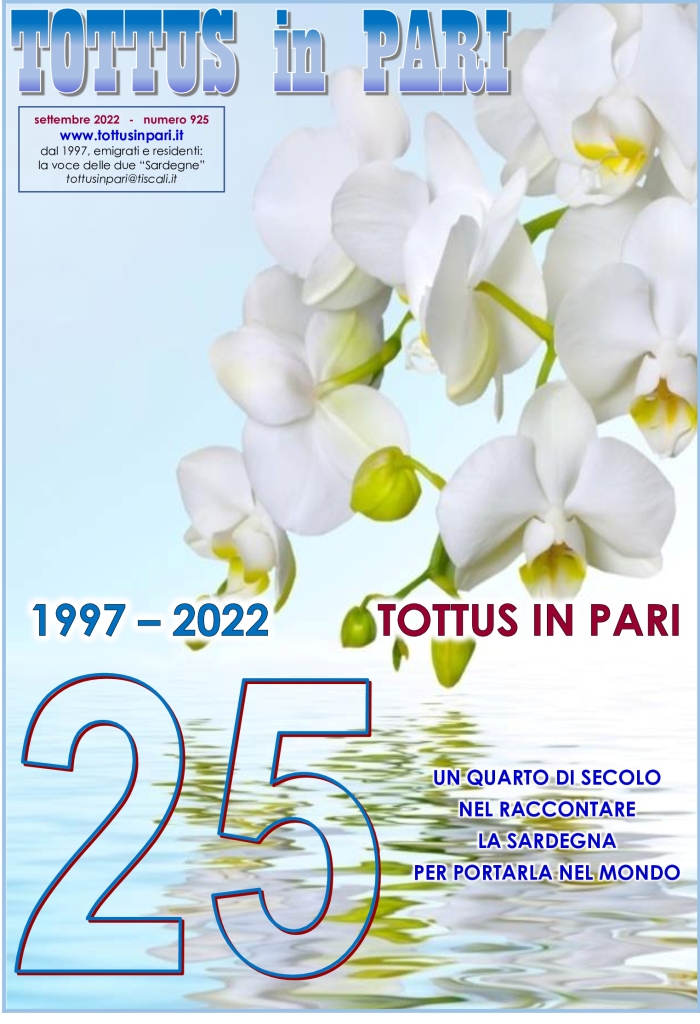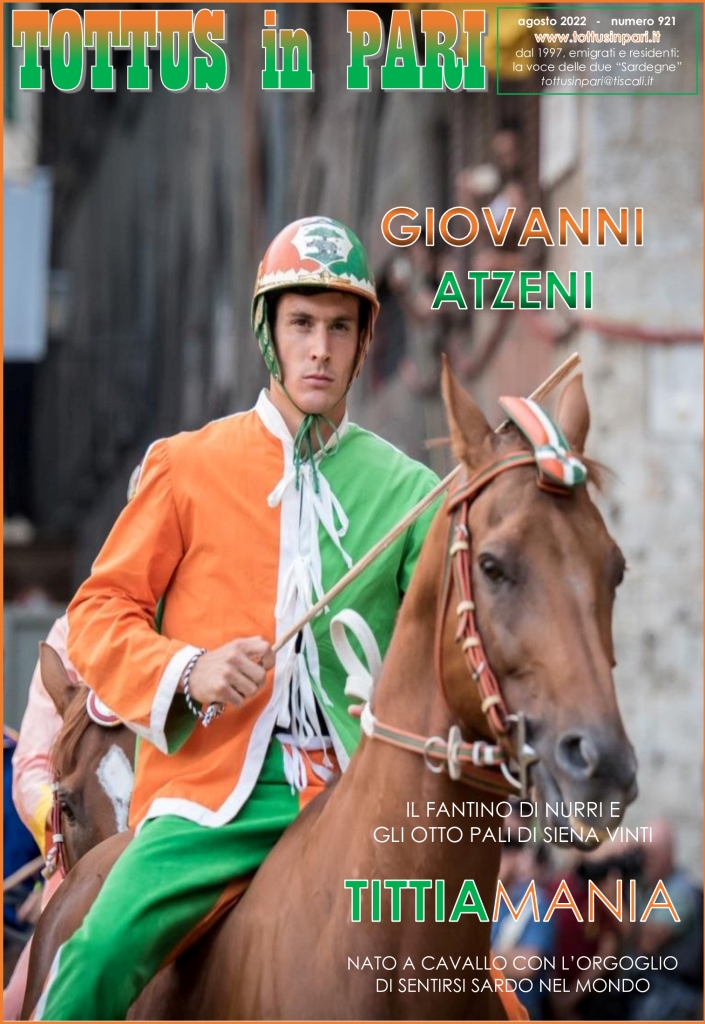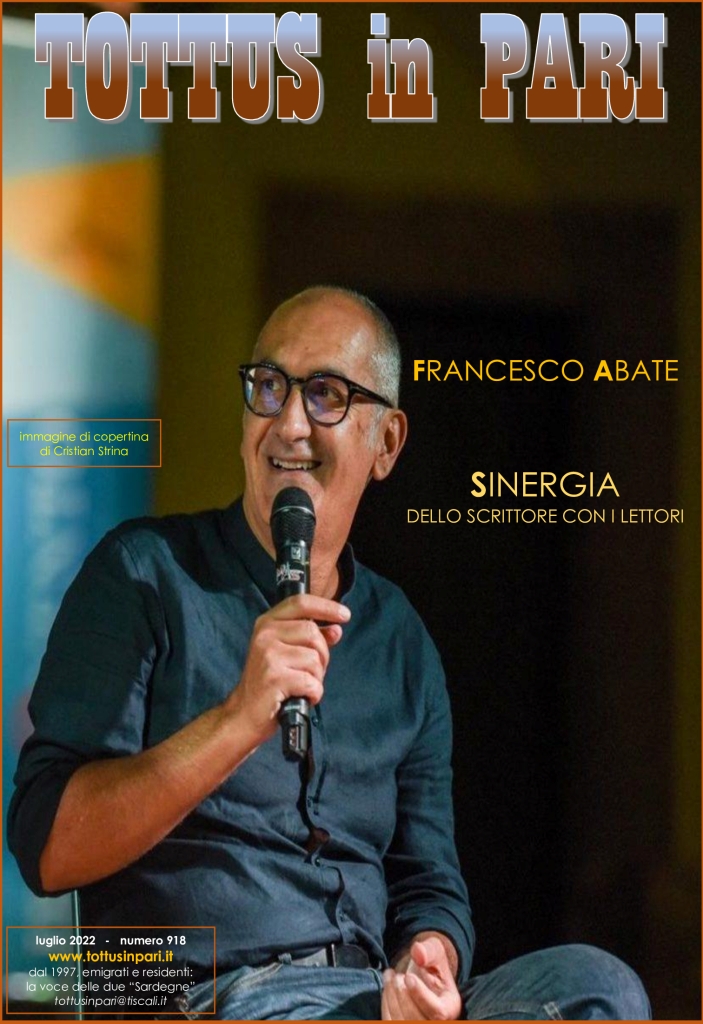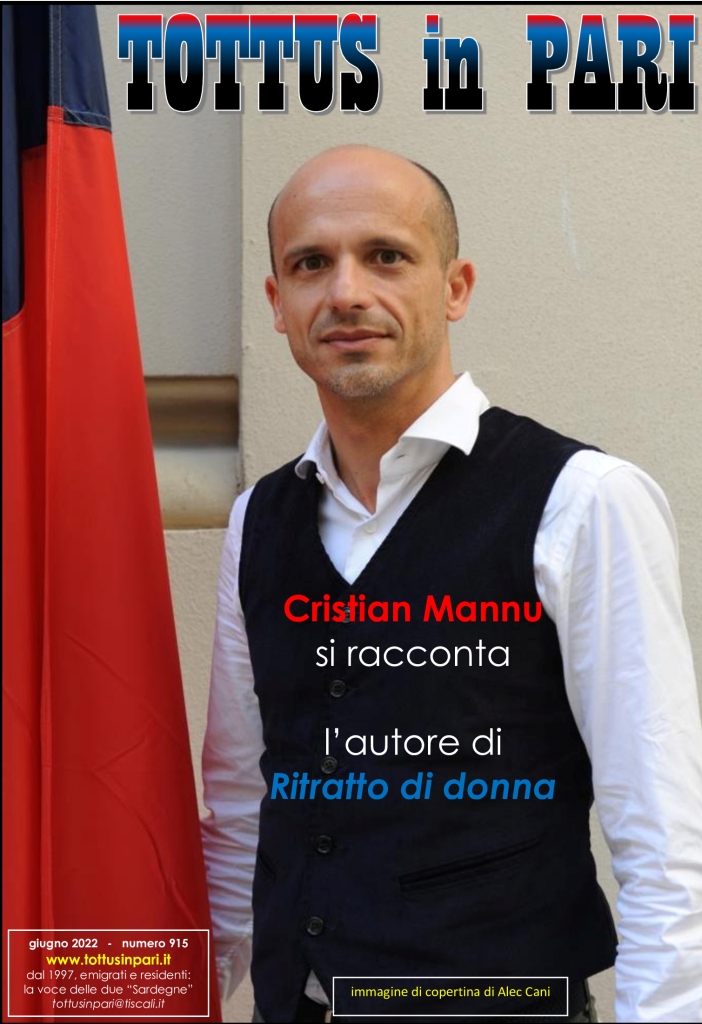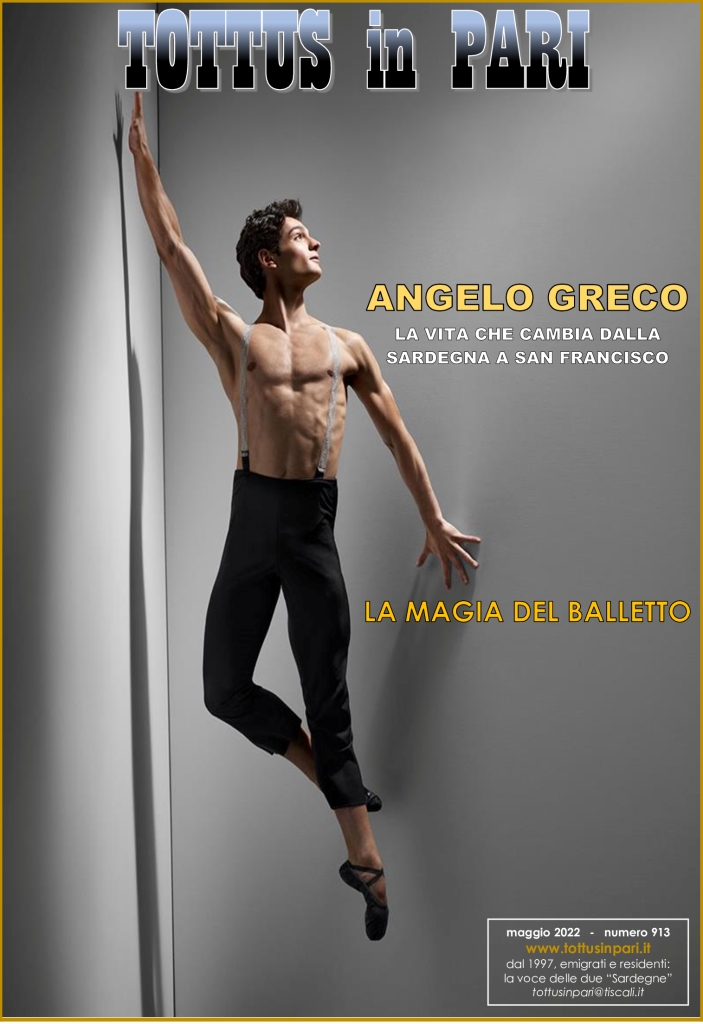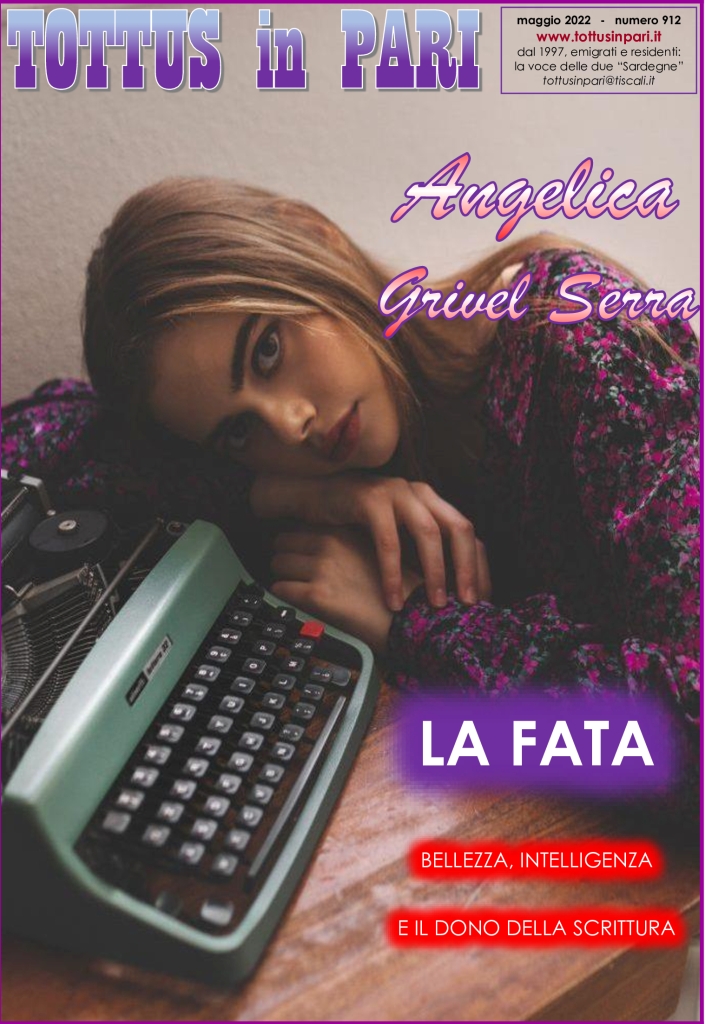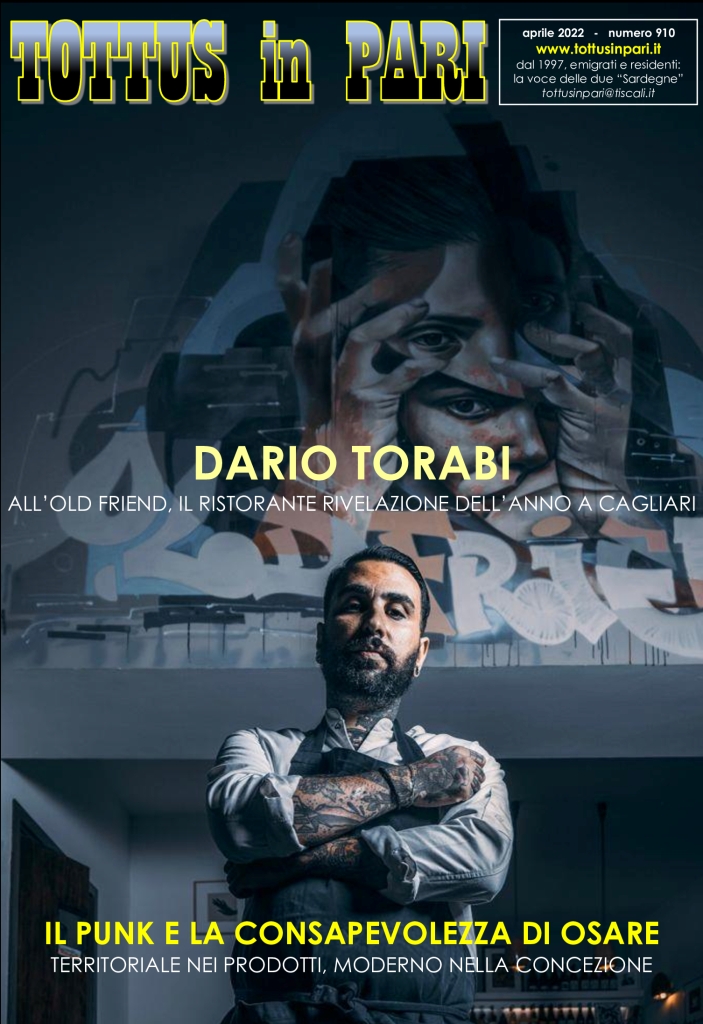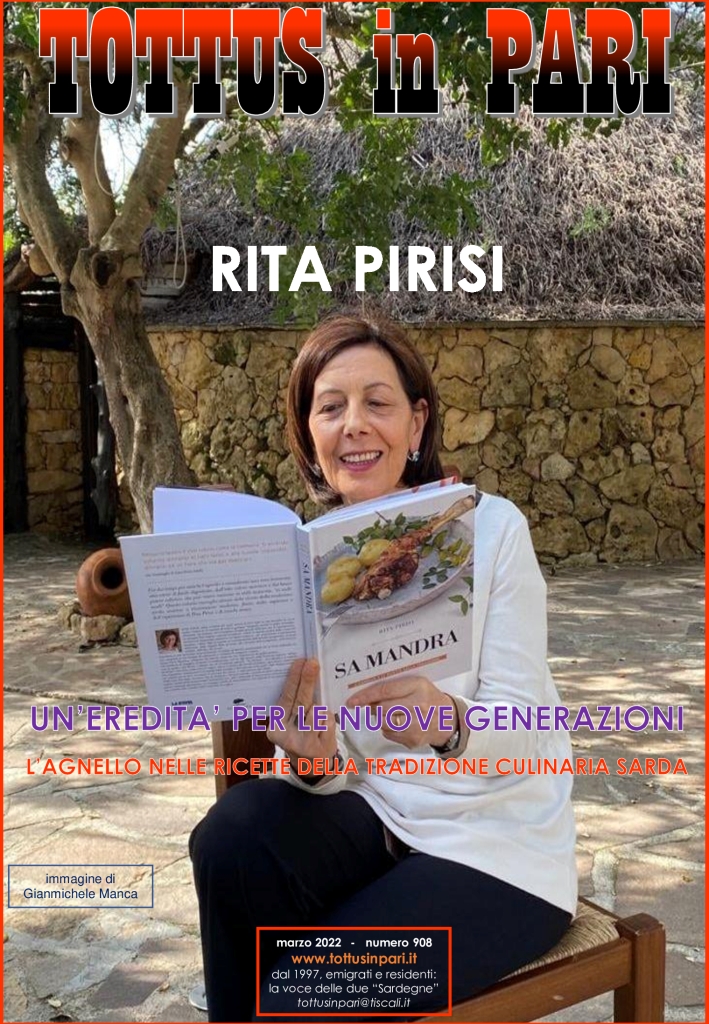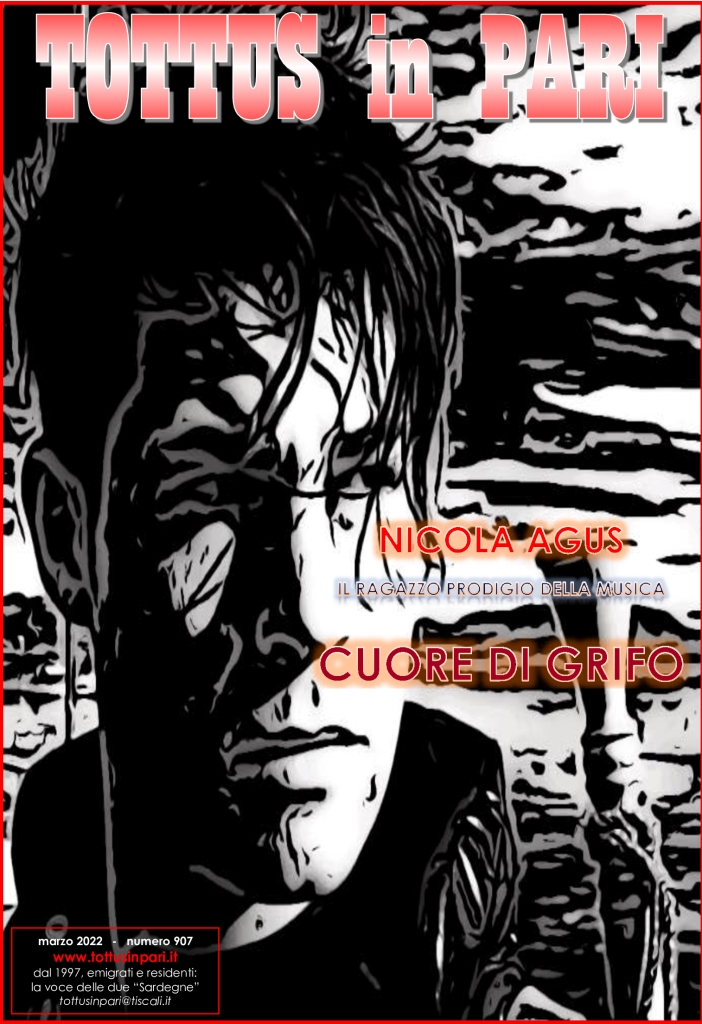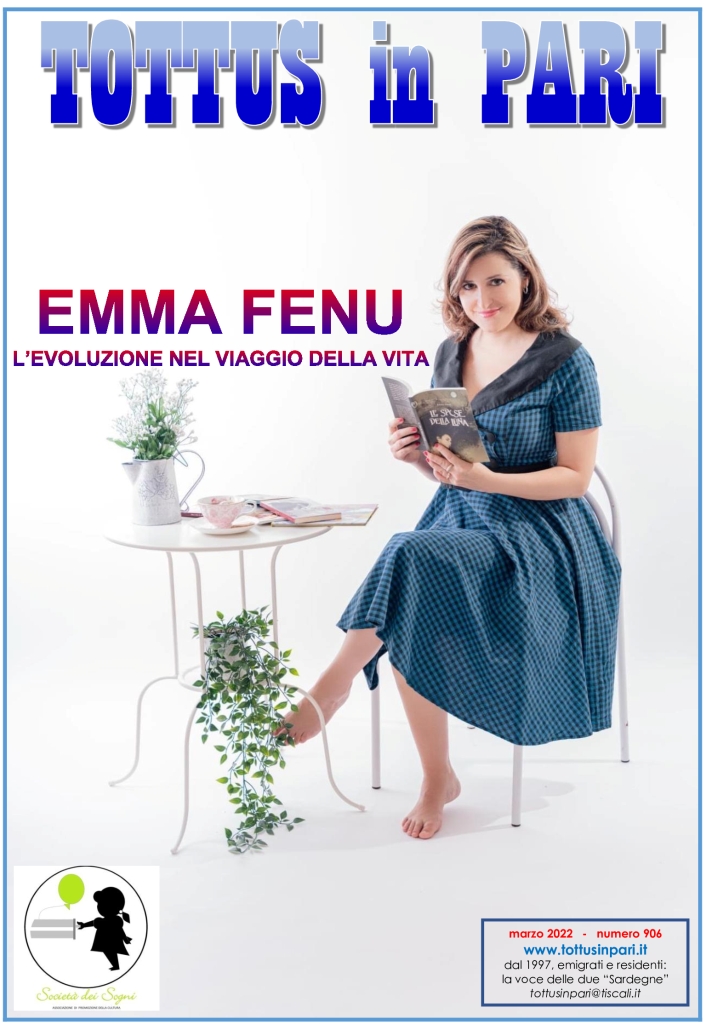Didascalia: da sin. Giovanni Antonio Cocco, l'Assessore Virginia Mura, Serafina Mascia, Giacomo Serreli, Franco Siddi, Bachisio Bandinu (foto di Bastianino Mossa).
di Paolo Pulina
Il cibo quotidiano in Sardegna vuol dire prima di tutto pane, pane tipico. La Sardegna vanta primati nella produzione di pani tipici: da un recente studio a livello europeo risulta che la Sardegna possiede circa l’80 per cento dei pani tipici italiani, il restante 20 per cento è presente in prevalenza nell’Italia del Sud.
Quando ho letto che, sulla base di questi dati, la Regione Sardegna prevede la possibilità di proporre la candidatura a patrimonio immateriale dell’umanità all’Unesco dei pani tipici sardi, mi è venuta in mente una pagina delle “Lettere dal carcere” di Antonio Gramsci che ben descrive come un emigrato (un po’ speciale, per la verità) apprezzi il sapore del pane fatto nell’isola di origine.
Il 29 dicembre 1930 scrive alla sorella Grazietta: «Il giorno di Natale ho ricevuto il pacco. Di’ alla mamma che tutto era in ordine e che nulla si è guastato; il pane era ancora fresco e l’ho mangiato con molto gusto: si sentiva il sapore del grano duro sardo molto buono».
Gramsci rimpiangeva anche le leccornie sarde: «kulurzones, pardulas, zippulas, pippias de zuccuru e figu sigada – di quella famosa zia Maria di Tadasuni –, pirichittos» (si veda la lettera del 26 febbraio 1927).
Naturalmente i sapori regionali si apprezzano di più quando mancano, così come succede per l’aria.
Tutti quelli della mia età nati in una famiglia di pastori bramavano su pane comporàu (i panini tipo michetta o il pane tipo miccone) dato che tutti i giorni in tavola c’era il pane fatto in casa (cotto in sa domo de su furru, sa domo de su pane); il formaggino Mio e la mortadella facevano gola più che non il pecorino messo sulle mensole ad asciugare in cucina, più che non le salsicce pendenti dal soffitto. Non parliamo poi della ricotta, scartata sia che fosse fresca sia che fosse stata affumicata sopra graticci di listarelle di canne, nei pressi del focolare.
Anche a me è bastato allontanarmi da casa da Ploaghe per gli studi universitari a Milano e rimpiangere la carne del porcetto arrosto, della pecora bollita, dell’agnello arrostito in occasione delle feste natalizie e pasquali.
In tutte le epoche, ogni semplice emigrato sardo, nato prima o dopo Gramsci, si è portato in testa il sapore del pane carasau e sicuramente anche del primo companatico che lo accompagna, cioè il formaggio pecorino, in un’isola come la Sardegna caratterizzata da una plurisecolare dominanza della civiltà pastorale.
Ebbene, una volta, qualsiasi emigrato non poteva certo rifornirsi in maniera regolare dei cibi sardi della produzione alimentare di base neanche se si era trasferito in una regione della penisola, figuriamoci se era emigrato in un altro Paese dell’Europa o fuori dell’Europa.
Questo oggi è possibile per il ruolo che gli emigrati hanno svolto nel diffondere il consumo degli alimenti sardi nel mondo.
Questo oggi è possibile per il successo che hanno avuto nel mondo coloro che hanno deciso di investire sulla specificità dei sapori della cucina sarda.
Il convegno “Sapori e saperi in valigia: la cucina sarda nel mondo” ha voluto mettere in evidenza questi fattori di diffusione del prodotto enogastronomico sardo nel mondo ma allo stesso tempo ha voluto presentare, in una sede prestigiosa come l’EXPO che ha come slogan “Nutrire il Pianeta / Energia per la Vita”, almeno un elemento – quello della necessità di compilare una Guida ai ristoratori sardi in Italia – di un piano frutto della programmazione della FASI, la federazione dei settanta circoli sardi attivi nell’Italia continentale: si tratta di “Sarda Tellus”, innovativo progetto regionale (approvato dall’Assessorato del Lavoro della Regione Sardegna, che lo ha inserito nel programma dell’emigrazione 2014-2015) inteso a far conoscere e valorizzare i prodotti e le eccellenze agro-alimentari della Sardegna, facendo tesoro dell’esperienza che gli emigrati sardi e i loro circoli hanno maturato e che costantemente dispiegano nella promozione dei prodotti sardi nei luoghi in cui vive e lavora la gente di Sardegna fuori dell’isola.
Nota finale. Alla domanda «Qual è il suo piatto sardo preferito?» il giornalista del “Corriere della Sera” Gian Antonio Stella ha risposto: «Quante settimane ho per rispondere? La Sardegna ha una cucina fantastica, l’unico difetto è che non è molto dietetica. Mi piace il porcetto, i ravioli e tutti i formaggi sardi, vivrei solo di quelli. Se mi domandassero cosa mi porterei in un’isola deserta, senza esitare risponderei i formaggi sardi. Adoro tutti i vini sardi, anche se sono troppo pesanti per la vita che faccio, mi bastano due bicchieri di Cannonau per dormire 15 giorni di seguito. È inutile fare delle classifiche, la cucina e i prodotti tipici sardi sono tutti eccezionali, dal pane carasau alla zuppa gallurese, troppi per fare un elenco completo». Per questa sua dichiarazione (rilasciata gratuitamente) da autorevole testimonial il minimo che qualche Circolo dovrebbe riservare a Stella è un invito: a pranzo e/o a cena!