Sono passata di ruolo in Emilia Romagna e lasciare la Sardegna era stata una scelta.
Dolorosa, forzata e inesorabile… ma pur sempre una scelta.
Ed io ero poco più che una spavalda ragazza che sventolava il vessillo di un destino ancora da costruire.
– Oh Romi’, ma lo sai che nelle province di Aosta, Modena e Asti ci sono moltissime cattedre da assegnare per le immissioni in ruolo? – mi aveva detto un giorno un’amica e collega.
Facevamo parte entrambe della graduatoria che allora si chiamava del “doppio canale”, rientrando così nel novero di quei docenti privilegiati provvisti sia di abilitazione all’insegnamento sia dei 360 giorni di supplenza effettuati all’interno di un triennio. L’inclusione in questa graduatoria, oltre alla prerogativa di non decadere, ci concedeva il vantaggio di esprimere due preferenze per le sedi di destinazione.
– Eddai, perché non facciamo domanda ad Aosta? – mi aveva proposto col tono di una scommessa, ma pronunciata sottovoce come un’orazione.
– Tu sei matta! Io non intendo andare a scuola col gatto delle nevi. –
– E allora in Piemonte, ci sono degli ottimi vini. –
– Ma andiamo in Emilia che si mangia bene e la gente è cordiale. –
Avevamo tirato in aria una moneta, con l’incoscienza e l’azzardo della nostra giovinezza:
Testa = Piemonte. Croce = Emilia.
Dopo qualche mese eravamo piazzate circa al 700esimo posto nella graduatoria della privincia di Sassari e al 35esimo in quella di Modena.
Il nostro reclutamento era avvenuto in anni diversi e in sedi diverse.
Convinte di lasciare la Sardegna insieme e farci forza vicendevolmente, eravamo invece partite in solitudine e disperse in Emilia come due cani randagi.
Ed io me lo ricordo ancora nitidamente lo stato d’animo di quando sono partita, accompagnata dall’insolenza della giovinezza e dalla sicurezza di chi non ha nulla da perdere.
E altrettanto nitidamente ricordo anche quello di quando, nel parcheggio dell’aeroporto di Bologna, avevo poggiato la valigia per terra, mi ci ero seduta sopra e, nascosta dalle auto in sosta, avevo pianto disperatamente. Avvolta dalla solitudine e dallo sconforto di chi, invece, aveva perso ogni punto di riferimento.
Ero giovane.
Avevo genitori giovani e autonomi.
Non avevo un marito e non avevo figli.
Oltre agli affetti e all’amore per le mie radici, non avevo nulla che non avrei potuto temporaneamente barattare per una cattedra a tempo indeterminato.
E, nonostante tutte le condizioni favorevoli, era stara dura.
Ora, grazie a una riforma scandalosa quanto un film porno, questo esilio dei precari non sarà più una scelta.
È una riforma che non tiene conto del fatto che l’età media dell’immissione in ruolo si sia alzata di almeno un decennio e la firma sul contratto di lavoro a tempo indeterminato venga apposta ben oltre i 40 anni, quando i precari hanno abbondantemente percorso per le supplenze le strade della loro provincia.
Abbandonare la propria residenza crea disagi inenarrabili il cui peso specifico è ben superiore rispetto a quello che avevo affrontato io.
Spedire i docenti a diverse centinaia di km da casa equivale a smembrare famiglie, sgangherare equilibri consolidati e drenare le finanze di chi ha uno stipendio già scarno.
Non si tratta di distanze percorribili in un paio d’ore di macchina per poter riabbracciare moglie e figli nel weekend. Significa prenotare traghetti e aerei, aspettare le vacanze di Natale e Pasqua prima di rivedere i propri cari.
Si tratta di avere un discreto gruzzolo da cui attingere in attesa del primo stipendio che, per superare l’iter burocratico del Ministero del Tesoro, arriva dopo quattro o cinque mesi.
Si tratta di abbandonare a sé stessi i genitori anziani o delegarne ad altri la cura, proprio nel momento in cui hanno maggiormente bisogno di aiuto.
E ci meravigliamo se molti docenti, dopo aver ipotecato la loro giovinezza nella formazione, nonostante la gavetta di anni di supplenze fatte qua e là, gettino la spugna e rifiutino l’immissione in ruolo?
Già li sento quelli che hanno sempre le tasche piene di sentenze, dall’alto delle loro inossidabili certezze bianche o nere, che tuonano con voce grave:
– Si va dove c’è il lavoro! –
Ma smettetela, per favore.
Siete lì, armati come sentinelle, a presidiare il confine tra ciò che è opportuno e ciò che non lo è.
Pronti a indossare la divisa del possibile e dell’impossibile solo quando si parla delle vite altrui.
Paradossalmente queste sentenze, incise con lo scalpello, provengono da chi per andare al lavoro non ha mai percorso più di due isolati di strada.
E invece io vi invito a tacere e togliervi il cappello davanti a quei docenti che si turano il naso, mandano giù l’amara medicina e partono con un nodo in gola, rassegnati a qualsiasi sacrificio.
Ma vi invito a togliervi il cappello anche davanti a quei docenti che, dolorosamente e dignitosamente, rifiutano. Facendosi carico delle conseguenze anche emotive di quella scelta, ma che mostrano l’orgoglio di non piegarsi al ricatto di un’assunzione che, anziché un’opportunità, si configura come uno stupro del diritto di famiglia e un attentato alla dignità dei lavoratori.
E, per favore, date un altro nome a ‘sta porcheria di riforma: non chiamatela La Buona Scuola.
Così, per decenza.
http://www.sardegnablogger.it/

































































































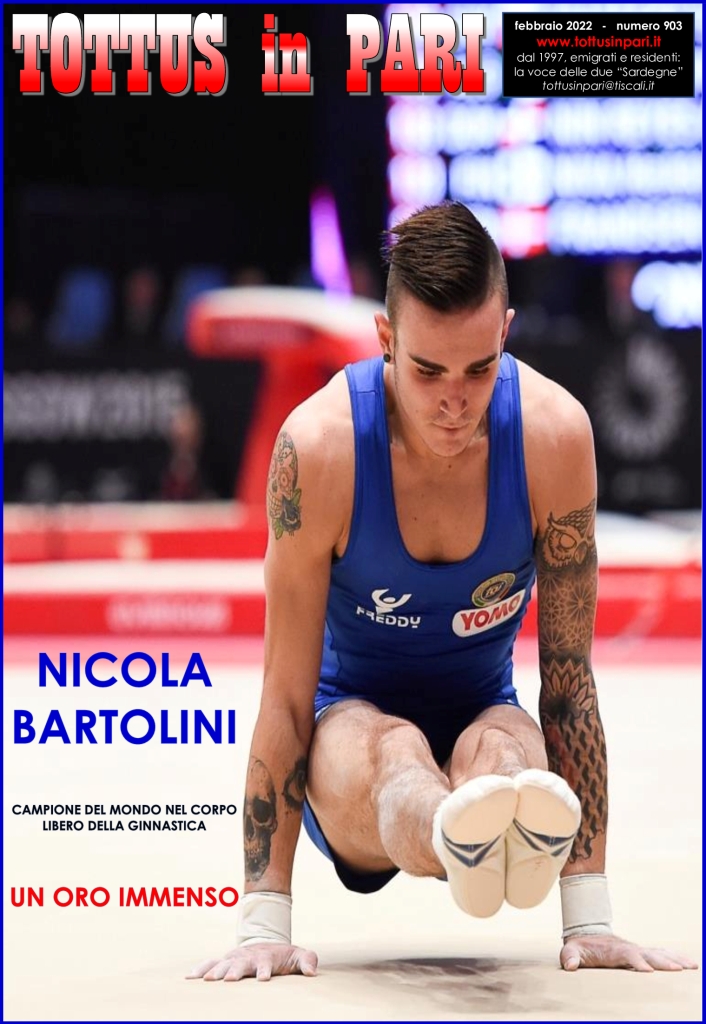








Ciao,io ho lavorato 40 anni come operaio sempre lontano da casa,dice bene chi” raglia” che si và là dove c’è il lavoro,per me è stata molto dura,quante rinunce,se uno non ha la testa forte…molla,quante volte l’ho pensato ma poi pensavo alla famiglia e….. facevo di tutto per dormire perchè era l’unico modo per non farlo……molte persone prima di criticare le persone che rinunciano al posto di lavoro lontano da casa,devono controllare che la loro bocca sia collegata col proprio cervello…..se cel’hanno