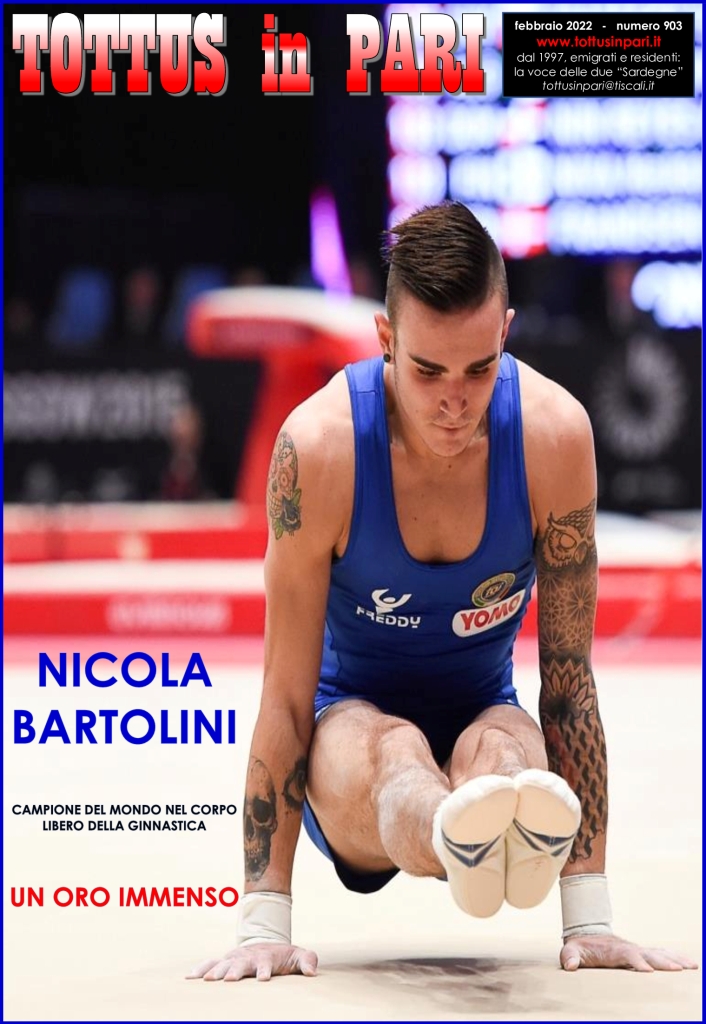Dorgali vista dall’alto appare come un’aquila pronta a spiccare il volo. Un’amena cuspide di paesaggio incontaminato al confine tra Barbagia e Baronia. È tra questi sentieri bucolici che passeggiavano le fanciulle dorgalesi “di bella e gentil carnagione e di certa avvenenza“, come scrivevano Angius e Casalis nella monumentale opera sulla Sardegna di metà ‘800. Fra di loro c’era una fanciulla bella come una benedizione, ma che aveva “un carattere asprigno, si adirava spesso, qualche volta rispondeva senza riguardo, frequentava poco la chiesa, era irascibile e imperiosa; guai a contrariare la sua volontà“, raccontava sua mamma. Era Maù Sagheddu, Maria era il nome che riservava solo alle faccende burocratiche e alle “cose del continente“.
Maù nasce a Dorgali il 17 marzo 1914 da Marcantonio Sagheddu, pastore, e Caterina Cucca, casalinga. È quinta di otto fratelli, anche se il legame più forte sarà, fino alla fine, quello con la sorella Antonia, chiamata Tottona. Il dolore dell’abbandono lacera, dalla più tenera età, i giorni spensierati di Maù; l’amato babbo muore appena cinquantenne, quando lei ha solo cinque anni, stroncato da un’epidemia di Spagnola che le porta via, in breve tempo, anche due fratellini. Il peso della famiglia ricade sulle spalle di tzia Cucchedda, come in paese era chiamata la madre di Maria. La capofamiglia non transige sull’educazione dei numerosi figli e nonostante le mille difficoltà esige che frequentino le scuole. Maù ha un profitto generale straordinario, non andrà oltre la classe sesta, che a quel tempo per le persone di censo modesto è il livello di istruzione più elevato. Non custodisce, tuttavia, la sua preparazione come un tesoro geloso, sono tante le coetanee rimaste indietro negli studi che Maù si offre di aiutare, ad un solo patto: che non si sappia in giro.
Intanto è diventata un’adolescente bellissima. Studia e lavora. Maù è un’abbaresa che come altre fanciulle di Dorgali attinge l’acqua alla fonte pubblica perché in casa non c’è quella corrente. Collabora con gli uomini alla lavorazione del formaggio e con le donne si impegna nella faticosa produzione del pane carasau.
Le sue mani sembrano fatte per lavorare, non per pregare.
L’ambiente familiare in cui la ragazza cresce è profondamente religioso, “La mamma era di messa e comunione quotidiana e ogni giorno recitava il rosario. Questa santa donna, tuttavia, nonostante tutte le cure materne, non sembrava esser riuscita a trasmettere alla piccola i suoi buoni insegnamenti” riporta padre Dionigi Spanu, gesuita dorgalese e più grande studioso della figura di Maria Sagheddu. Maù di parrocchia, incensi, preghiere e genuflessioni non ne vuole sapere.
È burbera, determinata e il carisma della sua autorevolezza cresce assieme alla bellezza esteriore. È un’autentica balente barbaricina, sono tante, infatti, le ragazze che si rivolgono a lei in cerca di protezione, affinché metta una buona parola con gli insegnanti o mitighi i litigi adolescenziali. Lei chiede solo che non se ne diffonda la voce in paese. Più volte, sulla via del rientro a casa, viene vista privarsi dei pochi soldi faticosamente guadagnati dalla giornata lavorativa per donarli a qualche mendicante ancora più povero di lei. Una pietà virile, silenziosa e nascosta.
L’unica volta che venne vista piangere fu durante un contenzioso con mamma Caterina. Cominciavano ad arrivare copiose le proposte di matrimonio da parte di buoni e onesti lavoratori. Caterina vedeva cosa buona nel ‘sistemare’ quella figlia che continuava a sacrificarsi per la famiglia tanto numerosa: era tempo che pensasse a farsene una propria. Con i pochi risparmi messi da parte pensò così di far realizzare il bel costume di Dorgali per impreziosire la bellezza della figlia. Il pomeriggio della festa della patrona, santa Caterina d’Alessandria, all’ennesima esortazione della madre di indossare l’abito elegante, Maù scoppia in un pianto esasperato. Da una parte il dispiacere di fare un torto alla madre tanto premurosa, dall’altra il rammarico legato alle dinamiche di paese per le quali con la sua eleganza avrebbe rischiato di umiliare le amiche che non possedevano nessun abito per la festa. L’epilogo della storia è degno di Maù. Sceglierà di non indossare il costume per condividere con le sue amiche il momento festoso. Non intende in alcun modo sottrarsi all’impegno di far quadrare il bilancio familiare e ancor più di alleggerire le fatiche della cara sorella Tottona. Per ‘le cose di chiesa’ non c’è tempo. Cuce, ricama, tesse con il telaio a mano, va a servizio nelle case delle famiglie benestanti, si reca in campagna a fare il bucato e a trasportare, con estrema fatica, la legna da ardere. Ma le funzioni religiose nessuno deve azzardarsi a nominarle. Non riesce a trovare un’utilità concreta nella preghiera.
Poi qualcosa cambia irreversibilmente nella vita dell’indomita Maù. È il 25 novembre 1932. Durante la festa di quella patrona che lei non ha voluto onorare con la bellezza del suo abito, muore l’inseparabile sorella Tottona. Niente è più come prima. La fragilità dell’esistenza sembra diventare un’ossessione. Siamo a cavallo tra i due conflitti bellici più strazianti che il mondo abbia mai conosciuto. Osserva la sua gente ridotta in miseria, rovesciata come le stoppie dopo la mietitura delle spighe. Nel circondario l’unica istituzione capace di realizzare opere benefiche sono quelle religiose. L’ideale di giustizia che ha sempre avuto cresce dall’interno cambiandola. Decide di far fecondare il prezioso sentimento in qualcosa di veramente utile al maggior numero di persone. Si confronta con il vice parroco don Basilio Meloni che la incoraggia: vuole lavorare al servizio di una comunità monastica. Sceglie un monastero di clausura, il convento dell’ordine delle Trappiste di Vitorchiano, vicino a Roma. Mette la madre di fronte al fatto compiuto.
Ma la vita monastica non è sufficiente a sfogare l’ideale di carità umana che ha dalla più giovane età. Continua a considerare essenziale e grandioso il lavoro caritatevole della Chiesa ma matura la consapevolezza che essa disperda il suo potenziale benefico nei mille rivoli delle diverse confessioni religiose. Maù, che è diventata Suor Maria Gabriella, decide di fare un voto: offrire la propria vita perché Cristo riunisca la Chiesa. Questo orientamento spirituale è ciò che più tardi sarà alla base del movimento Ecumenico moderno che comprende non esclusivamente una conversione ma un dialogo tra le diverse confessioni.
Suor Maria Gabriella divenne rapidamente simbolo mondiale di questa inedita corrente ecclesiale. I primi sintomi della malattia che la uccide, la tubercolosi, si manifesteranno, all’improvviso, qualche giorno dopo la professione solenne del suo voto, proprio durante la settimana che la Chiesa Cattolica destina alla preghiera per l’unità dei fedeli. Il male la divora in una dolorosa agonia che dura poco meno di un anno, fino al 23 aprile 1939.
Alcuni avvenimenti straordinari si accompagnano alla sua morte: le campane suonate a morto vengono udite da tutti con il rintocco festoso della solennità. O ancora il persistente profumo di rose che pervase per un anno esatto dalla morte l’infermeria in cui venne ricoverata. Quella ragazza schiva che non voleva esser fotografata, tanto che esistono solo tre fotografie che la ritraggono, è destinata ad un primato d’eccellenza: “Essere la prima Beata Sarda” come ricorderà Giovanni Paolo II durante la cerimonia di Beatificazione, il 25 gennaio 1983. Fatto ancor più singolare è quello di essere citata e indicata come modello all’interno di un’enciclica (Ut Unum Sint), il documento più importante redatto dal Capo della Chiesa universale.
Maria Gabriella Sagheddu, il cui culto si diffonderà da subito in tutto il mondo, diventerà l’angelo dell’Ecumenismo senza smettere di essere Maù. L’aquila di Dorgali ha spiccato il volo e ha riempito d’orgoglio la terra di Sardegna.
* LaDonnaSarda