
di Omar Onnis
Un grande storico francese, Marc Bloch, morto fucilato dai nazisti durante la seconda guerra mondiale, definiva la storia come la "scienza degli uomini nel tempo".
Scienza, perché, pur non essendo una disciplina matematica, pure ha una sua metodologia, delle regole teoriche e pratiche che rispondono ai principi della validazione e della falsificazione.
Ora, sostenere, come spesso si è fatto e come implicitamente si fa ancora, che la Sardegna non ha storia, laddove si tratta di una terra abitata dagli uomini da almeno dieci, quindicimila anni, è un nonsenso. Se manca qualcosa, in Sardegna, forse è quello studio, quella scienza degli uomini nel tempo di cui parlava Marc Bloch, oppure non è sufficiente. Non mancano certo le vicende e i processi da studiare e da raccontare.
Raccontare, appunto. Questa è la seconda gamba della questione. Oltre allo studio, alla ricerca, all’analisi e alla critica delle fonti, ecc., il compito dello storico è prettamente narrativo. Non nel senso di "romanzesco" (non apro nemmeno la parentesi sui rapporti tra narrativa di finzione e storia propriamente detta, perché ci vorrebbero altri tre incontri come questo per affrontare il tema), ma nel senso che le sue ricerche devono confluire in una narrazione.
Come parte dello stato italiano, la Sardegna vede da centocinquant’anni la propria storia inserita nel quadro della storia d’Italia, sia a livello scolastico, sia a livello accademico, sia a livello divulgativo-enciclopedico. Se però voi vi armaste di santa pazienza e andaste a compulsare manuali scolastici, testi enciclopedici, e storie di Italia in volumi (ce ne sono di diverse estensioni e di diversi tagli editoriali), fareste molta fatica a trovare la Sardegna. Fareste fatica a trovarla anche nei volumi dedicati alla Sardegna! Di solito vi si trova la storia di qualcuno in Sardegna (i romani, gli spagnoli, i piemontesi… gli italiani).
Ora, a me, dopo tanti anni di studio della nostra storia, sembra che anche dove la ricerca qualche passo lo abbia fatto, manchi o sia deficitaria proprio la parte della narrazione.
Questo perché, a mio avviso, uno dei difetti più vistosi della nostra storiografia è la visuale sotto cui essa racconta la nostra storia. Il soggetto narrante non siamo mai noi sardi, ma sempre qualcun altro. Dichiaratamente o meno, la soggettività storica sotto la cui lente ci osserviamo non appartiene mai a noi stessi. Conseguentemente, non potendo rientrare a pieno titolo nella narrazione storica dell’Italia, veniamo tenuti fuori, non veniamo narrati.
Eppure, la storia è indispensabile non tanto per conoscere o addirittura mitizzare il passato (in quest’ultimo caso, è molto meglio non conoscerla troppo bene!), ma per poter comprendere il presente. La storia ci parla sempre di noi stessi, in un modo o nell’altro.
Ora, nel nostro caso questa cosa è così vera da risultare preoccupante.
Facciamo un esperimento. Tracciamo il quadro generale e alcuni dettagli della situazione storica della Sardegna in un dato periodo (non vi dico quale).
– Spopolamento e flussi migratori (ossia, una densità di popolazione molto al di sotto della media italiana ed europea e un flusso in uscita non compensato da un corrispondente flusso in entrata).
– Una situazione economica debole: industrie in mano a società straniere, a grandi monopoli.
– Commercio governato da dinamiche estranee al tessuto produttivo locale.
– Ricatto occupazionale come base indispensabile a mantenere condizioni lavorative pessime e precarie.
– Insufficiente infrastrutturazione, sia dal punto di vista quantitativo, sia qualitativo.
– Mass media controllati da grandi imprenditori in conflitto di interesse e legati a centri di potere esterni all’Isola.
– Una politica votata alla mediazione col potere centrale, senza alcuna capacità progettuale e propulsiva propria.
– Un mondo culturale e artistico ricco di fermenti e aperto verso il mondo, ma in costante e difficoltosa dialettica con i cliché e gli schemi interpretativi applicati da un’ottica esterna.
Potrei continuare, ma il quadro mi pare delineato.
Di quale periodo della nostra storia sto parlando?
Sapete, non so dirvelo nemmeno io. Potrebbe essere la Sardegna di oggi, ma potrebbe essere quella di cento anni fa.
In realtà, potrei anche sottolineare alcuni aspetti che differenziano radicalmente queste due epoche. Per esempio l’alfabetizzazione di massa. Tuttavia, fatte le debite proporzioni, considerata l’alta dispersione scolastica di cui soffre la Sardegna attualmente e la costante spinta all’emigrazione di molti nostri "cervelli", come si dice con una sineddoche un po’ truculenta, e paragonato il tutto con l’indice di alfabetizzazione italiano ed europeo, anche su questo fronte il parallelo tiene più di quanto sembrerebbe.
Il problema che vorrei affrontare qui, con voi, è come sia possibile che in cento anni, in cui di cose nel mondo e anche in Italia ne sono successe parecchie, la nostra situazione sia cambiata così poco.
Proverei, in questa sede, a individuare a grandi linee almeno due ambiti principali, collegati tra loro,
che ci possano dare il senso di quanto è successo e farci capire se ci fossero possibilità diverse oppure no. Quello economico e quello politico.
La Sardegna di cento anni fa, dunque. Cosa succedeva dalle nostre parti cento anni fa? Be’, intanto si veniva da tre decenni abbastanza pesanti.
Negli anni Ottanta dell’Ottocento, la Sardegna aveva conosciuto una certa ripresa economica, grazie al traino del settore agroalimentare e alle esportazioni. Niente di clamoroso, ma un trend favorevole, che poteva essere la premessa per qualcosa di più corposo. Erano tramontate le velleità del primo autonomismo e anche la classe intellettuale e politica era in una fase di rinnovamento. Verso il 1887, ecco la doccia fredda. Sapete che in quell’epoca i vari stati europei – Gran Bretagna e Francia su tutti – portavano avanti le loro guerre coloniali e cercavano di imporre la propria economia e la propria politica sull’intero globo. Nell’ambito delle ripicche economiche tra stati, in un momento in cui erano ancora forti le separazioni doganali tra sistemi nazionali, con dazi, forme di protezionismo, manovre di concorrenza sleale e quant’altro, l’Italia in particolare era in concorrenza con la Francia. Cosa fa il governo italiano di quegli anni, a capo del quale c’era Francesco Crispi? Denuncia (ossia si rimangia unilateralmente) i trattati commerciali con la Francia e, come per magia, la Sardegna finisce KO. Questo perché la Francia era il maggior importatore di beni e prodotti dell’agroalimentare sardo. Come se non bastasse, praticamente in contemporanea esplode una crisi bancaria che si mangia i risparmi di un sacco di famiglie. Una situazione tremenda.
L’agricoltura ne risente moltissimo e persino la pastorizia (pure in perenne crescita in quegli anni) riceve un bel colpo. Chi ne paga le conseguenze sono ovviamente le fasce di popolazione più disagiate. Il primo sbocco della manodopera liberata (diciamo così) da questa crisi è il comparto minerario, in forte sviluppo. Tanta manodopera disponibile fece sì che crollassero i salari (non c’erano le garanzie sindacali che ci sono oggi, ovviamente: ma anche su questo, diciamo che la tendenza attuale è di ritornare verso quella situazione!). E le condizioni di lavoro diventarono semplicemente infernali.
Contemporaneamente si accentuarono i problemi del ribellismo endemico, specie in alcune zone dell’Isola. Il fenomeno del banditismo fu naturalmente relegato tra le questioni di ordine pubblico.
Commissioni parlamentari di inchiesta scrissero interi tomi, a volte illuminanti (come la relazione di Francesco Pais Serra del 1896), ma che rimanevano lettera morta. La politica sarda era dominata già allora da Francesco Cocco Ortu, gran proconsole di Sardegna, pluriministro a cavallo tra i due secoli.
Nel 1897 uscì un libro diventato ben presto un caso pubblico. L’aveva scritto un antropologo positivista della scuola del Lombroso, di quelli che andavano in giro a misurare i crani per vedere di distinguere etnicamente tra le persone e prevedere chi fosse destinato alla subalternità sociale, culturale economica e alla delinquenza. L’antropologo in questione si chiamava Alfredo Niceforo e il suo libro si intitolava La delinquenza in Sardegna. E il famoso libro in cui si teorizza la natura congenitamente delinquenziale dei sardi, specie di quelli dell’interno. Lavoro, purtroppo, santificato dalla sua aura di scientificità e preso per buono – per esempio – anche da una giovane scrittrice sarda di belle speranze, Grazia Deledda (un fratello della quale, per altro, si era fatto un bel po’ di galera – ingiustamente, è ovvio! – per questioni di abigeato…).
Due anni dopo l’uscita del libro, nel 1899, quindi, e dopo la visita in pompa magna della coppia reale sull’Isola (re Umberto e la regina Margherita: erano pur sempre ancora re di Sardegna, ricordiamolo) nella primavera di quell’anno, venne attuata una vera e propria spedizione militare punitiva nelle Zone Interne. Truppe di fanteria reduci dalle spedizioni coloniali in Africa furono inviate a prendere possesso del territorio, fare rastrellamenti, arrestare indiscriminatamente qualsiasi sospetto o, in mancanza, i suoi familiari (comprese donne e bambini). Una missione che venne raccontata in un libro famoso, da uno dei partecipanti all’impresa, l’ufficiale toscano Giulio Bechi. Il suo libro, Caccia grossa, suscitò un certo clamore. Venne esaltato da alcuni, anche in Sardegna, ma venne sonoramente stroncato da altri, come ad esempio il poeta e avvocato nuorese Sebastiano Satta. Nella prefazione dell’ennesima edizione (quella del 1914, se non erro), lo stesso Giulio Bechi dipingeva la Sardegna come una terra esotica, a disposizione di qualsiasi spirito avventuroso: la "nostra Patagonia", la chiamava. Questo, per dire quale fosse l’idea che si aveva allora di noi e della nostra terra!
Quella era l’epoca giolittiana, una fase della storia italiana abbastanza controversa. Portò un certo sviluppo, ma fece crescere la sperequazione tra nord e sud della penisola. La Sardegna venne investita da questo processo di modernizzazione, ma come tutte le province marginali e, nel nostro caso, periferiche, più che altro ne subì gli effetti perversi, a danno della maggior parte della popolazione e a vantaggio degli speculatori e dei capitalisti, quasi esclusivamente non sardi, che ne presero in mano le risorse.
Ma la Sardegna, in fondo, non era una terra così separata e "speciale" come la si dipingeva. Benché i problemi fossero gravi e pressanti, nelle città c’era grande fermento culturale. Il clima internazionale della bèlle èpoque arrivava anche da noi. Giornali, libri, pamphlet circolavano e favorivano lo scambio di idee.
Tuttavia, era in atto una inevitabile scissione tra il sostrato culturale popolare (la cui matrice fondamentale si può individuare nella lingua sarda) e le sovrastrutture culturali generate dalla prima alfabetizzazione e dal contatto dei nostri intellettuali con i loro colleghi italiani, sovrastrutture che si alimentavano di e
lementi esterni, in primis la lingua italiana, veicolata dalla scuola e dalle università. Una scissione complicata (che trova espressione chiara e anche umanamente toccante in molte pagine di Antonio Gramsci, per esempio), difficile da metabolizzare da parte dei sardi stessi.
Le difficoltà e le contraddizioni della vita quotidiana produssero inevitabilmente conseguenze macroscopiche di natura anche politica, oltre che sociale.
Buggerru e Cagliari (1904-6)
L’industrializzazione, che in questa fase significò come abbiamo detto soprattutto crescita del settore estrattivo, produsse conflitti tra lavoratori e padronato.
Nel settembre del 1904, come molti di voi sapranno, una protesta dei minatori di Buggerru per le pessime condizioni del lavoro e l’esiguità dei salari, sfociò in una repressione militare che fece due morti e molti feriti tra i lavoratori. L’episodio è uno dei pochi eventi sardi ricordati nei manuali storici italiani perché provocò il primo sciopero generale della storia italiana.
Ma non era solo il mondo del lavoro operaio a soffrire. I processi produttivi e distributivi di quel periodo, con monopoli, protezionismi incrociati e un implacabile regime di dazi, praticamente immobilizzavano la Sardegna in una morsa di sfruttamento e di subordinazione agli interessi di pochi grandi capitalisti.
Nel 1906, a causa dell’alto prezzo dei beni di prima necessità – e del pane in particolare – esplosero rivolte sia a Cagliari e nel Campidano, sia nei centri di produzione casearia. Un grande fermento popolare, non guidato politicamente, né sorto da una elaborazione teorica di qualche tipo. Solo, attraverso i canali consueti della socializzazione (bettole, piazze, mercati, vicinati), si era diffuso capillarmente un sentimento di avversione verso i responsabili della situazione, che allora erano individuati in particolare negli speculatori stranieri, specialmente italiani.
Il motto che passava di bocca in bocca (come ricorda lo stesso Gramsci) era: "a mare sos continentales!".
Le rivolte del 1906 vennero soffocate nel sangue, naturalmente. Non esistono stime definitive, ma si calcolano almeno 14 morti e decine e decine di feriti ad opera dei soldati.
Ma il malcontento non si arrestò di certo. Alcune pubblicazioni anonime usavano una nuova parola d’ordine: emancipazione. E intendevano chiaramente la separazione dall’Italia. Mentre giovani intellettuali cercavano di elaborare in forme teoriche e politiche queste manifestazioni di scontento popolare, la classe dominante sarda (impersonata dal proconsole Cocco Ortu) tentava di tenere a bada la situazione, rivendicando concessioni da parte dello stato centrale o soluzioni legislative speciali. Qualcosa si fece, ma certamente, dato il tipo di approccio tipicamente top-down (di questo riparleremo fra poco), e la necessità di garantire i profitti del sistema produttivo vigente, la situazione non cambiò affatto.
L’emigrazione
Uno degli esiti della crisi fu l’emigrazione. Non solo dalla Sardegna, bisogna dire. Le regioni povere dell’Italia, anche del nord (pensiamo al Veneto, per esempio), conobbero un flusso migratorio costante e di enormi dmensioni in quegli anni. La destinazione dei sardi era prevalentemente l’Argentina. Tale fenomeno proseguì ben oltre il 1920.
La Grande Guerra
Nel 1914, vicino a Roma, ci fu un grande raduno di politici e intellettuali sardi: si cercava di trovare e condensare una prospettiva politica unitaria per sollevare la questione sarda al livello di stato centrale (nazionale, si diceva, ove per nazionale si deve intendere italiano).
Grandi discorsi, grandi enunciazioni e tanto entusiasmo.
Ma non ci fu il tempo di concretizzare nulla. Scoppiò la prima guerra mondiale e, come sapete, dopo qualche tentennamento (al solito!), anche l’Italia entrò nel conflitto, trascinandosi dietro la Sardegna.
Lasciamo perdere la retorica sulla Brigata Sassari, ecc. Io so che mio nonno paterno, classe 1898, ferito sul Carso (e per questo salvatosi dalla carneficina dei suoi commilitoni), non ha mai voluto parlare in tutta la sua vita di quell’esperienza. Mai. Passando dalla cronaca familiare alla storia generale, dobbiamo ricordarci che la Sardegna pagò un prezzo altissimo alle fantasie di gloria di Vittorio Emanuele III e dei suoi generali. Intanto, su una popolazione di circa 800 000 abitanti, ne partirono 100 000: più del 10% dell’intera popolazione! Di questi, non tornò più indietro il 13%. Consideriamo che la media italiana delle perdite fu del 10%. Ecco da dove viene la retorica del sacrificio, della riconoscenza che i reduci dal fronte chiedevano allo stato centrale. E questo, solo per quanto riguarda gli arruolati. Bisogna pensare a cosa significò per una terra ancora largamente a vocazione agricola e pastorale vedersi strappare per anni tutti i giovani maschi in salute. Un collasso sociale e antropologico, oltre che economico.
Il PSdAz e la scelta autonomista
Chi tornò dalla guerra aveva comunque le idee un po’ più chiare su se stesso e sul mondo. Questo dobbiamo riconoscerlo.
I leader dei reduci dal fronte si resero conto immediatamente che avevano dietro di sé una grande forza popolare. Specialmente Camillo Bellieni, di Sassari, promosse la maturazione politica del movimento. Ma ne incanalò le energie in una formula che tutti conosciamo perfettamente: l’autonomia. La guerra non era ancora nemmeno finita, che usciva in Sardegna un pamphlet con questo titolo: "Per l’autonomia!". L’orizzonte in cui i capi del movimento dei reduci iscrivevano le istanze emancipative dei sardi era quello: chiedere un riconoscimento particolare e concessioni legislative ed economiche all’Italia in virtù del sangue versato nelle trincee. Un patto fondato sul lutto, quindi.
Ma i reduci e le loro famiglie non avevano questa idea. La stragrande maggioranza di loro si aspettava di vedere realizzate quelle parole d’ordine che solo pochi anni prima circolavano di bocca in bocca: a fora sos con
tinentales, emancipazione.
Lo stesso Bellieni spiega in un suo scritto che, a fronte del diffuso sentimento "separatista" (allora si diceva così, in termini spregiativi), loro (ossia, lui Lussu e gli altri leader) dovevano accollarsi il difficile compito di far accettare una soluzione così complicata e in un certo senso contraddittoria come l’autonomia. Bellieni era quello che diceva di sentirsi grato all’Italia perché aveva estratto i sardi dal buio della loro storia barbarica, con la luce della sua civiltà (proprio così!). Era quello che descriveva i sardi come una nazione "abortiva", ossia, non abortita, morta, ma proprio produttrice di morte.
Ecco come nacque il PSdAz. Su queste basi di rivendicazione e di ammissione di subalternità e in conflitto esplicito con qualsiasi pulsione indipendentista.
Fatto sta che alle elezioni del 1921 (che non erano a suffragio universale, ma già a suffragio allargato) il PSdAz prese una cosa come il 36% dei voti: un’enormità.
Si trattava di un partito di massa che poteva certamente guidare la Sardegna verso un processo di emancipazione politica. Dovete pensare che proprio quello stesso anno (il 1921) l’Irlanda otteneva dalla Gran Bretagna il primo riconoscimento di sovranità. Aveva dovuto pagare un tributo di sangue notevole e una pesante lacerazione della propria società. In Sardegna c’erano le conseguenze della guerra, ma nessun conflitto aperto. Nel parlamento italiano si parlava diffusamente di una soluzione irlandese per la Sardegna. Dovette intervenire personalmente Emilio Lussu, eletto deputato, per stroncare qualsiasi allusione (e, in Sardegna, illusione) che il successo del PSdAz significasse l’inizio di un percorso di indipendenza.
Di lì a tre o quattro anni, la maggior parte del PSdAz trasmigrò nel Partito Nazionale Fascista. Ma in fondo la cosa non era del tutto contraddittoria con le premesse teoriche su cui era stato fondato.
Lussu ne uscì e divenne un leader dell’antifascismo italiano.
Oggi
La nostra disamina può terminare a questo punto.
Cosa c’è di attuale di quanto descritto fin qui?
Alcune strutture di fondo sono rimaste – ahinoi! – invariate. Prima accennavo all’approccio politico ed economico di tipo top-down. Ebbene, questo è una caratteristica di lunga durata della storia contemporanea sarda. Ne parla, ad esempio, un articolo, comparso nel 2003 su una rivista internazionale di studi politici ("European Planning Studies"), scritto da un ricercatore olandese, Gert-Jan Hospers. In quest’articolo, l’autore solleva in particolare il problema delle conseguenze negative provocate da tale approccio dall’alto in basso.
Significa che tutte le decisioni e le misure sia di carattere legislativo sia concrete riguardanti la Sardegna sono state prese fino ad oggi da un’entità sopraordinata ed esterna, senza partire dal basso e dal territorio, né coinvolgerlo nella formulazione delle decisioni. Era già una caratteristica della politica sabauda, almeno dalla metà del Settecento, ed è proseguita lungo tutto il corso della nostra storia.
Pensiamo solo, già in pieno XX secolo, alla famosa legge del Miliardo, concessa nel ’29 dal regime fascista. O ai Piani di Rinascita, tra anni Sessanta e Settanta. E pensiamo a quanto sta succedendo sotto i nostri occhi: politici e lavoratori sardi che accorrono a Roma a pregare che il governo italiano risolva la crisi (ineluttabile) del nostro comparto industriale.
All’articolo di Hospers abbiamo risposto io e Olive Perra con un pezzo uscito nel settembre del 2009 sulla stessa rivista internazionale, ampliando il discorso e introducendo la questione (che Hospers affrontava indirettamente e un po’ implicitamente) della sovranità come alternativa in qualche modo necessaria a tale tipo di approccio fallimentare.
Perché di fallimento dobbiamo parlare.
Badate bene, la concessione dell’autonomia regionale non ha mutato in nulla tale rapporto sbilanciato e patologico. Anzi, se possibile ne ha peggiorato alcuni effetti. La ricercatrice politica scozzese Eve Hepburn dichiara apertamente, in un suo articolo del 2008, uscito su un’altra rivista internazionale, che l’autonomia sarda è stata ed è tutt’ora una autonomia "di facciata".
La situazione grave e per certi versi poco dignitosa in cui ci troviamo attualmente è dunque figlia di processi e strutture ereditate dal passato.
In anni recenti sembrava che si fosse in qualche misura rovesciata la tendenza, grazie alla mobilitazione degli anni 2003 e 2004 contro l’ipotesi nucleare in Sardegna, che servì da trampolino di lancio per l’avventura di Renato Soru. La sua vittoria alle elezioni del 2004 e le parole d’ordine con cui la cominciò e la portò avanti almeno per i primi due anni sono stati indubbiamente una rottura evidente col passato. Veniva evocata, per la prima volta nella storia sarda recente, una nostra soggettività politica a sé stante. La cosa è finita male, e ancor prima delle deludenti (per Soru) elezioni del 2009. Già la sua scelta di accollarsi i rifiuti campani, al di là della solidarietà umana con quelle popolazioni, era un errore politico madornale. Il suo ingresso nei ranghi di un partito italiano come il PD, per altro abbastanza avverso a qualsiasi discorso men che centralista, è stato l’altro passaggio decisivo. E tutto è rientrato nei ranghi.
Consideriamo ancora il settore delicatissimo dei mass media. Cento anni fa c’erano già i giornali. C’erano L’Unione e la Nuova, proprio come oggi, ed appartenevano a gruppi editoriali o singoli editori non sardi, con interessi economici variegati. Il proprietario dell’Unione era il grande monopolista del comparto minerario sulcitano, per dire.
Oggi, le due maggiori testate sarde appartengono una (la Nuova) a un gruppo editoriale italiano (La Repubblica – L’Espresso), l’altro a un imprenditore immobiliare molto vicino all’attuale presidente del consiglio italiano. Il terzo quotidiano sardo (Il Sardegna) è la testata sarda di un gruppo italiano (e-polis), che pubblica giornali locali (a livello regionale o provinciale). Come si vede, il campo dell’informazione a grande diffusione è in mani come minimo sospette (al di l
à della serietà di qualche giornalista che lavora nelle varie testate: ce ne sono, chiaramente).
Il rapporto strutturale tra Sardegna e Italia non è affatto mutato, in cento anni. Siamo sempre e inevitabilmente una periferia, lontana e marginale, di uno stato più grande. I Sardi rappresentano poco più del 2% della popolazione italiana. Nella maggior parte delle rilevazioni demoscopiche i sardi non sono presi in considerazione. (…) Siamo il 2% di qualcun altro.
Ed è così. In termini quantitativi, statistici, e dunque come peso elettorale, rappresentiamo questo.
Se sommiamo questo dato alla distanza geografica, diventano chiare certe situazioni che a noi fanno gridare allo scandalo, ma che in realtà sono assolutamente inevitabili.
Consideriamo altri numeri: consideriamo le strade. Abbiamo detto che cento anni fa la Sardegna soffriva una pesante carenza. Vediamo oggi.
C’è una cosa che si chiama indice infrastrutturale. Un numero che indica quanto una posto è infrastrutturato. In questo caso parliamo di strade. Se consideriamo l’indice infrastrutturale stradale italiano pari a 100, nel 2001, quello sardo nello stesso anno era pari a 63. In Sardegna la rete stradale era deficitaria, rispetto alla media italiana. Nel 2007, sempre considerando 100 l’indice italiano, quello sardo era sceso a 43! Erano state distrutte le strade che c’erano già in Sardegna? Ovviamente no. Solo che sulla penisola nel frattempo erano proseguiti gli investimenti in questo settore (nonostante il periodo di vacche magre), in Sardegna non era stato fatto nulla. Il motivo? L’ostilità degli italiani? No di certo. Lasciamo stare le recriminazioni. Il problema, ripeto, è strutturale. L’Italia, come stato, deve pensare ai propri cittadini e al proprio territorio. Se deve scegliere come indirizzare gli investimenti non può privilegiare il 2% della sua popolazione a discapito di tutto il resto. Questo è un dovere i qualsiasi politico italiano. Anche se il politico italiano è sardo! Molti si stupiscono della circostanza che la Sardegna, pur avendo espresso tanti politici ad alto livello in Italia, non ne abbia mai ricavato conseguenze positive. Ma la riposta è semplicissima: se sei un politico italiano, benché nato in Sardegna, farai gli interessi dell’Italia. E’ giusto così!
La politica favorevole alla Sardegna devono (dovrebbero) farla i sardi in Sardegna e per la Sardegna, senza aspettare che sia l’Italia a risolvere i nostri problemi. Quello sarebbe il famoso approccio top-down di cui abbiamo parlato. A noi interessa creare un approccio bottom-up, che faccia emergere le forze e le risorse della Sardegna e le porti a maturazione.
Per riuscirci – e qui viene la parte più politica di questa chiacchierata – le condizioni storiche, economiche e geografiche ci impongono la via della sovranità e dell’indipendenza politica. La storia, a mio avviso, è molto chiara, a questo proposito. Ma non è un destino ineluttabile. Bisogna lavorarci su. Cento anni fa prevalse il compromesso autonomista, la paura (o la certezza) di essere un popolo minus habens, inferiore agli altri, non all’altezza del compito. Oggi, possiamo guardare a noi stessi con maggiore equanimità, senza nasconderci difetti e magagne e nemmeno esaltarci in celebrazioni identitarie o nazionaliste fuori tempo massimo.
Naturalmente, spetta a noi lavorare perché questo percorso prenda corpo e si sviluppi nei termini più inclusivi e democratici possibili. Credo che valga la pena provarci. Almeno non dovremo dire ai nostri figli e nipoti che sapevamo e non abbiamo agito, che eravamo qui e non ci siamo assunti le nostre responsabilità.
Dobbiamo cogliere le occasioni che la storia ci porge. Naturalmente, passando sulla terra leggeri.





























































































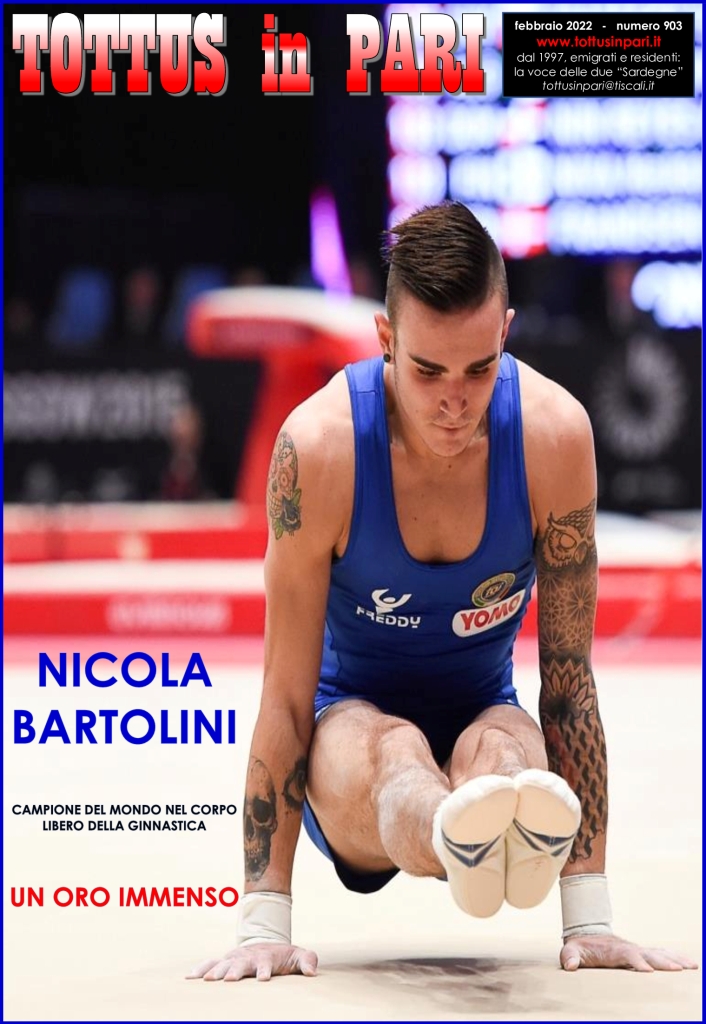











Che cosa triste e patetica fare circoli di immigrati sardi…
Nessuno deve essere straniero da nessuna parte, il mondo è di tutti, è uguale per tutti, ma purtroppo è l’ignoranza che crea le diversità.
Svegliamoci, non esistono lombardi, sardi, siciliani, esistono uomini con abitudini differenti, date dal luogo in cui si sono evoluti. Ma sempre della stessa merda di carne e di sangue si tratta. Sveglia.
Signor Mush, per uno che crede di essere UOMO di/del MONDO e Sveglio (ma non ha il coraggio di firmare con il suo nome) potrebbe almeno spiegarci per quale motivo questi circoli la disturbano, e anche dove l’ha visto questo mondo di TUTTI e uguale per TUTTI. Grazie!