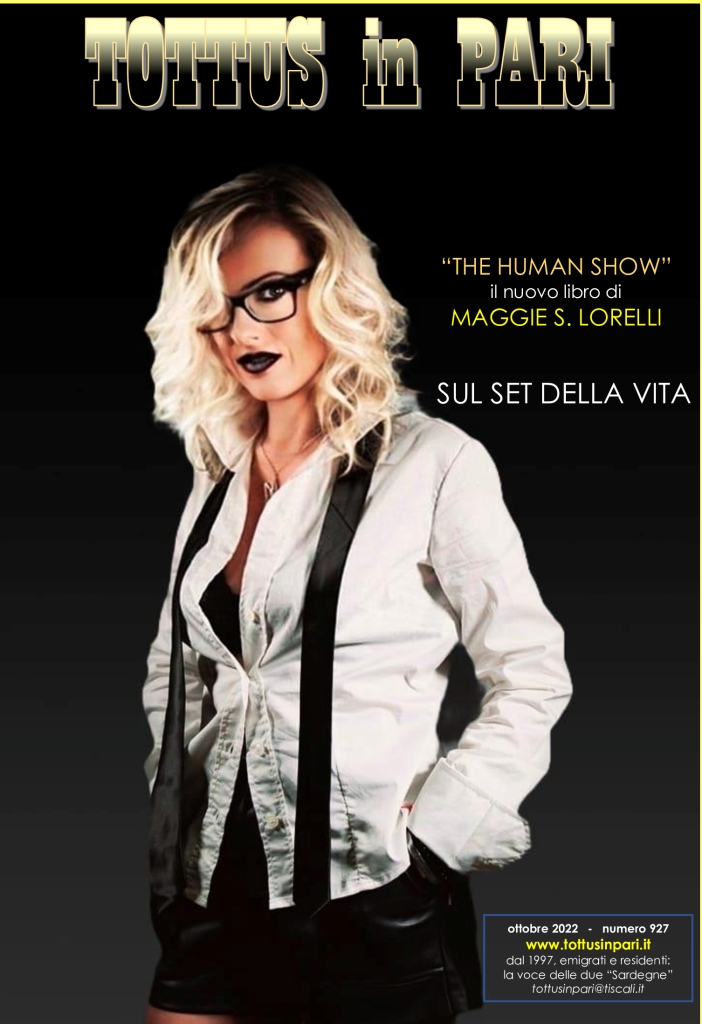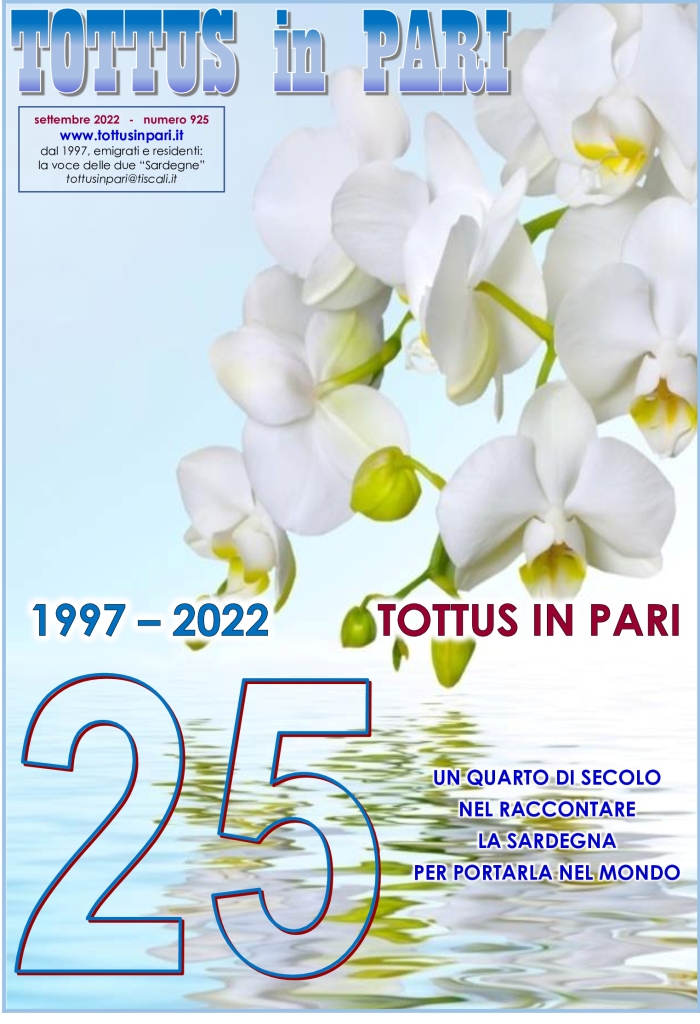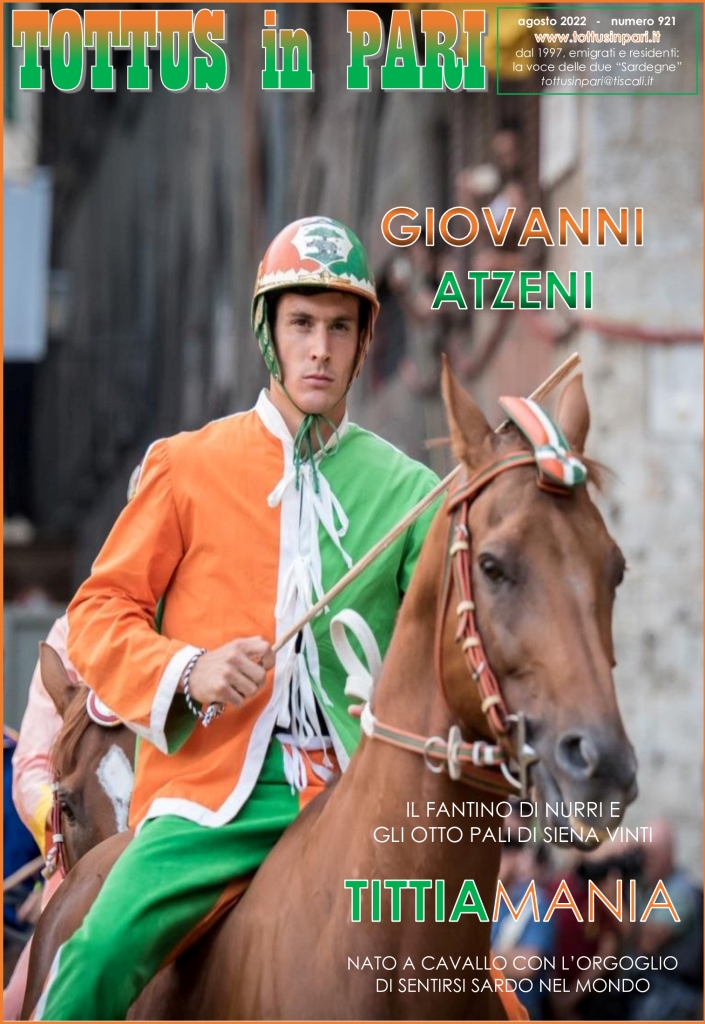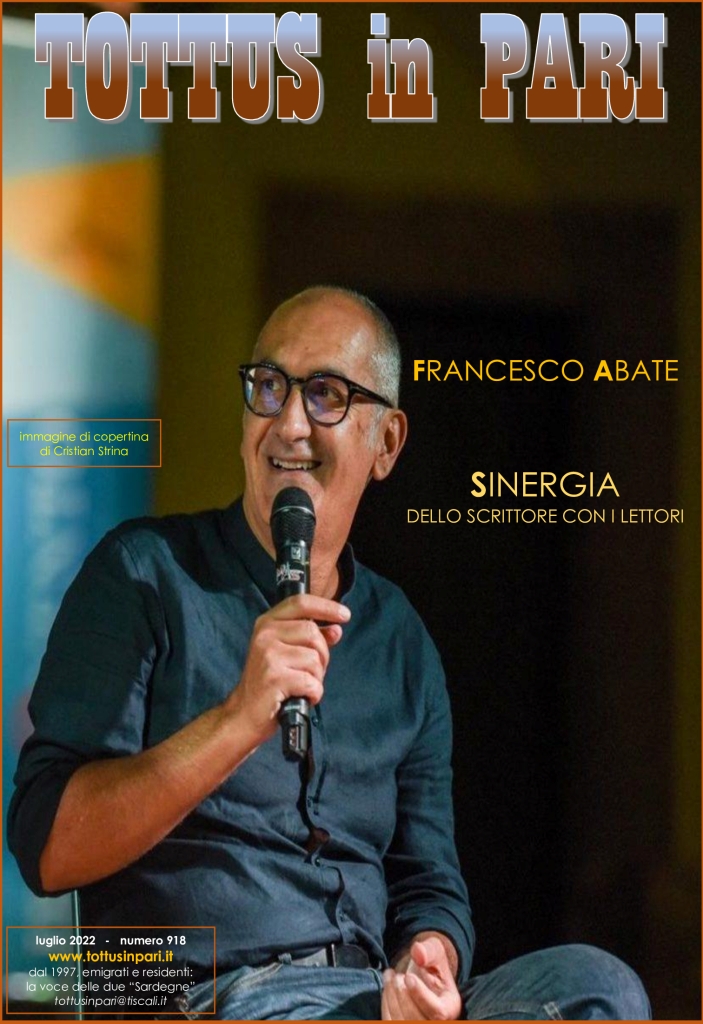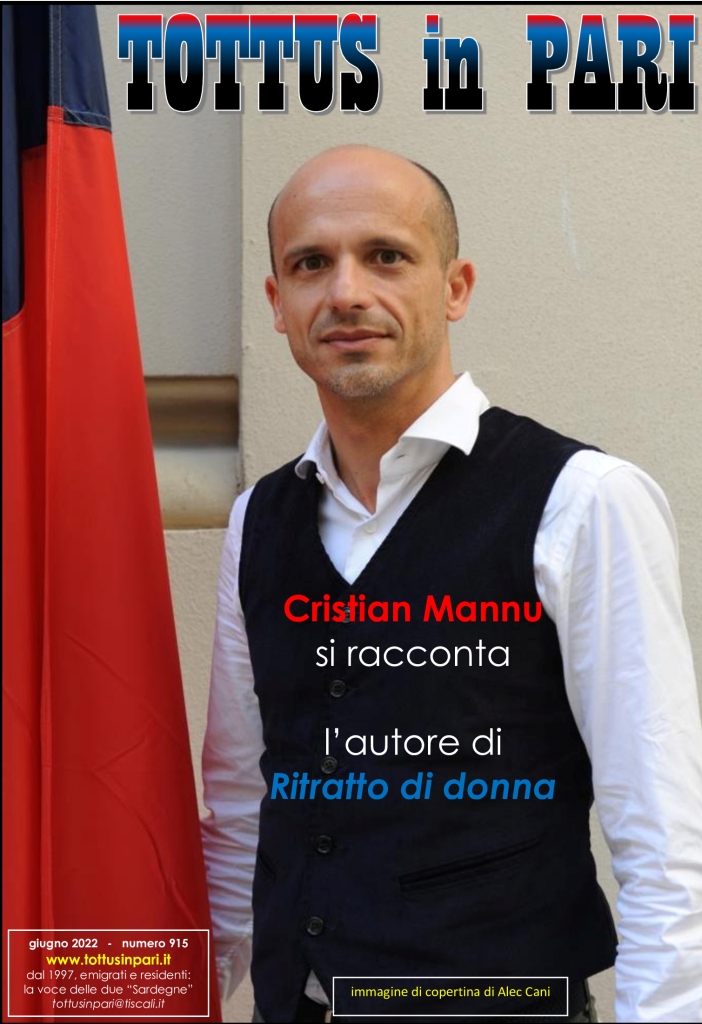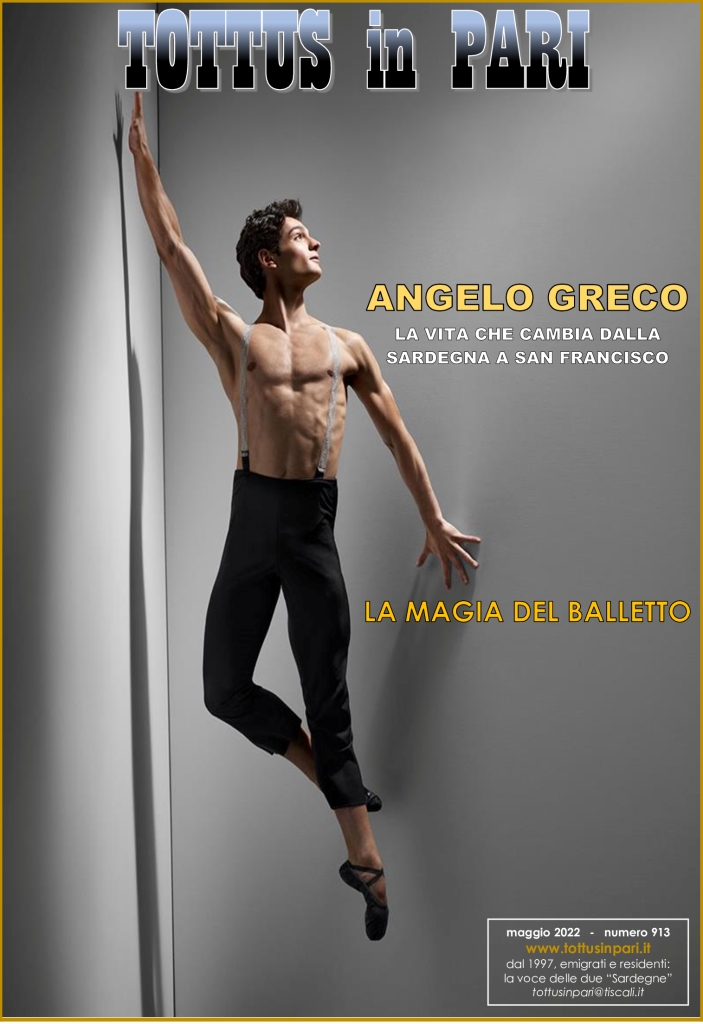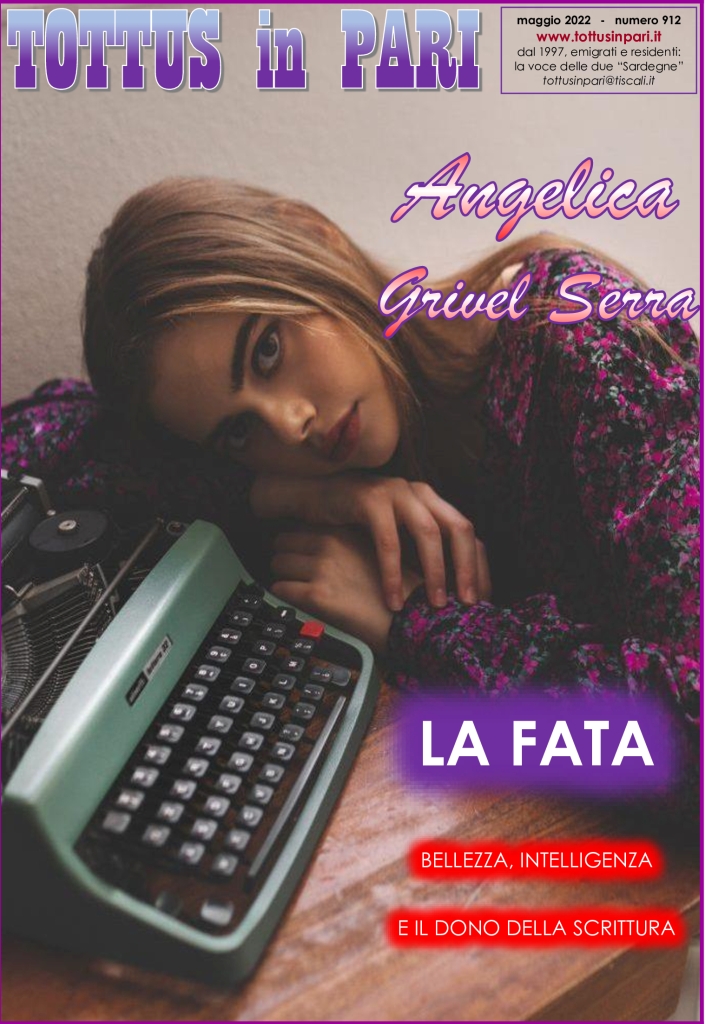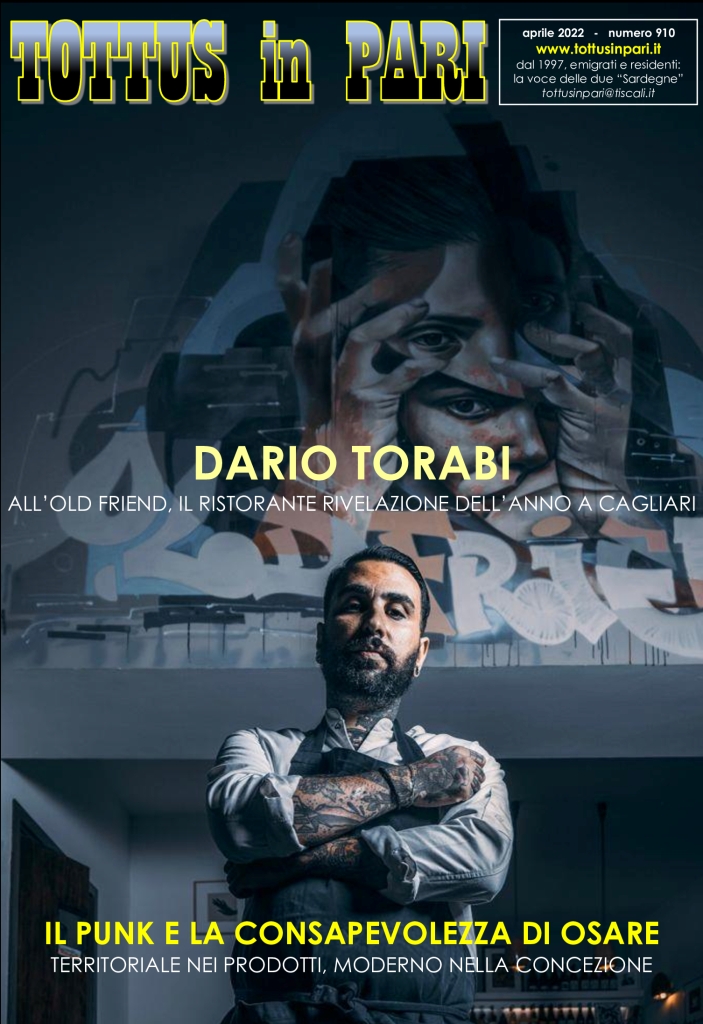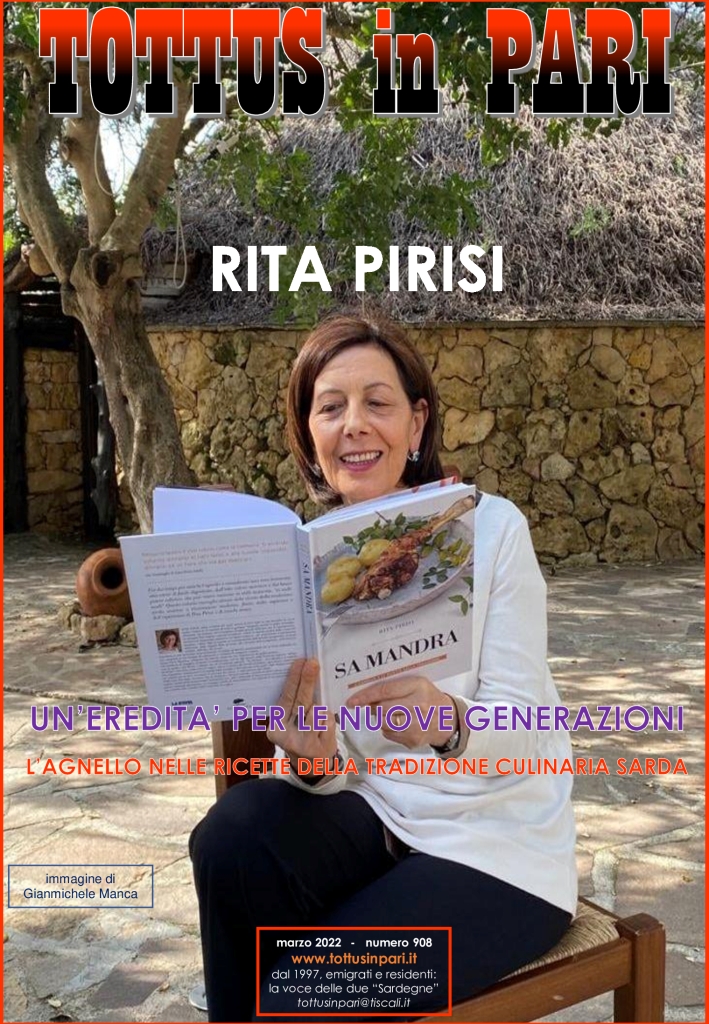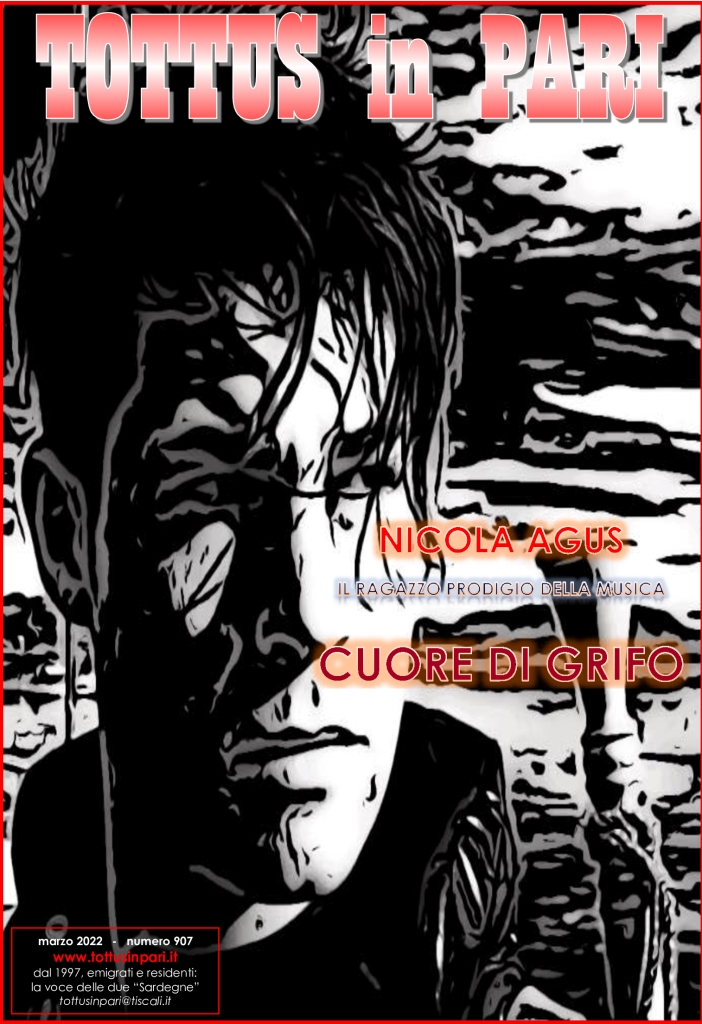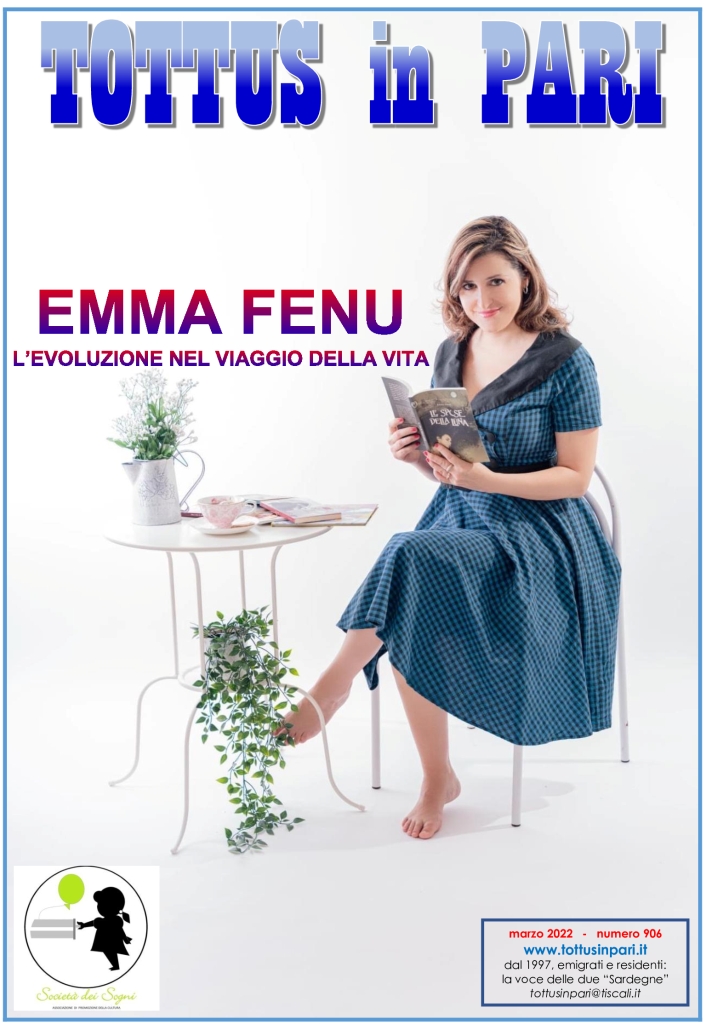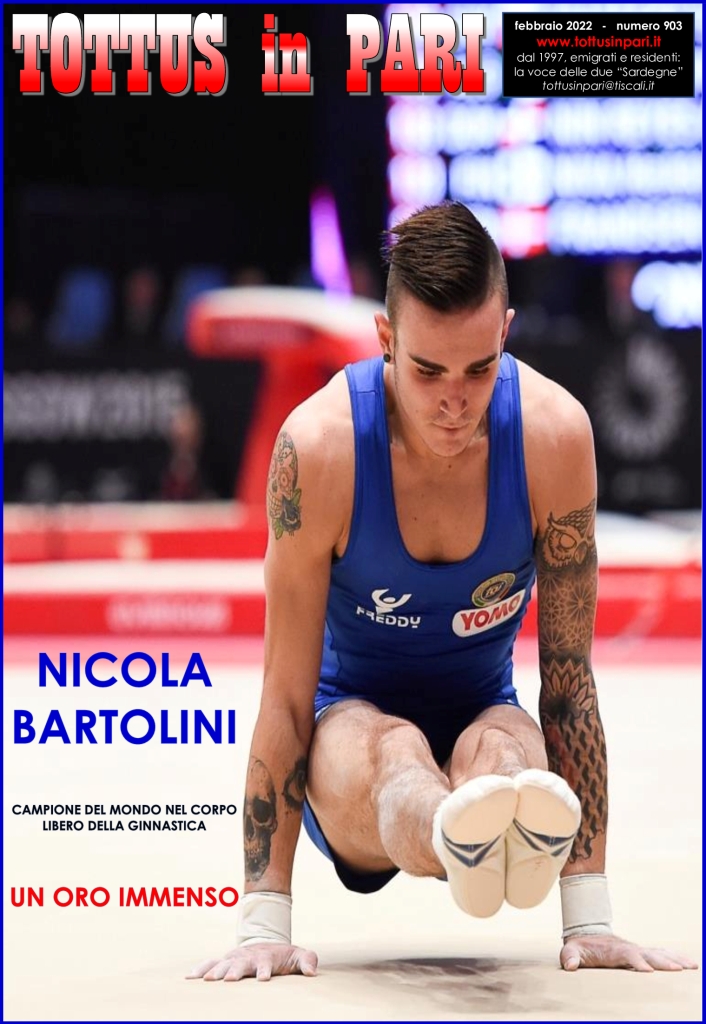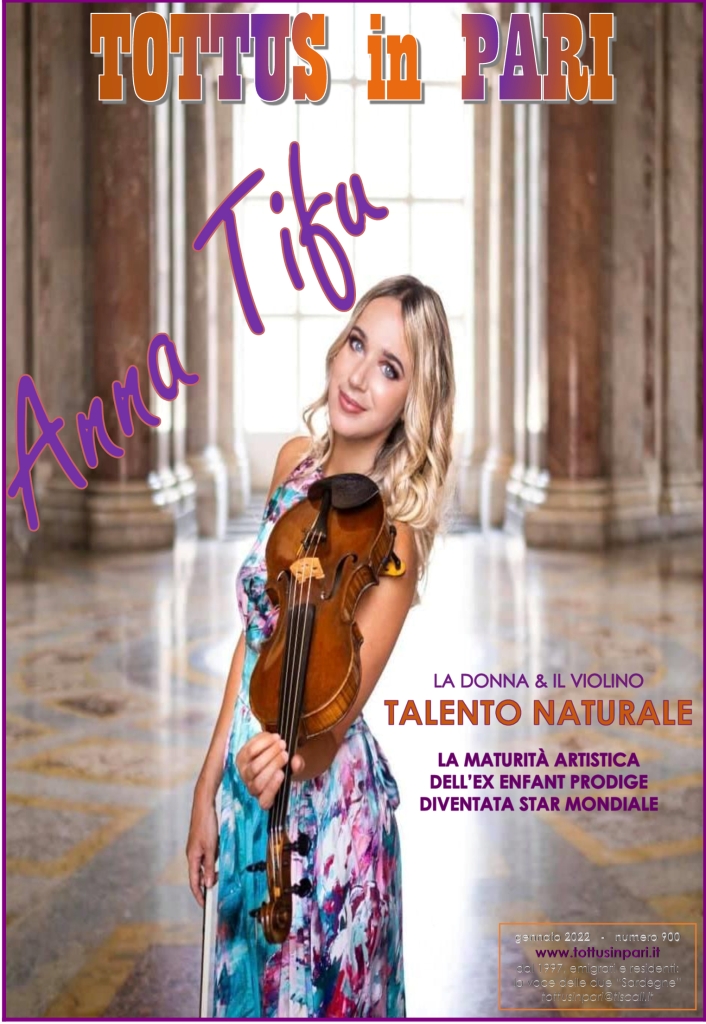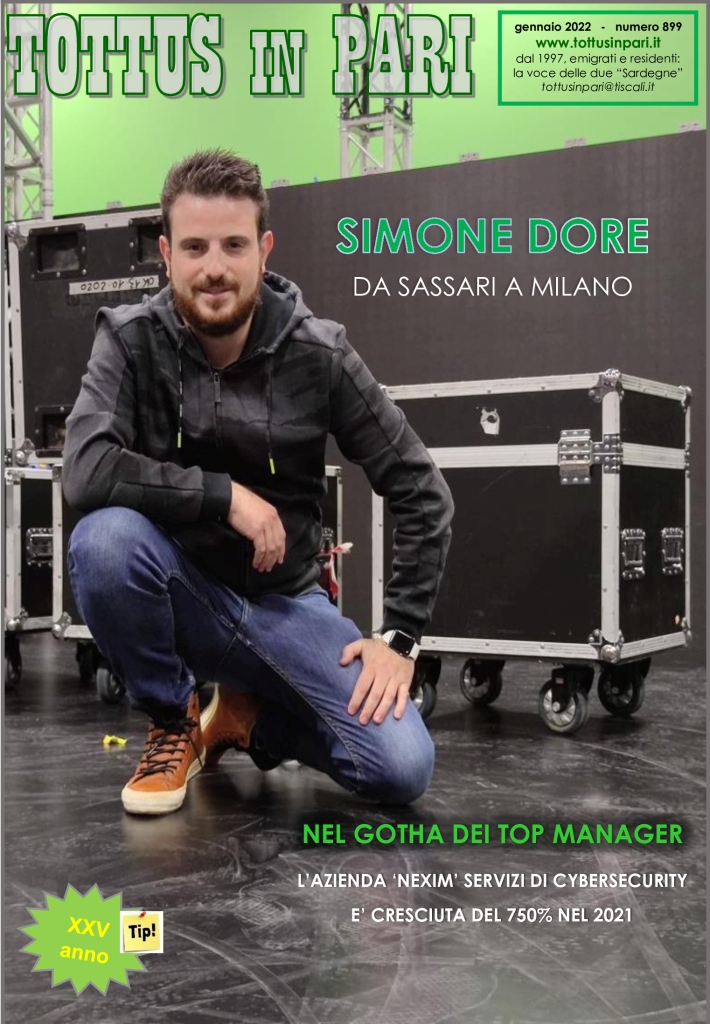di ROBERTA CARBONI
Generalmente identificata con l’Afrodite dei Greci e con la Venere dei Romani, Astarte è in realtà una divinità con numerosi attributi e sfaccettature. Il suo culto era diffuso in tutto il Mediterraneo e aveva un indubbio carattere guerriero, ma anche marinaro.
Il culto di Astarte a Cagliari è attestato dal III secolo a.C., ma potrebbe essere più antico. A testimoniarlo rimangono oggi numerose tracce materiali, tra cui un’iscrizione in caratteri punici ritrovata durante gli scavi della chiesetta di Sant’Elia al monte sul Colle di Sant’Elia, che riporta la dedica alla dea di un altare in bronzo. Questa iscrizione, oggi custodita al Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, potrebbe fare riferimento alla presenza di un antico tempio dedicato ad Astarte proprio sulla sommità del promontorio che oggi prende il nome di Sella del Diavolo a causa di una nota leggenda popolare [leggila qui].
Il Capo Sant’Elia è l’ultima parte di un sistema di colline parallele; la netta frattura dell’estremità meridionale, per la sua forma particolare nota come Sella del Diavolo, connota il paesaggio di Cagliari da tempo immemore, radicandosi nell’immaginario collettivo e diventando una vera e propria cifra identitaria, tanto da celarsi persino nel nome dell’abitato: Krly.
Krly, infatti, è la prima forma scritta che conosciamo del toponimo. Compare su alcune iscrizioni di età punica ritrovate nel tempio di Antas, a Fluminimaggiore e, se l’interpretazione linguistica è corretta, potrebbe essere legato all’importanza del promontorio, al suo valore fondante e identitario. Kr significherebbe, infatti, roccia, la -l renderebbe il nome collettivo, e potrebbe essere tradotto come “le colline” o “il promontorio”.
E su questo promontorio, nel 1870, è stata ritrovata l’iscrizione del III secolo a.C., che riferisce la presenza di un santuario affacciato sul mare; un santuario extra-urbano, dedicato alla divinità fenicia Astarte.
Secondo il resoconto del rinvenimento da parte del canonico Spano, l’iscrizione fu “distaccata dal residuo d’un muro che trovasi in cima del capo Sant’Elia, in vicinanza alla torre dello stesso nome” . Lo Spano, in particolare, precisa che l’iscrizione era “fabbricata alla parte di sud nella parete interna orizzontalmente”. Alla luce dei dati a nostra disposizione, quindi, possiamo ipotizzare che il blocco lapideo recante l’iscrizione fosse inserito nella parete interna destra della Chiesa di Sant’Elia al Monte, sorta nello stesso sito occupato in precedenza dal tempio di Astarte, forse riutilizzandolo, del tutto o in parte.
La posizione, poi, in un punto del promontorio dal quale si può controllare il Golfo ed essere visti dal mare, risultava sia strategica, per un luogo sacro il cui culto era dedicato a una delle principali divinità protettrici della navigazione, sia funzionale , quale indicatore per il riconoscimento del luogo. Una tra le ultime ipotesi, infatti, è quella di un tempio-faro, che attendiamo venga confermata dagli scavi ancora in corso.

Le divinità del mondo antico hanno sempre molte caratteristiche e sfaccettature: Astarte non fa eccezione. Il suo culto era largamente diffuso nel Mediterraneo: era legato ai rituali oracolari e fertilistici.
Astarte è una divinità guerriera; veglia sui naviganti e protegge le città. I suoi molti attributi hanno portato all’innesto di molte divinità a prosecuzione del suo culto, ma, generalmente, è identificata con la Afrodite dei Greci, e la Venere dei Romani (fertilità, maternità, guerra e navigazione, sono gli ambiti in cui agiscono queste divinità).
La dea titolare del tempio a Capo Sant’Elia, però, è connotata dall’appellativo “di Erice”, dunque la stessa divinità adorata nella città siciliana. Secondo una delle ipotesi formulate dagli studiosi, il culto di Venere/Astarte Ericina potrebbe essere connesso ai Romani, i quali solevano includere nel proprio pantheon le divinità adorate nei territori che conquistavano. In particolare si sentivano protetti dalla dea nella loro espansione contro Cartagine: il santuario di Erice era rimasto in mano romana anche durante periodi di ribellioni, per questo motivo la veneravano con grande devozione.
Significativamente, nel III secolo, proprio quando sarebbe stato dedicato l’altare a Capo Sant’Elia, in Sardegna scoppiava la rivolta di Ampsicora, cui aderisce buona parte dell’Isola, ma non Karales, che resta fedele a Roma. Ecco che, ancora una volta, Roma è difesa in guerra da Astarte/Venere di Erice. Potrebbe essere stato questo il motivo dell’introduzione dell’appellativo di Ericina accanto al nome Astarte, a Karales? Ciò attesterebbe una “romanizzazione” dell’antico culto fenicio-punico.
Astarte, come abbiamo detto, è una divinità connessa alla guerra, ma anche alla fertilità e all’amore. Sappiamo da Erodoto e da altre fonti che nel tempio di Astarte ad Erice fosse praticata la “ierodulia”, ovvero la prostituzione sacra.
Si tratta di una pratica rituale assai diffusa connessa a culti legati ad Astarte, Afrodite, Venere a seconda del contesto, che consisteva nell’unione tra una donna o un uomo che impersonavano la divinità della fecondità, e uno straniero, in cambio di un pagamento, il quale andava a rimpinguare le casse del tempio.
Che questa pratica sia stata introdotta anche a Karales non esistono al momento prove certe, ma è forte la suggestione che nasce dalle numerose assonanze con contesti simili. Attraverso la prostituzione sacra, le città che ospitavano i santuari della dea ricevevano un costante flusso di denaro, veicolato dai mercanti, assidui frequentatori di questa tipologia di tempio, a carattere emporiale.
Intanto gli scavi continuano e ci auguriamo che molti degli interrogativi ancora aperti trovino finalmente risposta.