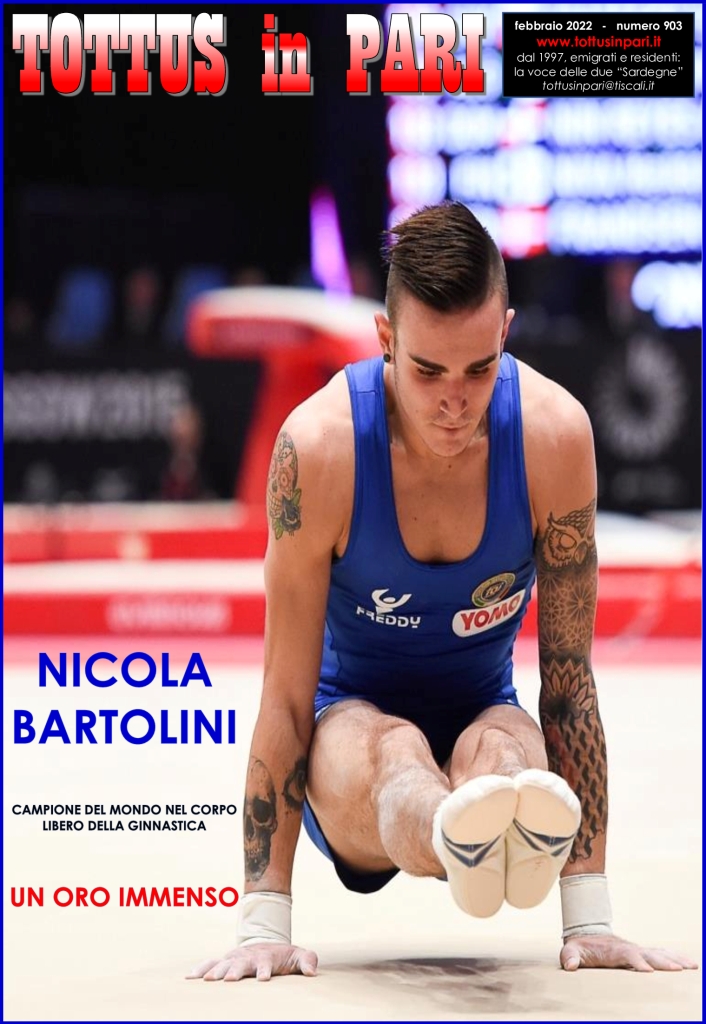di SILVIA PIETRANGELI
Mia madre ha i capelli castani che le sfiorano le spalle, la fronte leggermente sudata e una maglietta chiara a mezze maniche. Il sorriso di papà spunta da sotto i baffi biondo cenere e guarda dentro l’obiettivo attraverso un paio di Ray-Ban a goccia. Alle loro spalle una signora anziana, con la crocchia bianca, dentro un abito nero abbottonato sul petto, parla con qualcuno rimasto fuori dall’inquadratura, accanto ad altri volti e corpi che incorniciano gli sguardi dei miei genitori. Su tutti incombe una patina giallognola di polvere e di pellicola consumata dal tempo, un sole accecante che fa stringere gli occhi e indossare i cappelli.
Quell’immagine sbiadita, catturata sul sagrato del santuario è ancora lì, sulla scrivania dello studio di casa, dove per tantissimi anni è rimasta a guardarci dal cuore della Sardegna. “Eravamo all’Ardia di Sedilo – mi diceva mia madre – sposati da pochi mesi. Io ti aspettavo. Se sei nata a novembre, vediamo, ero al quinto mese”.
Trentacinque anni fa. Quella è stata la mia prima volta all’Ardia. E anche se non ho respirato con i miei polmoni la terra rossa di luglio, devo conservare da qualche parte nel mio inconscio il rumore degli zoccoli e le grida della folla, penetrati con irruenza nel mondo ovattato del grembo di mia madre.
Probabilmente proprio questa consapevolezza ha fatto si che sabato pomeriggio, una volta in cima alla collina affacciata sul monte Isei e sul placido lago Omodeo, davanti a quel pezzo di cielo azzurro e di terra brulla, mi sia sentita in un luogo familiare, conosciuto.
Siamo arrivati da Cagliari in sette, poco prima delle cinque del pomeriggio e il suggestivo anfiteatro polveroso che accoglie il santuario era già gremito di fedeli, curiosi e turisti.
Anche noi seguiamo il flusso di persone accaldate che entra nel perimetro sacro attraverso l’angusto arco di pietra, sotto il quale, qualche ora più tardi, sarebbero sfrecciati pericolosamente i centoventi cavalieri di San Costantino.
Ci arrampichiamo sul tracciato di terra battuta e sassi, oltrepassando i profumi invitanti delle bancarelle, pronte a rifocillare i pellegrini con salsicce, dolciumi, carne arrosto,Ichnusa e cannonau.
Ho chiare le indicazioni dei miei genitori: cercate di mettervi sui gradini della chiesa, da lì si vede bene. Quindi, una volta arrivati ai piedi del santuario, non perdiamo tempo e occupiamo le ultime lastre di pietra irregolari e bitorzolute del lato sinistro del sagrato, sotto la campana, all’imbocco della discesa.
I miei amici sono un po’ perplessi sulla posizione che abbiamo guadagnato, perché non sappiamo bene dove passeranno i cavalli, non ci sono transenne, le persone si spostano, camminano, entrano ed escono dalla chiesa, abbiamo intorno una folla ancora informe, uno spazio dove non è facile individuare il percorso dei cavalieri.
Sui gradini alle nostre spalle è seduta una coppia di signori di una certa età, silenziosi, accaldati, ma avvezzi al clima torrido della Sardegna. Lui, nonostante la temperatura proibitiva, indossa dei pantaloni di velluto, una camicia azzurra sopra una maglietta bianca. La moglie, piccola e secca, è rannicchiata accanto, la pelle chiara, le mani nodose, gli occhi stretti e fermi.
“Mi scusi – chiedo voltandomi verso di loro – i cavalli passano qui, vero? Va bene se restiamo seduti qua?” L’uomo mi guarda senza muovere un solo muscolo del volto. Forse è un po’ perplesso dal mio look. So di sembrare una tedesca con il mio cappellino naif, la gonna verde pistacchio, i sandali dal discutibile gusto nordico e la pelle pallida di chi non vede sole da mesi. La mia amica Manuela, invece, ornata di collane e orecchini colorati sembra una turista americana. Dopo qualche secondo di silenzio, l’uomo indica con i pollici le pietre sulle quali poggia i piedi e dice “Questo è il posto migliore.”
Il tempo di ringraziare e una ragazza giovane, in jeans e maglietta, si rivolge affettuosamente al signore con la camicia azzurra: “Ma era lei che due anni fa suonava la campana? Si ricorda di me? L’anno scorso però non c’era! Non è venuto!” L’uomo la guarda, sorride per la prima volta e risponde soddisfatto “Si ero io. Certo che mi ricordo, l’anno scorso sono stato male e non sono potuto venire.”
“Si avvicini, venga, che ormai è ora – gli dice porgendo la mano per aiutarlo a muoversi sui gradini sconnessi – iniziamo a suonare!” Infatti, proprio sopra le nostre teste penzola una fune lunga e spartana che sale sino alla campana e che può essere suonata da qualunque volenteroso.
A questo punto siamo sicuri di essere nel posto perfetto, in mezzo ai veterani dell’Ardia, nella posizione degli intenditori. Da lassù dominiamo l’intera vallata. Nonostante la polvere e il fumo degli arrosti, distinguiamo con chiarezza “su frontigheddu”, la collina con la croce in pietra dalla quale partirà la corsa. Riusciamo a vedere il dirupo che i cavalieri percorreranno a rotta di collo, l’arco, la salita che porta alle spalle della chiesa e la discesa verso “sa muredda”, cioè il terrapieno circolare che racchiude un’altra croce, questa volta di ferro, intorno alla quale i cavalieri compiranno tre giri in senso antiorario e tre in senso orario. Dalla nostra posizione vediamo l’intera vallata che lentamente si gonfia di persone e ci crogioliamo sotto il riflesso abbagliante del sole sul lago.
Iniziamo a chiacchierare con i vicini di gradino. Una volta accertata la nostra origine sarda, anche il signore con la camicia azzurra si scioglie e nelle ore che precedono l’inizio dell’Ardia conversiamo di buon grado. Ci racconta della sua attività di agricoltore, delle difficoltà dei tempi che stiamo vivendo. Ci parla con gli occhi lucidi della passione della figlia parrucchiera per i cavalli. “Adesso ne possiede tre – ci dice la moglie con orgoglio – ma qualche anno fa i due più belli glieli hanno rubati.” Parla poco la signora, ma si capisce che quella riservatezza non nasconde sottomissione, anzi, coerentemente alla più genuina tradizione matriarcale sarda, è lei il motore della famiglia. “Pensi che fa anche le pariglie. Lo sa che cosa sono?” Certo che lo so, ma mi fa piacere sentirli descrivere le imprese della figlia; la immagino arrampicata in piedi sulla groppa dei cavalli appaiati e lanciati al galoppo. Mi piace ascoltarli mentre descrivono il coraggio e l’abilità dell’amazzone impegnata a mantenere l’equilibrio sulle spalle di altri cavalieri, in una piramide umana, pericolosa e sfrenata, tra le vie tortuose di qualche paese della Sardegna.
Naturalmente ne approfitto per avere la conferma di tutto quello che ho letto sull’Ardia nei libri che ho trovato a casa prima di mettermi in cammino per Sedilo. “Allora – mi spiegano – la prima pandela, cioè il capo corsa è scelto discrezionalmente dal parroco sulla base dei nomi inseriti nel “libro delle promesse”, cioè tra le persone che hanno fatto il voto a San Costantino. Poi a sua volta lui sceglie due cavalieri fidati, la seconda e la terza pandela. Ognuno impugna uno stendardo, una bandiera, rispettivamente gialla, rossa e bianca. Insieme nominano tre scorte, tre cavalieri muniti di bastone che hanno lo scopo di impedire il sorpasso da parte degli altri cavalieri. E a volte si picchiano pure.”
“Ma è mai capitato che qualcuno abbia superato il capo corsa?” chiedo ingenuamente.
“Noto! Per carità – s’inserisce una signora che stava ascoltando – non deve capitare per nessuna ragione, porta male” E si fa il segno della croce per scongiurare tale avversità.
Per un attimo, tra un sorso d’acqua e un ghiacciolo, mi domando come farò a spiegare il senso di questa festa popolare agli amici inglesi, una volta che rientreremo a Leeds. Mi torna alla memoria l’immagine dell’ippodromo di York, dove si svolge una delle corse più importanti e popolari dell’Inghilterra, con tutti quei fantini colorati, il manto verde, le palizzate bianche, le siepi, le tribune con le poltroncine, il profumo del prato appena tagliato. Penso che sia difficile raccontargli che qui non esistono cappelli dall’architettura complicata per le signore o tacchi a spillo, che in realtà non si tratta di una vera e propria corsa, perché nessuno vince e nessuno perde e soprattutto che non c’è niente su cui scommettere.
So che sino a quando potrò raccontargli la leggenda che ricollega la nascita del santuario a un nativo di Scano Montiferro, fatto schiavo dai Mori e imprigionato a Costantinopoli, che sognò San Costantino, il quale gli promise la libertà in cambio dell’impegno a edificare una chiesa in suo onore, andrà tutto bene. Penso che addirittura saranno interessati a capire l’origine storica dell’Ardia, a partire dall’attività dei corpi di guarda bizantini che difendevano i santuari da attacchi esterni e che quindi “facevano la guardia al Santo”.
Ma, e qui arriva il difficile, come spiegargli che in realtà parliamo di un Santo che proprio Santo (almeno per la chiesa cattolica) non è?
Sono sicura che a questo punto li avrò persi. Come fargli capire il sentimento che anima i cavalieri, che li spinge addirittura a rischiare la vita in una corsa pericolosissima, per qualcuno che non ha il titolo di Santo? Già vedo i nasi storcersi e comparire sui loro sguardi l’ennesimo punto di domanda per l’incomprensibile mondo Italiano, per questi strani popoli mediterranei con le loro le tradizioni strampalate e le contraddizioni più assurde.
Spiegargli la sagra di Sant’Efisio è semplice. Il Santo guerriero che libera l’isola dalla peste è una storia più lineare. Ma giustificare agli occhi di un protestante il sentimento di fede e devozione per un imperatore romano mai canonizzato risulta difficile. Però, se devo essere sincera, è anche la parte che più mi piace di questo rito sacro e profano. Un Santo per acclamazione, un sentimento popolare più dirompente di qualunque bolla papale. Un meraviglioso gesto di libertà. Che bello.
Alcuni spari violenti mi scuotono dai pensieri. Il santuario è ormai traboccante di spettatori, si è trasformato in un immenso anfiteatro di corpi accaldati, in un’unica folla trepidante nella quale serpeggia una crescente eccitazione.
L’ora si avvicina e i fucilieri iniziano a farsi largo tra le persone del pubblico. Per quelli che non capiscono i numerosi “a fora!!!” gridati verso chi occupa posizioni pericolose del tracciato, si passa alle schioppettate a salve, molto efficaci nel convincere i più restii ad abbandonare la postazione in una curva a gomito o su una possibile traiettoria dei cavalli.
“Spostati da lì – grida una signora verso una troupe televisiva straniera – guarda che è pericoloso”
“La gente è proprio imprudente, si mettono in questi posti, affari loro se i cavalli gli vanno addosso!Se la cercano” prosegue stizzita.
“Ma non hanno mai pensato a mettere delle transenne?” chiedo timidamente.
“No! Stai scherzando! Non le hanno messe e non le metteranno. Non si deve cambiare niente. Non avrebbe più senso. La gente deve imparare a non mettersi dove gli si dice che è pericoloso. Questa è l’Ardia.”
E ha ragione la signora. La magia di questa corsa è racchiusa nel contatto tra il pubblico e i cavalieri, nel sentirsi così vicini da poterli quasi sfiorare; percepire il rumore degli zoccoli, il profumo dolciastro del sudore dei cavalli, le parole sussurrate dall’uomo all’animale; vedere ogni singola ruga che solca i volti dei cavalieri, poter ammirare il gioco dei ricami colorati dei sottosella. Nell’Ardia i cavalieri non sono gli unici a sfidare il pericolo, anche gli spettatori a modo loro lo fanno. Per qualche minuto si ritorna in un tempo arcaico, laggiù dove l’uomo, per sentirsi tale, ha bisogno di gareggiare con la sorte, di affrontare la paura.
Anche i carabinieri si danno da fare nel convincere le persone a spostarsi dai punti più critici. Con molta gentilezza ci consigliano di salire più in alto sul sagrato per evitare di prendere una zoccolata com’è capitato l’anno scorso a una ragazza. I vicini di gradino con cui abbiamo fatto amicizia ci cedono un po’ di spazio.
Ormai siamo in piedi e nel frattempo arrivano il parroco, il sindaco e due carabinieri, tutti rigorosamente a cavallo.
Si sistemano anche loro sui gradini ai piedi della chiesa e per alcuni minuti la tensione dell’attesa diventa palpabile, tutta la valle e il monte piombano in un silenzio irreale.
“Stanno per partire” sussurra qualcuno e sulla collina davanti, a “su frontigheddu”, si staglia la figura antica e misteriosa di un cavaliere solitario accanto alla croce di pietra. Guarda alle sue spalle verso le fidate pandelas e verso le guardie che tengono a debita distanza il gruppo dei cavalieri. Poi osserva la discesa ripida, l’arco, il santuario, la chiesa.
Un grido percorre la folla. “E’ partito!”
Dalla collina si alza una nuvola di fumo e un cavaliere dopo l’altro l’affrontano e l’attraversano; da soli o a piccoli gruppi, sfrecciano impavidi in una corsa sfrenata, verso l’abisso e verso il cielo, verso l’arco e verso il monte, verso il mistero della vita e della fede.
E’ tardi quando riattraversiamo l’arco per tornare a piedi verso il paese. E’ buio e grilli hanno iniziato il loro canto.
Sento le gambe tremare. So che non è colpa della stanchezza, ma piuttosto di tutta la tensione accumulata nella giornata. Stringo tra le mani il cero lungo e affusolato di San Costantino, respiro gli odori della notte sarda.
Sono ricoperta di un sottile e persistente strato di polvere. La sento nel naso, negli occhi, in bocca, tra i denti. Guardo il lago muto e addormentato accanto alla via del ritorno e rigiro nella memoria le immagini e le emozioni della giornata: i cavalli precipitati sotto i nostri occhi, la mano di una signora che si aggrappa alla mia nel momento del pericolo, le incitazioni e le esclamazioni della folla, il volto terrorizzato della fidanzata di un cavaliere che vuole vedere le foto della caduta per capire chi fosse il ferito, la brezza che entra dalle porte spalancate della chiesa, le parole dell’omelia del parroco, l’argento degli ex-voto, le foto dei fedeli, le braccia protese verso le bandiere, le giacche di velluto, le camicie bianche, il fumo, le voci, le campane.
Ho la sensazione di essermi finalmente riappropriata di quel pomeriggio di trentacinque anni fa. Come i cavalieri che girano intorno al santuario, anch’io nel mio piccolo ho ripercorso un cerchio.
Ormai è notte quando ci infiliamo in macchina per imboccare la 131 e ritornare a Cagliari.
Sento un odore strano. Controllo le suole delle scarpe. Temo di aver calpestato dello sterco di cavallo.
Non mi arrabbio. Sorrido. “Fermiamoci un secondo” dico a Stefano al volante.
Per un attimo torno di nuovo sul sagrato della chiesa, con il sole a picco e la polvere nella gola. Qualcuno sbuffa con aria seccata ad alta voce.
“Uffa questa puzza di merda di cavallo, che schifo!”
Sento ancora la voce della ragazza in jeans e maglietta mentre accostiamo su una piazzola al lato della strada.
“Eh no mia cara signora, si sbaglia. Questa non è puzza di merda. Questo è profumo d’Ardia.”