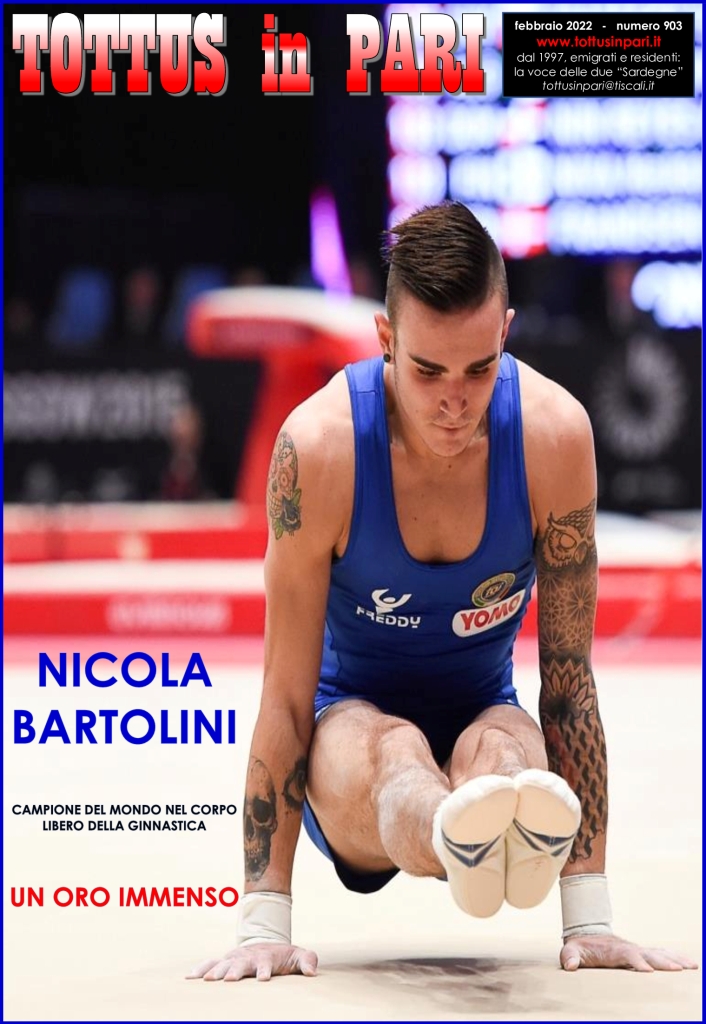nella foto l’autore dell’articolo
di OMAR ONNIS
Il sistema costituzionale dell’Italia, il suo ordinamento giuridico, è basato sulla democrazia parlamentare e sulla centralità della rappresentanza dei cittadini. Questo è un assunto che viene sempre rimosso dal dibattito istituzionale e dai commenti. È una scelta specifica, fatta da un larghissimo fronte politico, all’indomani della IIGM e della sconfitta del fascismo, proprio per impedire che lo scenario politico-istituzionale diventasse facile vittima di derive autoritarie, di dittature della maggioranza (anche relativa) o peggio.
Tutti problemi che quelle stesse persone avevano visto squadernarsi sotto i loro occhi nei venticinque anni precedenti. Ma alcuni erano anche memori della prima fase dell’unità italiana, non certo limpida né votata ad aperture democratiche e alla larga partecipazione della cittadinanza alla sfera politica.
Risultavano quasi del tutto rimossi i guasti del colonialismo interno, che pure almeno alcuni dei costituenti avevano ben presenti. E questo è uno dei fattori di debolezza e inadeguatezza della “costituzione più bella del mondo”. Ma è un altro discorso, almeno in parte.
In definitiva, le cose erano state ordinate affinché non potesse mai esserci una gara alla vittoria di uno su tutti e che fosse sempre necessaria una negoziazione, un accordo tra diversi, per formare un governo.
Per altro in uno scenario – come detto – in cui potevano essere rappresentate in parlamento tutte le istanze popolari, benché minoritarie e marginali. Aveva un senso.
In Italia, per come si è costituita questa compagine politica fin dal suo esordio, era e rimane la soluzione migliore, o la meno peggio, dato che l’Italia è comunque un pastrocchio politico piuttosto insensato, congenitamente patogeno.
Se a questa soluzione a livello centrale si fosse aggiunto anche un forte federalismo interno e un ampio rispetto delle diversità reciproche, lo stato repubblicano sarebbe stato davvero quel nuovo patto democratico tra cittadini che non è mai riuscito ad essere. E forse avrebbe avuto un senso farne parte anche per la Sardegna, se non altro per comodità.
In ogni caso l’impianto politico di riferimento, a livello costituzionale, è sempre quello del 1948.Centralità del parlamento, proporzionalismo elettorale, governi collegiali (niente “premier”, dunque, né “capo del governo”, come invece amano dire i mass media).
Tuttavia, con la fine della guerra fredda, l’estinzione dell’URSS e la teorica caduta della discriminante anti-comunista (più che altro per dissoluzione del PCI), c’era il rischio che le maggioranze potessero improvvisamente mutare di segno, in senso popolare e di sinistra, mettendo la DC in minoranza.
Il quadro politico italiano si sbloccava e si faceva concreta la possibilità di consegnare lo stato a governi progressisti, laici, popolari.
Un esito poco affidabile nell’ottica della “democrazia vigilata” o “parziale” quale l’Italia doveva essere, nell’interesse di chi ne aveva sponsorizzato la formazione e poi garantito, nel post IIGM, l’esistenza autonoma, dentro la NATO e in funzione di potenti interessi geo-strategici altrui.
La caduta dei partiti dominanti, con l’operazione Mani Pulite, si inserì in un momento di particolare fragilità politica. Ma fu colta al balzo (non voglio credere che fu pianificata a tal fine) per inserire dentro l’ordinamento costituzionale vigente il germe della competizione, della ricerca della vittoria, con le leggi elettorali maggioritarie e gli altri espedienti che svuotavano progressivamente di forza e di senso la rappresentanza parlamentare e ne riducevano lo spettro politico.
Il problema della cosiddetta II Repubblica non è stato Berlusconi, che caso mai è un sintomo del male, non il male medesimo. Così come non è stato il palese accordo stato-mafia, anch’esso tutto sommato fisiologico, per come hanno sempre funzionato le cose in Italia fin dalla sua unificazione.
Il problema è stata la deriva anti-democratica, lo spostamento del centro politico dal parlamento al governo e la trasformazione di quest’ultimo in un premio per la minoranza di volta in volta più robusta, in grado, a quel punto, di prendersi tutto, senza grandi contraltari nel potere legislativo e senza più alcuna vera dialettica interna.
Gli stessi eredi del PCI e delle altre forze di sinistra si sono ricollocati nell’alveo della social-democrazia liberista che intanto prendeva piede in tutto l’Occidente, mutando forma solo per adattarsi alle specifiche dinamiche locali, nei vari stati. I danni più estesi e duraturi all’impianto democratico italiano, alla costituzione materiale e agli assetti sociali del paese non li ha fatti Berlusconi, o non solo lui. È stato un concerto e un incontro di interessi. Le conseguenze sono state:
– la concentrazione del potere economico;
– lo svuotamento del potere di interdizione della sfera pubblica nell’ambito produttivo (salvo che come veicolo di denaro pubblico in tasche rigorosamente private;
– la normalizzazione di tutti i presidi sociali e culturali di indole potenzialmente democratica (scuola e università, sindacati, mass media);
– la disarticolazione sistematica del mondo del lavoro e il suo indebolimento in termini di garanzie contrattuali e di rappresentanza politica;
– il conseguente aumento delle diseguaglianze e la radicalizzazione delle distanze tra diverse aree dello stato;
– il nuovo centralismo autoritario, a volte mascherato a volte palese.
Nel corso di questo processo, piuttosto rapido in termini storici, le forze locali e le minoranze interne ai confini statali sono state messe nella condizione di non nuocere.
(Salvo pochi marginali casi, che ridurrei sostanzialmente alla Provincia autonoma di Bolzano, in virtù del vantaggio strutturale e inimitabile delle garanzie a livello internazionale, e di riflesso a quella di Trento; la Valle d’Aosta è troppo piccola per contare qualcosa in termini generali.)
Il caso della Sardegna è istruttivo, ben degno di essere annoverato tra i casi di studio, a livello accademico.
Verso il 1991 (occhio alla coincidenza delle date: fine dell’URSS e Prima guerra del Golfo) finiva la stagione dell’assistenzialismo e della corruzione del tessuto economico, sociale e culturale garantita dai finanziamenti del Piano di Rinascita.
Da questo momento in poi, lo stato ha fatto sistematicamente man bassa di risorse, senza nemmeno fa finta di reinvestire qualcosa in infrastrutture, nei beni comuni, nella sfera dei diritti civili e sociali.
La “vertenza entrate” è emblematica di questa recrudescenza coloniale da parte dello stato verso l’isola. La brutale appropriazione – illegittima e illegale – delle entrate costituzionalmente spettanti alla Regione sarda sono uno dei fatti più eclatanti e insieme simbolici di tale fase storica, non ancora chiusa.
Ma non c’è stato solo questo. Lo stato ha dismesso tutto ciò che poteva dismettere, tranne il controllo repressivo e quello militare. Un fatto che salta agli occhi anche senza ricorrere a chissà quali strumenti di analisi.
La politica sarda è stata egemonizzata, col beneplacito e il favore di Roma, da forze politiche senza orizzonti e senza contenuti, senza obiettivi e senza alcun interesse reale alla cosa pubblica.
La politica sarda ufficiale è diventata una sorta di rappresentazione scenica, giusto per fingere di fare qualcosa, mentre ciò che conta viene deciso in altre sedi e fatto valere sì tramite gli strumenti formalmente istituzionali, ma secondo una logica del tutto estranea al gioco politico democratico.
Finito malamente il periodo del “vento sardista” degli anni Ottanta, l’unica minaccia a questo andazzo, negli ultimi venticinque anni, è stata la stagione della prima candidatura e della vittoria elettorale di Renato Soru, nel 2004, sulla scia della enorme mobilitazione popolare contro il pericolo di una centrale nucleare e/o lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi italiani nell’isola (2003).
Una parentesi breve (due anni) ma significativa, accompagnata da una forte rinascita dell’indipendentismo.
Come sia andata a finire lo sappiamo.
La seconda occasione in cui il processo neo-coloniale in Sardegna è stato in qualche misura messo in pericolo è stato in occasione delle ultime elezioni regionali, nel 2014.
In tale frangente lo scenario politico – inizialmente minacciato dal fuoco di paglia della vittoria del Mov. 5 stelle alle elezioni politiche 2013 – è stato scosso dalla partecipazione alla contesa elettorale di Sardegna Possibile, con Michela Murgia candidata alla presidenza, a cui si affiancavano altre candidature di matrice indipendentista.
La reazione al pericolo che una simile opzione rappresentava è stata feroce e senza tante remore. Anche grazie ai trucchi di bassa lega escogitati dai partiti dominanti (ma non più egemoni, né maggioritari) nella normativa elettorale, che hanno consentito di escludere da qualsiasi rappresentanza istituzionale il voto regolarmente espresso di decine e decine di migliaia di elettori.
Ma in ogni caso, nemmeno tale manovra è riuscita a nascondere la realtà di una forte domanda democratica e di autodeterminazione. Anche questa è una storia che conosciamo (o dovremmo conoscere) tutti molto bene.
La domanda di democrazia, di reale rappresentanza popolare, di diritti e di autodeterminazione non è cero scemata, anzi con tutta evidenza è persino aumentata, al di là degli episodici esiti elettorali (sempre condizionati da vari fattori, anche esterni, non sempre limpidi). In definitiva oggi ci troviamo con uno stato centrale estremamente debole e con una situazione politica sarda precaria e del tutto subalterna.
A livello di stato centrale, il pasticcio combinato con la trovata dell’ultima legge elettorale (il c.d. Rosatellum) non fa che confermare la mala fede e la totale ciarlataneria della classe politica italiana.
La quale, al solito, predilige affidarsi a logiche di accentramento del potere e di favore verso centri di interessi robusti, a livello italiano e internazionale.
L’equivoco – voluto – ancora una volta sta nella pretesa di innestare una competizione alla “o tutto o nulla” in un quadro costituzionale concepito invece per favorire accordi e compromessi e per basarsi (in teoria, secondo il dettato costituzionale) su una larga e aperta rappresentanza democratica in parlamento.
Se non si scioglierà questo equivoco, non se ne uscirà mai. Ma a chi importa uscirne? Sia come sia, è evidente che la Sardegna non possa più dipendere dalle sorti dei vari governi italiani, né dalle trovate escogitate dalla classe dominante italica per perpetuare il proprio potere e garantire gli interessi dei suoi protettori internazionali.
Oggi invece siamo ridotti allo status di colonia di una colonia, sostanzialmente. Di provincia marginale e sacrificabile di una compagine politica debole e pericolosamente incline ad avventure autoritarie. La nostra classe politica è più che mai abbarbicata al potere, nelle istituzioni, negli enti pubblici, nella sanità, in ogni meandro occupabile tramite clientelismo e dispendio di denaro pubblico.
Tuttavia anch’essa è ormai drammaticamente debole. Lo dimostra oltre ogni dubbio il fatto palese che l’agenda politica sarda è sostanzialmente occupata da istanze, questioni e anche orpelli puramente retorici di matrice indipendentista o comunque di opposizione radicale allo status quo.
Un fatto che è solo apparentemente paradossale.
È inevitabile che i centri di potere attuali cerchino di assorbire e di disinnescare, normalizzandole, questioni generali, istanze sociali e culturali, parole d’ordine a loro avverse.
Anche per questo, oggi più che mai, è indispensabile distaccarci dalle dinamiche politiche italiane. Occorre creare una faglia attiva tra scenario politico sardo e scenario italiano.
È chiaro che tale soluzione non potrà essere praticata – al di là delle dichiarazioni di circostanza (penso alle sparate ridicole di un Silvio Lai sull’eventualità di un PD “sardo” ed altre baggianate trasformiste di questa risma) – dalle forze politiche subalterne e coloniali.
Non tanto perché siano partiti italiani, ma perché non sono partiti.
Sono organizzazioni affaristiche che non hanno la funzione di corpi intermedi dentro i rapporti sociali, ma quella di garantire vantaggi e potere ai loro capi-fazione e ai loro protetti. E al contempo mantenere a disposizione di speculatori internazionali e dei giochi geo-politici l’intera Sardegna e le sue risorse.
La scelta di non avere nulla a che fare con loro non discende dunque da una discriminante di tipo “etnico” (i loro rappresentanti locali sono pur sempre sardi, rispettando in questo il copione delle migliori tradizioni coloniali), ma semplicemente da profonde ragioni politiche. Non sono cose che si sistemano in un mese o in un anno, è chiaro. Nemmeno in un decennio. Ma è anche vero che il processo è ormai in corso.
Gli scossoni, gli apparenti passi indietro, le occasionali rimodulazioni organizzative sono solo episodi contingenti dentro un movimento storico profondo.
Ci vorrà molta forza per portarlo a compimento in termini democratici ed emancipativi, ma non sarà nemmeno poca la forza necessaria ad arrestarlo.
E credo che l’opzione anti-democratica e palesemente colonialista già in campo, di qui in avanti avrà sempre più difficoltà ad affermarsi a buon mercato.
La debolezza dello stato italiano non è un grande vantaggio, perché in tali ricorrenti circostanze l’Italia dà sempre il peggio di sé.
A maggior ragione approfittarne non sarà una scelta troppo cinica. A patto che tale scelta sia rivolta a una reale crescita di consapevolezza e di democrazia nell’isola, e non alla conquista di un ruolo di intermediazione da parte di homines novi, più o meno realmente… nuovi, pronti a sostituire la moribonda classe politica dominante, ma senza alcuno scopo realmente rivoluzionario (se non in termini passivi, come già segnalato diverse volte). E senza dimenticare di mantenere uno sguardo vigile sullo scenario internazionale, cosa che la politica sarda tradizionalmente non ha mai saputo o voluto fare.