Con un film del 1960, che fu un caso nel 1994 quando finalmente uscì – e restò in programmazione per alcune settimane in 50 sale a Parigi – comincia una stagione che alcuni comuni vorrebbero dedicare all’emigrazione in Belgio che li ha segnati, cominciati a svuotare, 70 anni fa, senza che si siano mai ripresi.
Già vola il fiore magro (verso di una poesia di Quasimodo) è il titolo del film, di Paul Meyer, regista belga al quale il governo – che gliel’aveva commissionato – chiese indietro i soldi dell’anticipazione (e ritirò la pellicola) quando vide che non era come l’aveva immaginato. Non una felice storia di integrazione fra comunità di italiani, greci, slavi, con la popolazione locale….
La realtà che Meyer vede e racconta è quella più cruda della vita fra le baracche. Senza mai introdurre lo sguardo nei pozzi, segue i giochi sui cumuli di carbone, l’apprendimento del francese a scuola, di un ragazzino di Ula Tirso, mentre il padre, Pietro Sanna, già disilluso, sogna il ritorno, aspettando alla stazione di Flénu l’arrivo dei familiari dalla Sardegna, i figli piccoli, la moglie.
Il primo convoglio carico di giovani maschi italiani, duemila, un centinaio di sardi fra loro, partì da Milano la sera del 12 febbraio del 1946. Erano stati reclutati dagli uffici di collocamento: i manifesti della Federazione carbonifera belga promettevano salari inimmaginabili allora altrove, il viaggio gratis, in 18 ore da Milano, sino alla bocca della miniera, un alloggio pronto, la possibilità di far seguire la famiglia. Ma era il disastro dell’immediato dopoguerra che portava la gente a crederci. La Sardegna sovrappopolata nelle zone interne, rispetto all’agricoltura e alla pastorizia impoverite, le aree minerarie sature a loro volta, fornì migliaia di giovani contadini e pastori a questo scambio diseguale. Quanti furono?
Oggi si fa comune affidamento su queste cifre: nel 1955 gli italiani nelle miniere belghe sarebbero stati quasi 47.000 su un totale di 65.000 stranieri e di 114.000 minatori, dunque poco meno della metà della manodopera dei bacini carboniferi. Ma l’impressionante flusso di regolari e di emigrati clandestini, la permanenza in miniera anche per brevi periodi di chi non ce l’ha fatta a restare ed è tornato a casa o ha scelto altri lidi, porta a 230.000 il numero degli italiani che tra il 1946 e il 1960 lavorarono nelle miniere belghe.
Nel 1972 i sardi che sono ufficialmente in Belgio sono 18.903, rappresentano il 7% del totale degli italiani che vi si sono stabiliti. Si tratta di dati ufficiali. Sfuggono sicuramente coloro che non registrano all’anagrafe del comune di provenienza il loro trasferimento. Anche l’emigrazione successiva agli accordi del 1946 non è suffragata da dati certi, nonostante la gran parte degli emigrati venissero regolarmente assunti, con contratti che passavano dall’ufficio di collocamento.
Ci sono paesi in Italia e in Sardegna che sono stati segnati per sempre da quell’esodo. Da Ardauli se ne andarono in 90, apripista il sindaco da poco eletto, il sardista Chicchinu Ibba che al ritorno qualche decennio dopo si dedicherà all’assistenza dei minatori e a scrivere finalmente un libro che è una delle pochissime testimonianze scritte di quella vicenda, premiato dalla Fondazione archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano.
Da Siniscola andarono via in 650. Lo storico Martino Contu sta coordinando una ricerca paese per paese.Pochi hanno voglia di ricordare. Bisognerà interrogarsi anche su questo. I minatori della prima ondata hanno 90 anni, suppergiù, i non molti sopravvissuti. Il regista Simone Cireddu sta provando a raccogliere testimonianze, ma vengono fuori a fatica. Barbara Pinna, figlia di un minatore di Zuri, ricorda quanto poco il babbo parlasse di quegli anni, e mai della miniera. Mostrava le foto di se stesso tutto elegante per le vie di Mons la domenica, basta.
La rivista Studi Emigrazione ha dedicato un numero a quello che l’autore di uno dei saggi, quello su Marcinelle, chiama «il governo della memoria». Quando lavora la memoria, cosa ricorda, cosa rimuove, cosa la sollecita, o la scoraggia. E chi ricorda? Le persone che hanno vissuto quelle esperienze, le loro famiglie? E chi è rimasto in paese, assistendo al proprio declino, come ad Ardauli? È come se non ci fosse la forza nemmeno per ricordare, sembra, a volte. La forza, l’intelligenza, per suscitare memoria, raccoglierla, organizzarla, tramandarla, farla diventare storia.
Le migrazioni sono la storia di chi è andato via per restarsene altrove per sempre o è tornato, ma anche di chi è rimasto, e le ha subite magari credendo di essere fortunato a restare. È la storia dei luoghi della partenza e dell’arrivo. Sarebbe anche una bella chiave interpretativa della vicenda delle classi dirigenti, nella piccola dimensione e in quella più grande. Merkel sì, oggi, e ieri De Gasperi, ma anche i sindaci del Barigadu, i docenti delle scuole.
Se non fosse per Marcinelle – 262 operai arsi dalle fiamme nel pozzo di Bois du Cazier, fra loro 136 italiani – e la cui ricorrenza è diventata dal 2001 ogni 8 agosto Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo anche il Belgio, chi si ricorderebbe di quell’epopea italiana, della pagina sarda?
A Marcinelle non c’erano sardi, fu un caso. Ne morirono altri prima e dopo. Ma non è la tragedia che fa ricordare, e conservare la memoria. In Arsia, Istria sud-orientale, nel 1940 morirono 185 minatori, in grande maggioranza italiani. Chi lo ricorda? Minimizzata dal regime fascista, sovrastata da altre tragedie e dalle vicende del confine orientale, fu rimossa. C’erano alcuni sardi fra i morti. C’è qualche scuola, nel paese da dove provenivano, dove si rilegge la storia attraverso questi fatti?
Non tutto fu tragedia, ovviamente. Non tutto sconfitta.
«Per due convogli che andavano, uno tornava», secondo la testimonianza di qualche giorno fa di Pasquale Zaru, 91 anni, emigrato da Sorradile, ora a Bidonì. Tornavano i tanti giovani che non se la sono sentita più di restare alla vista dei pozzi, delle “cantine” (parola belga che significa mensa) nelle quali sarebbero dovuti andare a vivere, e che in realtà erano gli hangar nazisti utilizzati durante la seconda guerra mondiale per i prigionieri sovietici, grandi stanze dentro capannoni di lamiera di proprietà delle società minerarie, con bagno e cucina in comune, un letto con materasso e coperte; non erano riscaldate d’inverno, d’estate caldissime.
Nei pozzi le condizioni di lavoro erano disumane; prima della tragedia di Marcinelle, nel 1956, non erano in dotazione nemmeno le maschere antigas. Si lavorava per otto ore, e poi spesso soprattutto gli italiani si prestavano a fare un secondo turno, in cunicoli stretti, alti a volte solo 40 centimetri, a temperature anche di 45 gradi, sdraiati su un fianco con il martello pneumatico imbracciato, mentre una candela illuminava la scena. Alla consumazione dei pasti erano dedicati 20 minuti.
La paga veniva data due volte al mese, in genere il 10 e il 25 del mese. Il salario medio si aggirava, all’inizio degli anni ’50, tra i 220 e i 350 franchi al giorno. Con il lavoro a cottimo si riusciva a raggiungere anche oltre 400 franchi. Le ferie venivano calcolate sulla base dei giorni lavorati nell’anno precedente. Dai 6 giorni all’anno del 1948 si passò ai 12 e poi ai 30, grazie all’intervento dei sindacati.
http://www.sardegnasoprattutto.com/





























































































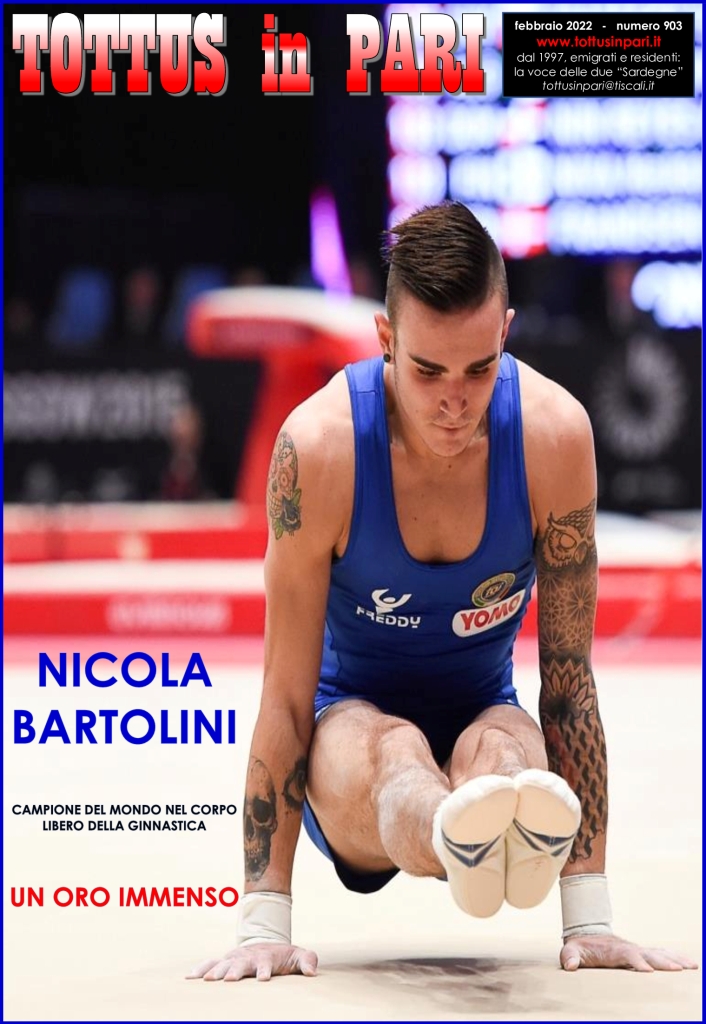











la guerra del carbone, l’abbiamo vissuta in pieno, quanti ricordi, siamo stati veramente l’immigrazione di tutti i sacrifici, abbiamo sopravvissuto ma il prezzo è stato alto !
Capisco che il Belgio abbia rifiutato il film, urlano troppe verità, ho scritto un libro autobiografico che trascrive gli anni del carbone e l’ambiente di vita da immigrati, un editore mi ha detto- non posso pubblicare il suo libro è troppo triste, sarebbe un trauma per le nostre lettrici-