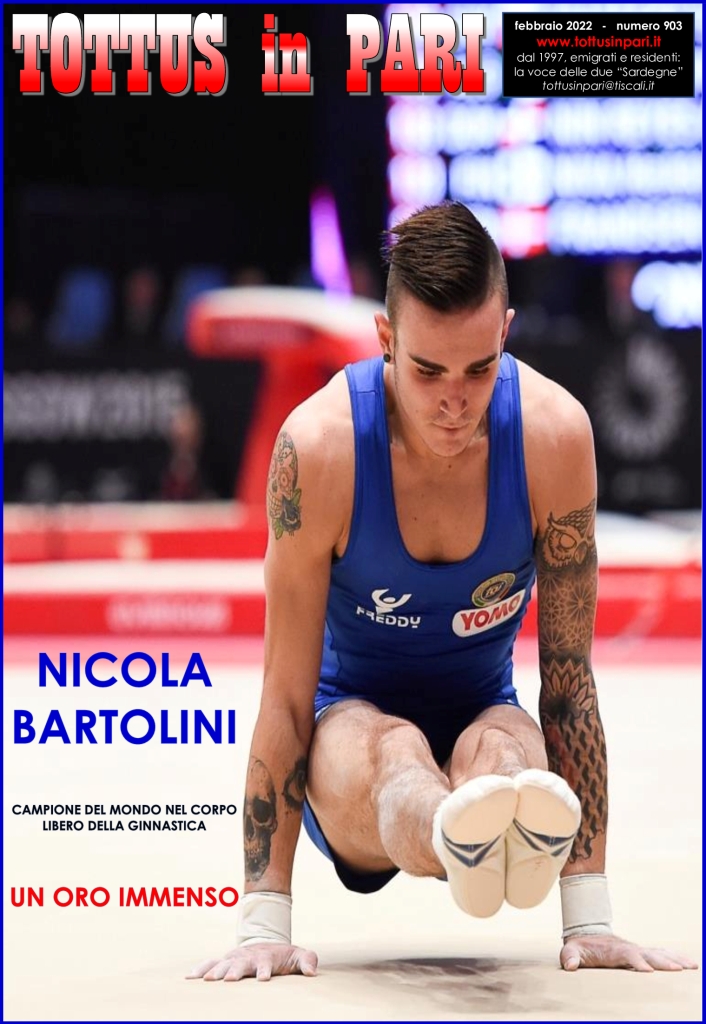“EL PINCIPE” ENZO FRANCESCOLI: UN CALCIATORE CHE NELLA STORIA DEL CAGLIARI HA LASCIATO IL SEGNO
C’è il Re, O’Rey (Pelè); c’è l’Imperatore (Adriano); c’è il Kaiser (Beckenbauer); ci sono stati baroni (Liedholm, Causio), e anche un Principe (Giannini), ma nell’araldica del calcio internazionale, con tutto il rispetto per l’ex capitano della Roma, il vero e unico Principe risponde al nome e al cognome di Enzo Francescoli. Lo chiamavano così per la classe sopraffina, per l’incedere elegante, per il portamento aristocratico, dentro e fuori dal campo. Aveva un modo di giocare in punta di piedi, come se non fosse in un prato verde popolato da 22 energumeni, ma si trovasse ad un ballo dell’aristocrazia nella sala di un palazzo ottocentesco, stucchi e arazzi, gli uomini in smoking, le donne impeccabili in pizzi e merletti. Il suo calcio era un valzer suadente, leggero, raffinato, eppure allo stesso tempo ritmico, corposo, concreto. Un genio che ha ispirato scrittori come Galeano e che è passato dall’epoca d’oro dei numeri 10, gli anni ’80 (Zico, Maradona, Platini, Antognoni e scusate se è poco), alla decade dei ’90 portabandiera del muscolo come unica unità di misura accettata per giudicare il valore di un giocatore. I tifosi gli hanno voluto bene. In Uruguay perché considerato erede di Schiaffino, il leggendario regista della Celeste campione del mondo nel ’50 e in seguito fuoriclasse al Milan; al River, dove è stato in due riprese, è ritenuto alla pari di altri fenomeni che hanno segnato la storia di questo club; e al Cagliari, beh, forse soltanto Riva lo precede nella classifica dei giocatori più ammirati. Dagli spalti del Sant’Elia un ragazzino di nome Andrea Cossu lo guardava a bocca aperta e prendeva nota di qualche trucco del mestiere. Non era l’unico. Un paio di anni prima, dalla Curva del Velodrome di Marsiglia, lo applaudiva un altro adolescente, di origine berbera, dagli occhi di ghiaccio: Zinedine Zidane. Proprio lui, il “10” versione 2.0 dei campioni anni ’80, perfetto anello di congiunzione tra due epoche calcistiche, capace di coniugare tecnica e fisico, visione di gioco e atletismo. Zidane ha chiamato il figlio Enzo, proprio in onore di Francescoli, un omaggio per il suo idolo degli anni giovanili. Il Principe prendeva calci a raffica e non si lamentava mai. Si rialzava, una smorfia, un’occhiata comprensiva verso l’avversario e via a divertirsi ancora con il pallone. Quel che non poteva soffrire erano i falli proditori, tesi a fare male. “Ci guadagniamo tutti da vivere tirando calci al pallone, se rompi le gambe a qualcuno gli fai perdere il lavoro e il sostentamento alla sua famiglia”. Soltanto una volta, a memoria d’uomo, gli saltarono i nervi. Successe in una partita di Coppa America, quando diede una testata ad un avversario, reo di avere colpito a tradimento il compagno Alzamendi. Reazione sbagliata, ma non poté fare altro. “Dovevo difendere il mio compagno”, disse scuotendo la testa con quella tipica monoespressione a metà tra il pigro e il disincantato.L’Uruguay è un caso unico al mondo. Un paese con poco più di tre milioni di abitanti, che, seppure con alti e bassi, fa parte in modo stabile del G8 del calcio mondiale. I bambini maschi giocano tutti al pallone: è la quantità che fa la qualità, altrimenti non sarebbe possibile costituire una squadra competitiva. Se è vero, come sostiene Oscar Washington Tabarez, che ogni paese dovrebbe giocare a calcio come sente la vita, l’Uruguay è sempre stato in trincea. L’Uruguay, piccolo macigno schiacciato tra due colossi come Argentina e Brasile, ha dovuto tirare fuori le unghie per sopravvivere. Da qui la “garra”, la proverbiale grinta che gli uruguagi mettono in campo, una specie di filosofia di vita. Sangue e cuore, sono queste le caratteristiche dei giocatori di Montevideo e dintorni. Ma a volte la “garra” non basta. Quando Enzo si rivelò, giovanissima stellina di un club di secondo piano, i Wanderers Montevideo, la Celeste attraversava uno dei momenti più bassi della sua storia. Estromessa dalla fase finale di due Mondiali consecutivi, aspettava un nuovo profeta in grado di ridare lustro a trofei impolverati, tramontata la generazione dei Morena e dei Victorino (ahi). Aspettava Enzo, che a soli 22 anni trascinò la Nazionale al primo trofeo internazionale dopo diciassette anni di attesa: la Coppa America, in finale contro il Brasile. Si trasferì al River Plate, la squadra più forte d’Argentina, vinse due volte il titolo di capocannoniere, fece spellare le mani al pubblico del Monumental. L’Europa iniziò a corteggiarlo. In modo particolare la Juventus, alla ricerca di un degno erede di Platini. Non se ne fece nulla e forse è stato meglio così. I due, accumunati da una grande classe naturale, erano troppo diversi. Platini era un regista universale col vizio del gol e dell’assist; Enzo era più artista, estemporaneo. A sorpresa scelse la Francia, attirato da un progetto ambizioso. Jean-Luc Lagardère, boss della Matra, società con interessi nell’aeronautica, nelle telecomunicazioni, nei trasporti e in mille altre cose, sognava di rendere vincente Parigi anche nel calcio, che Oltralpe vedeva tradizionalmente vincenti i club di provincia. Eccolo allora acquistare il glorioso ma decaduto Racing, e imbottirlo di stelle. Enzo era la più fulgida. Purtroppo nel calcio uno più uno non fa due, Parigi all’epoca ostentava distacco verso le foot, insomma per farla breve i risultati non arrivarono e neanche il consenso del pubblico. Enzo però aveva conservato le promesse, al punto che se ne andò all’Olympique Marseille. Ambiente completamente diverso, una città pazza per il calcio. La finale di Coppa Campioni sfumò in una discussa semifinale contro il Benfica di Eriksson, quando i portoghesi si imposero con un gol palesemente segnato di mano. Una immensa delusione per Enzo, da sommare a quella dei Mondiali ’86 e ’90. Non era riuscito a diventare leader di una Nazionale modesta, solo “garra”, anche oltre i limiti e poco più. Si rifece con la seconda Coppa America, vinta addirittura a Buenos Aires, in casa di Maradona (che per inciso, per lui ha sempre speso parole di stima e ammirazione). In Francia ormai Enzo scalpitava, aveva bisogno di altre sfide. Voleva l’Italia, dove si giocava il miglior calcio al mondo. Il Cagliari arrivò al momento giusto. Tonino Orrù era stato ospite fisso del ritiro nella Celeste durante Italia ’90, aveva già provveduto ad acquistare il solido Herrera e il promettente attaccante Fonseca. Un giorno Paco Casal, onnipotente agente con in mano tutto il portfolio del pallone uruguagio, gli propose di portare a casa anche Francescoli. Orrù rimase di sasso, pensava che lo stesse prendendo in giro. Un fuoriclasse del genere, nel Cagliari? Ma Orrù è un uomo pratico, colse al volo l’occasione. E iniziò il mito dei tre uruguayani in rossoblù. Non che furono tutte rose e fiori. Il Cagliari il suo numero “10” l’aveva già, Gianfranco Matteoli. In realtà non c’erano certo sovrapposizioni di ruolo. Matteoli dirigeva le danze di centrocampo, Enzo fu sistemato in attacco, al fianco della prima punta. Il problema era che la squadra, composta da giocatori all’esordio nella massima serie, difettava della giusta esperienza; e furono dolori, contro le corazzate che allora incrociavano le acque della Serie A. Per giunta, Enzo soffriva di una microfrattura al perone. Andava in campo grazie alle infiltrazioni, ma a stento si reggeva in piedi. Narra la leggenda che uno dei senatori della squadra andò a urlargli in faccia a muso duro, invitandolo a togliere fuori gli attributi. Glaciale la risposta di Enzo, un silenzio colmo di significati e uno sguardo impassibile. Non amava parlare, preferiva i fatti del campo. Aveva solo bisogno di tempo e di guarire dagli acciacchi. Con Fonseca ristabilito pienamente e l’esplosione di Herrera, Enzo fu tra i protagonisti di una salvezza insperata. L’anno dopo i rossoblù partirono come meglio non avrebbero potuto, matando al Sant’Elia la Sampdoria di Mancini e Vialli neo campione d’Italia. Uno storico 3-2, cu
Aggiungi ai preferiti : Permalink.