C’è stato un tempo in cui il forno sardo era accessorio domestico immancabile. Verrebbe da dire che un tempo sull’isola ce ne fosse uno per ogni donna, ma forse è un’esagerazione. Più probabile ce ne fosse uno per ogni famiglia o quasi. E’ certo che chi non poteva averlo usava quello dei vicini perché fai su pani in domu era una cosa più che naturale. Nella mia zona d’origine (campidano) il forno si trovava fuori dalla casa, nei casi più fortunati la bocca stava nella cucina e il corpo del forno all’esterno, era alto e facilmente accessibile. Nella mia zona d’adozione (goceano) il forno stava dentro la casa, e già che le case erano piccole al forno era riservato l’ultimo piano. La location era un po’ scomoda, l’accesso ripido ma tant’è, c’era e ce lo si faceva bastare. Era basso, aveva una bocca medio piccola e una profondità sorprendente. Le donne lo accendevano durante la lievitazione del pane conclusa la quale veniva infornato e cuoceva, a seconda della tipologia, per un ora o per pochi minuti. Alcune stavano in piedi mentre infornavano e sfornavano, altre sedute, gambe incrociate e schiena china.Qualunque fosse la postura, dettata dalla tipologia di forno, una cosa non cambiava mai: infornare e sfornare stancava, ma insieme con la fatica si toglieva dal fuoco l’orgoglio delle casalinghe isolane già che era in base alla capacità di produrre pane decorato, bello, croccante, fine, ben cotto, alto o basso che si decideva la bravura della donna e che la massaia era ritenuta un bocconcino più o meno apprezzabile. Si diventava allora immediatamente una bona meri ‘e domu nel campidano e una mathaxa de oro barbaricina. Si legava il forno a una delle attitudini ataviche della donna: sfamare i propri figli e la propria famiglia. Sfamarli con del buon pane era un po’ come rimetterli al mondo ogni volta, tant’è che i forni isolani, tutti e nessuno escluso, ricordano nella forma un grembo materno e sono cosa di domino esclusivamente femminile. Anche tutte le leggende che gravitano intorno a su forru hanno una spiccata connotazione femminile che ancora oggi si percepisce intensa e scontata.
Forno, pane e leggende
Cominciamo da lontano, cominciamo dal lievito. Le sarde, leggenda vuole, non lo hanno conosciuto da sempre, e le cose forse stavano davvero così. Pare che a rubarlo, il segreto del lievito intendo, perché di segreto si trattava, sia stata Maria, figlia di Anna. Non una Maria qualunque, ma quella che poi diventerà la Madonna e porterà alla ribalta anche la sua famiglia facendo diventare la madre una vera e propria santa, amatissima in Sardegna. Sant’Anna appunto è la Santa che un tempo si invocava quando si panificava. La si chiamava sa mama manna e sembra essere addirittura più importante di Maria. I bambini appena nati, assimilati al grano o forse a bei panini, venivano posti nelle ceste utilizzate comunemente per conservare il pane: si diceva che in quel modo sarebbero stati protetti da qualsiasi malaugurio. Lo si faceva in special modo per proteggerli da sa Koga, ma questo argomento teniamocelo buono per un’altra volta. Le donne che in Sardegna compivano azioni poco apprezzate socialmente nelle leggende venivano punite in maniera piuttosto esemplare. Alcune venivano pietrificate, e a girare in tondo per l’Isola se ne trovano ancora tante, con tutto intorno grano e arnesi per il lavoro, seni pesanti e secchi. Vedere il seno lungo e secco significa in termini concreti perdere la capacità di nutrire, con il latte, i propri figli. Quindi perdere la capacità di riprodursi. Una punizione esemplare in una società che tutto faceva in nome e per conto della fertilità e dell’abbondanza. Tant’è che un tempo per augurare disgrazia a una donna le si diceva “Ti si sicchen sas tittas” (Turchi – Maschere, miti e feste della Sardegna). Non è un caso che in Sardegna esistesse una pietra amuleto utilizzata appunto per evitare questo tipo di problema, evidentemente molto sentito. Era bianca e si portava a contatto con i seni. Si chiamava perda de latti o pedra de latti, ma questa è un’altra storia. Se non credi che il forno e la panificazione siano cose antiche e legate alla donna come l’uomo lo era al suo bestiame leggi qui: “Qualche volta, specialmente d’inverno nei centri più freddi, ci potevano essere dei problemi di lievitazione a causa della bassa temperatura, inconveniente cui si rimediava infilando per un attimo le sfoglie di pane nel forno, senza neppure toglierle dalla pála ‘e kòkere. Per questa operazione è stato segnalato a Núoro, Orgòsolo e altri paesi del centro il termine inkrepjare, un derivato di krépja “chiesa” che, propriamente, indica la cerimonia religiosa di purificazione delle madri dopo il parto, che a prima vista ha assai poco da spartire con la lievitazione e il forno: «La prima uscita della puerpera è per andare in chiesa a “purificarsi”; infatti dal momento del parto il diavolo ha acquisito su di lei un particolare potere, da cui si libererà con l’aiuto del prete. Si reca in chiesa col neonato, che protegge come un “angelo” dalle grandi tentazioni delle potenze infernali, e porta con sé una candela di grandi dimensioni. Si inginocchia davanti alla porta della chiesa; il parroco, che già l’aspettava, l’asperge d’acqua benedetta a rispettosa distanza e scaccia con preghiere il diavolo; poi si avvicina alla puerpera, posa sul bambino un lembo della stola e accompagna a braccetto la madre all’altare della Vergine Maria, dove questa accende la candela, s’inginocchia, riceve la benedizione e si considera così purificata. ».Per intendere il vistoso spostamento di significato che il vocabolo ha subìto, è utile quanto ci è stato riferito a Bitti, ove un’informatrice ha spiegato che, al verificarsi dell’intoppo sopra ricordato, si dava alla pasta unainkrejatèdda, ossia la si infilava nel forno giusto per il tempo di una preghierina, paragone temporale che già potrebbe chiarire l’accostamento con la cerimonia descritta in precedenza: in sostanza, così come la puerpera trae giovamento dall’entrata in chiesa, altrettanto fa la pasta, nella situazione critica in cui la lievitazione è a rischio, entrando nel forno. Forse, però, c’è nell’immagine anche un paragone scherzoso fra l’antico forno, a forma di cupola, e la chiesa, ciò che sembrerebbe confermato anche da alcuni proverbi ed espressioni, qualiquie non hat bidu Cheja, ad su furru si adorat – chi non ha visto chiesa, adora il forno, detto sempre a proposito di chi si meraviglia di ogni piccola cosa” e ancora “s’anta de su furru li paret un altare – la bocca del forno gli sembra un altare. Non ci sentiremmo neppure di escludere, infine, che l’impiego del verbo inkrepjare in relazione a un momento specifico del ciclo del pane possa in qualche modo e in qualche misura portare ad affioramento un condizionamento assai antico legato alla sacralità del forno (Giovanni Lupinu, in Pani – Ilisso)”. Ereditare un forno tradizionale oggi è uno dei più bei regali che si possano ricevere, è un po’ come ereditare un frammento di propria storia, è un p0? come ritrovarsi nel passato vivendo golosamente il presente. Ereditare un forno tradizionale oggi è un onore e un onere perché con gesti moderni la storia passata può ancora vivere.






























































































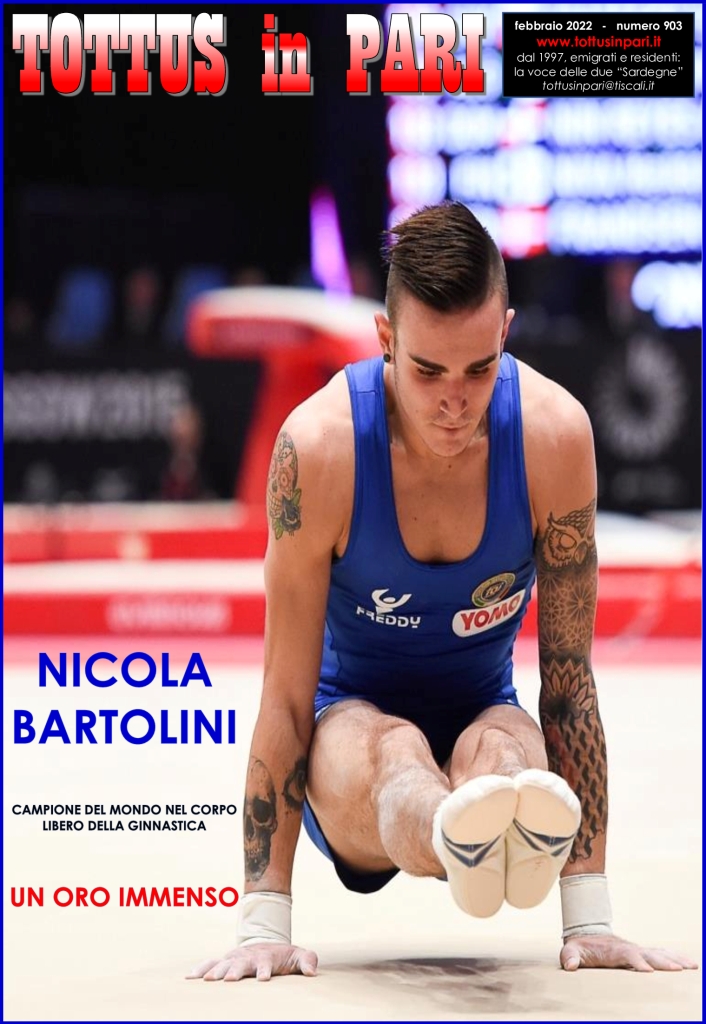











Ho notato che in Barbagia il forno è giu, quasi a livello del pavimento e le donne lavorano sedute. In campidano il forno è in alto.. si lavora in piedi. Bellissimii e che profumo dai comignoli all’alba !
Per caso, con mia madre qui, abbiamo discusso anche di pane, del pane di “allora”… Della sua bontà, ma anche de “is errigusu segausu, e su sooonnuuu! No ndi podia prusuuuu”….
su ki fanti oindì no est prus pani esti una porcheria.