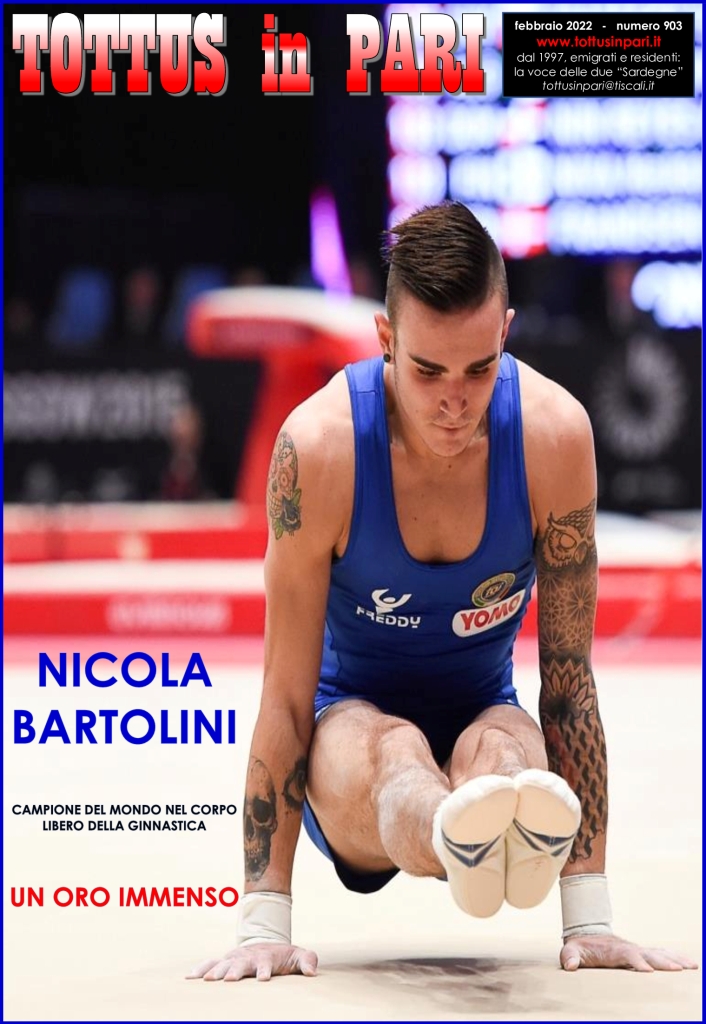Tra le fonti orali che, come è noto, contano eccome per chi si ponesse in mente di fare il mestiere di storico o più prosaicamente quello di giornalista, per quanto riguarda l’8 settembre del ’43, ne posso esibire una di prima mano: quella di babbo. Lui in realtà non era ancora babbo mio, l’incosciente ventinovenne sergente maggiore carrista del regio esercito italiano aveva impalmato la mia futura mamma Pinuccia giusto quattro mesi prima in quel di Guspini, ed era in Sardegna solo perché in Africa Orientale si era preso la malaria ed era scampato al disastro di EL Alamein e alla disfatta del contingente militare italiano che aveva combattuto con Rommel e ne aveva seguito trionfi e sconfitte, fino a quella finale . Quando il generale Antonio Basso, comandante le forze armate sarde che comprendevano anche una Divisione tedesca di 25.000 uomini, decise che non era proprio il caso che i soldati italiani ai suoi comandi dall’oggi al domani, come pretendeva il proclama del “generalissimo” Badoglio, prendessero ad ammazzarsi con gli alleati tedeschi del giorno prima, fece loro da scorta sino a che si imbarcarono alla Maddalena per la Corsica. Quasi senza colpo ferire. Babbo, mi diceva, ebbe l’ordine di seguire la retroguardia tedesca in motocicletta e, dopo una curva cieca si trovò i tedeschi così vicini che i freni della moto parvero azionarsi spontaneamente, tanto da fargli fare un bel volo sulla carreggiata. Fine della testimonianza, che babbo non amava proprio per niente rievocare quegli anni di travagli, del resto a mitragliare il treno con cui lui e mamma andavano in “luna di miele” a trovare i parenti in “cabesusu” erano stati gli Alleati, i nemici di prima, Americani o Inglesi che fossero, gli stessi che bombardando Gonnosfanadiga nel febbraio avevano fatto un centinaio di morti e non so quanti feriti ( per tacere dei bombardamenti cagliaritani), in un paesino di neanche 5.000 abitanti. Da qui la vulgata che i sardi non presero parte alla resistenza. In realtà i sardi che combatterono nelle brigate partigiane furono migliaia, sui quattromila dicono le fonti ultime, e migliaia furono quelli che si rifiutarono di indossare le mostrine della Repubblica Sociale messa su da Mussolini, reduce dalla prigione del Gran Sasso e prima ancora della Maddalena, mercé l’azione da commando dell’SS Otto Skorzeney, finendo nei lager nazisti con gli altri 650.000 soldati e i 22.000 ufficiali che “non aderirono” a Salò. Preziosi quindi i libri come questo che si presenta al circolo sardo di Vimodrone: “Pitzinnos Pastores Partigianos, eravamo insieme sbandati”(ed. Anpi Nuoro) con in sala due degli autori: i bittesi Natalino Piras e Pietro Dettori (gli altri due: Salvatore Muravera e Piero Cicalò), a far loro da contralto Tonino Mulas che pure scrisse un libro sull’argomento (prefazione di Oscar Luigi Scalfaro) e Andrea Pollio vicepresidente nazionale dell’Anpi. Il libro, imponente nelle sue cinquecento pagine, tocca leggerlo come fosse un componimento epico, inframmezzato com’è di poesia e di trascrizioni d’interviste ai sopravvissuti agli avvenimenti guerreschi che narra. Sono solo gli dei che scelgono a data della tua nascita il ’22 o ’23, magari a Orgosolo o Bono o Bitti. E allora sei quasi sempre pastore di pecore quando “ti chiamano alla leva” nel novembre del ’42. Scrive Luigi Podda, di Orgosolo, nel suo “Dall’ergastolo” (La Pietra, 1976): “…nella primavera del’42 comperammo un bue da lavoro pagandolo con alcune pecore… per lavorare alcuni piccoli orti che avevamo in comproprietà con altri parenti a pochi chilometri dal paese…a lavorare gli orti erano sopratutto le donne… esse svolgevano anche altri lavori di campagna, come zappare, mietere il grano, raccogliere le olive, mandorle e altri frutti, e ghiande per le pecore e per ingrassare il maiale… ancora adesso mi chiedo come le nostre donne riuscissero a fare tanto lavoro…”. E’ a queste mamme che si scrive in italiano magari non perfetto: “ Carissima mamma, da Alghero il 10 (luglio del 1943) ci anno partito invia aerea al campo di Roma, siamo arrivati sani abiamo fatto un bel viagio…pare che ci prendono aperugia a fare il reclutamento…”. Lettera di Nenneddu Sanna ( pag.100), non torrerà “a domo”. A Perugia si troverà assieme ai corregionali, in aviazione, e assieme a loro si scontrerà due mesi dopo questa missiva nel terremoto dell’8 di settembre. L’esercito italiano si scioglie come neve al sole, il re e i generali comandanti la nazione scappano a Brindisi, i tedeschi rimangono padroni d’Italia e sospinti dalle truppe alleate risalgono la penisola facendo stragi di civili inermi, colpevoli le più volte di aver “aiutato i partigiani”. I “Peruginos” sardi sbandati nelle campagne laziali si arrangiano come possono: banditando. Rubando pecore e aiutando i contadini in cambio di poco cibo e poco alloggio. Alcuni di loro incappano, ancora con indosso una divisa, nelle truppe tedesche, e vengono trattati come disertori e fucilati. Altri mandati a nord e “arruolati” nel nuovo esercito mussoliniano. E’ un bel gruppo quello che si strappa il teschio fascista dal basco nero e sceglie, assai poco consapevolmente in verità, di passare con la guerriglia partigiana di Tito che opera nella Venezia Giulia. E continua a banditare. Contro i tedeschi, sino al 25 aprile del 1945. La liberazione. Forse per l’Italia non certo per la Venezia Giulia. Terra di confine contesa tra popoli e nazioni, “italianizzata” dai fascisti sin dagli anni venti: ne fecero di tutti i colori per cancellare ogni traccia di slavo. Così che con l’8 settembre si cominciò a sentir parlare di “foibe” e “infoibati”, a centinaia, fascisti ma non solo, e donne e bambini. Meno male che presto arrivarono i tedeschi a mettere ordine, Hitler voleva tutto il Veneto per il suo nuovo costruendo Reich. I partigiani sardi combatterono assieme agli sloveni nelle brigate comuniste, sopratutto. Ma mai neanche lo diventarono comunisti, certo non vollero essere nazisti. Non è un caso che questi, tra le prime cose atte a segnalare che una nuova amministrazione era in atto, immediatamente mettono in funzione un campo di sterminio, con tanto di forno crematorio, e alle porte di una grande città come Trieste: la famigerata risiera di San Sabba. Dove finiscono la loro vita ebrei italiani e disertori e partigiani. Aiutati in questo, occorre ricordarlo, dai repubblichini di Salò. Quindi quel 25 di aprile che per l’Italia è liberazione, per Trieste e l’Istria è incubo rinnovato di foibe. A migliaia sono gli italiani che vengono uccisi e gettati in queste doline carsiche, sorta di pozzi che per centinaia di metri si perdono nelle crepe del terreno, dalle milizie slovene di Tito che in una sorta di contrappasso tragico vuole “slavizzare” il territorio conquistato liberandosi da ogni italianità. I partigiani sardi fortunatamente non parteciparono di tante atrocità, certo dicono della facilità con cui “gli slavi” sparavano alle persone anche solo sospette di collaborazionismo. Furono tempi feroci. Non sorprende che quasi tutti quelli che tornarono nei loro paesi d’origine preferirono non raccontare, erano ragazzi di vent’anni quando partirono e ne avevano ventitré quando tornarono, a fare i pastori, i contadini. Gli anni passati a fare i partigiani come un brutto sogno da buttarsi alle spalle. Un brutto sogno che non vuol passare, che quando danno un film alla televisione e vedi le uniformi tedesche ti prende un crampo allo stomaco e non riesci a resistere alla finzione e te ne scappi. Se oggi alla Risiera di San Sabba e ad Auschwitz e a Dachau ci vanno i ragazzi delle scuole per ricordare a quale pericolo è scampata l’umanità tutta, lo si deve anche al sacrificio della vita di tanti ventenni, che magari parlavano poco e male l’italiano e che di Trieste e del Carso avevano sentito dire dai loro padri, che da quelle parti a sparare c’erano stati con le mostrine rosse della “Sassari”. Molti di loro, “dispersi”, sono stati pianti nella solitudine delle famiglie e delle case
, dice bene Bachiso Bandinu: “Non vogliamo più piangerli come assenti, isperdidos in gherra, zente chi no est torrata, vogliamo che la memoria si faccia rito della presenza, dove la preghiera ha un luogo affinché la comunità si ricomponga nella totalità dei suoi figli”. E ancora: “… gli eventi dolorosi dei pitzinnos-pastores-partigianos è anche un messaggio che parla al presente perché della testimonianza di lotta per la libertà il nostro tempo ha un gran bisogno…La storia ci appartiene, dimenticarla significa ingannare il presente e oscurare l’avvenire”.
PER NON DIMENTICARE GLI EVENTI DOLOROSI DEI PINZIMONI-PASTORES-PARTIGIANOS E GLI ISPPERDIDOS INGHERRA”: INIZIATIVA A VIMODRONE DEL CIRCOLO “LA QUERCIA”
Aggiungi ai preferiti : Permalink.