di Aldo Aledda
Trattare dell’associazionismo e della politica regionale in materia, in fondo è la stessa cosa. I due fenomeni sono nati insieme (o quasi), si sono sviluppati in modo complementare e avanzano ancora strettamente connessi. La Sardegna è stata tra le prime regioni italiane a intervenire massicciamente e organicamente a favore dei propri emigrati in Italia e all’estero (ma la prima fu la Provincia Autonoma di Trento, nel 1953), ponendo sullo stesso piano di quella estera la meta nazionale. Con la legge n. 10 del 7 aprile 1965 (istitutiva del “Fondo sociale della Regione Sarda”), a flussi migratori ancora in atto la Sardegna impiegava proprie risorse finanziarie a sostenere gli emigrati e le loro famiglie. Un regolamento di attuazione della legge, abrogato nel 1991, ne regolava gli aspetti specifici. Se la Regione, nella logica del sostegno individuale, agevolava il rientro dei migranti (finanziando il cosiddetto “trasporto delle masserizie”, oppure concedeva sussidi a chi si trovava in difficoltà nel paese di accoglienza o organizzava colonie per i figli degli emigrati, ecc.), non minori attenzioni riservava proprio all’associazionismo. Infatti, una fetta consistente del bilancio in materia di flussi migratori s’indirizzò fin d’allora verso i “circoli degli emigrati”, benché si riconoscesse in essi solo una piccola parte della popolazione isolana trasferitasi nella Penisola e all’estero, desiderosa più di altre di mantenere le proprie radici.
Infatti, questa non costituiva più dell’uno o due per cento della massa degli emigrati sardi all’estero. Era, però, disposta a farsi riconoscere dalle istituzioni (sarde e italiane); con essa, pertanto, occorreva fare i conti se si voleva dialogare con l’universo isolano che stava fuori dai confini della regione (anche perché i sardi, una volta che si trasferiscono all’estero, mostrano non troppa propensione a manifestarsi come tali). D’altra parte queste formazioni – lungo una tradizione di associazionismo italiano che risaliva all’Ottocento – rappresentavano qualcosa di più di un mero fatto ricreativo: tante volte funzionavano come servizio sociale e sanitario, nella misura in cui si prodigavano a fornire informazioni sulla Sardegna e sui suoi prodotti oppure, alla stregua di agenzie turistiche, predisponevano volontariamente servizi di bigliettazione agevolata per passaggi in nave per l’isola a favore dei sardi residenti nella loro circoscrizione, ecc.. Nelle pionieristiche sperimentazioni di esportazione dei prodotti sardi – prima che questi fossero reperibili presso negozi o supermarket della zona, come sempre più frequente accade oggi – fungevano anche da punti di raccolta e di smistamento, in raccordo in genere con i primi volenterosi esportatori (spesso alcuni degli stessi emigrati con una maggiore vocazione per l’imprenditoria). Infatti, da molti piccoli centri dell’interno dell’isola, fin dagli anni Settanta, i pionieri dell’esportazione sarda battevano le zone dell’Italia del Nord e dell’Europa, dove più numerosa era la presenza di corregionali, proponendo vini, formaggi, salsicce, pane carasau, gnocchetti e dolci sardi; inizialmente ricorrendo a mezzi di fortuna ma poi, dagli anni Ottanta, costituendo autentici magazzini oppure, come capitò a Londra, facendosi ospitare in più ampie strutture di raccolta della produzione agroalimentare italiana. E la Regione non poteva non vedere che di buon occhio codesto attivismo commerciale.
Questi avamposti associativi, soprattutto dalla fine degli anni Settanta, si adoperarono intensamente per promuovere l’immagine dell’isola presso le comunità locali. E ciò avveniva senza alcuna contropartita che non fosse, alla fine dei conti, di poter contare su una sede in cui ritrovarsi e rafforzare la propria identità regionale. Sintesi significativa di quest’impegno erano le classiche “settimane sarde” (sostenute in gran parte con contributi regionali), in cui, non solo la comunità dei sardi, ma anche quella locale, si radunava a consumare i prodotti provenienti dalla Sardegna e ad assistere alle iniziative folkloristiche e culturali che facevano da corona (balli e canti sardi, conferenze, mostre, ecc.); in questi casi spesso era proprio la comunità locale più di quella sarda a mostrare interesse per quanto proveniva dall’isola. Capitò anche che le associazioni dei sardi fossero animate proprio da “stranieri” (spesso mogli o mariti di sardi), nonostante questi non potessero ricoprire ruoli dirigenziali di primo piano per effetto delle interpretazioni restrittive delle normative regionali che richiedevano per il loro esercizio il possesso di un’immaginaria “nazionalità” sarda.
La finalità sociale e persino ricreativa della costituzione di queste associazioni e il sostegno che diede originariamente la Regione a codeste aggregazioni di sardi “lavoratori”, non mancò di creare col tempo qualche problema in relazione alla loro base sociale. Infatti, a prescindere dalla connotazione paesana o dalla provenienza da determinate zone della Sardegna, che stava all’origine di molte di loro – e talvolta agiva da ostacolo verso i sardi provenienti da altre parti dell’isola (spesso i circoli erano designati informalmente sulla base del paese da cui proveniva la maggior parte dei soci) –, per gran parte di esse acquisiva una valenza decisiva il dato della connotazione sociale. In questo senso, se il circolo non si qualificava fin dalle origini come “interclassista” – come capitò in alcune grandi città, soprattutto dell’Italia settentrionale, in cui si erano trasferiti diversi corregionali per l’esercizio di professioni pubbliche di un certo livello (medici, magistrati, professori universitari, ufficiali superiori, ecc.) –, in genere finiva per essere frequentato da colletti blu o da piccoli artigiani, che si ritenevano gli esclusivi beneficiari dell’intervento regionale. D’altro canto, la stessa normativa regionale, parlando di interventi a “favore dei lavoratori emigrati” giustificava il sostegno finanziario della Regione soprattutto in funzione dell’anello socialmente più debole dell’emigrazione sarda, ossia la classe lavoratrice.
Gli elementi sociologici non sono di secondaria importanza nella storia dei circoli, giacché gli aspetti sociali sono spesso diventati pretesti per polemiche ed esclusioni. In omaggio al concetto allora imperante, e oggi ampiamente riveduto, della monocausalità dei flussi migratori – ossia che autentici fossero soli gli economic migrant – capitò, per esempio che fosse contestata la qualifica di “emigrato” ai funzionari statali o ai militari trasferiti nell’Italia settentrionale. Il fatto che quest’impostazione fosse accolta nella legge del 1965 – in particolare nel regolamento di attuazione che escludeva dalle sue provvidenze questa categoria di sardi residenti all’estero (anche se poi scomparve nelle successive enunciazioni legislative) –, in qualche modo rafforzò e giustificò l’azione di chi premeva sull’istituzione regionale perché non prendesse in considerazione come “circoli” e non concedesse ausili finanziari alle aggregazioni in cui la presenza di quei soggetti apparisse prevalente e caratterizzante. Contrastava contro tutto ciò il dato innegabile che la classe dirigente del mondo dell’emigrazione, anzi la leadership internazionale di questa, proveniva proprio da quei sardi trasferitisi all’estero cui si contestava la qualifica di “emigrato” (più della metà dei presidenti della FASI, per esempio, proveniva dal mondo dei “funzionari” e, a memoria di chi scrive, non si è mai dato un vicepresidente vicario della Consulta Regionale dell’Emigrazione sarda che appartenesse alla classe operaia). In buona sostanza, nei circoli – frutto anche di antiche contrapposizioni ideologiche e politiche – si attuava una discriminazione sociale al rovescio. Essa, comunque, contava importanti eccezioni, costituite soprattutto dal fatto che gli esponenti delle classi dei funzionari, dei professori e dei medici, in nome della comune origine regionale o di un condiviso sentimento politico di sinistra, ben volentieri si prestava a mescolarsi con operai e muratori. Tuttavia, alla lunga, questa caratterizzazione classista si rivelò negativa e incise sulle possibilità evolutive di queste aggregazioni, perché quando – abbandonati i vecchi cliché – si pensò al circolo come “ambasciatore della Sardegna”, si scoprì che esso non aveva né la cultura né il personale all’altezza di questo compito. Per conseguenza, anche l’innesto di sardi di seconda generazione – spesso con elevate competenze culturali e professionali – in un tessuto culturalmente connotato in quei termini, si rivelò un’operazione tutt’altro che semplice.
Tuttavia, nonostante questi limiti, alcuni circoli sardi ottennero risultati discreti anche nella promozione di attività che implicavano un notevole sforzo organizzativo e avevano ambizioni culturali ed economiche non di poco conto, gratificando la stessa Regione che li sovvenzionava. Il caso del premio di poesia sarda, che si organizza periodicamente a Milano (tipico caso di circolo “interclassista”), con il concorso di centinaia di sardi, ne è la dimostrazione. In alcuni angoli del pianeta si creò un raccordo con le università locali (talvolta coinvolgendo anche quelle sarde). Per esempio, in Germania l’interesse per la lingua sarda, che vantava in quel paese antiche tradizioni di studio (famoso il primo dizionario sardo del Wagner), è stato sempre coltivato dai circoli più sensibili coinvolgendo studiosi di alto livello e istituzioni universitarie. Altrettanto si può dire per la musica etnica, che trovò importanti attenzioni negli ambienti colti della Germania e degli Stati Uniti, soprattutto in ordine allo strumento delle Launeddas e ai canti “a tenores”. Le iniziative divennero più organiche quando la Regione, negli anni Ottanta, fece un’universale operazione di costituzione presso ogni associazione dei sardi di una biblioteca di libri sardi, laddove nei circoli costituiti in città sedi di università tale dotazione fu raddoppiata in quantità e migliorata nella qualità (in qualcuna, come Toronto, la biblioteca del circolo fu collegata in via informatica a quella della sede universitaria). Soprattutto negli anni Ottanta e Novanta i circoli sardi rappresentarono la punta di diamante dell’associazionismo italiano ed erano continuamente citate come esempi di proficuo investimento di denaro pubblico.
Come si attuava l’intervento regionale?
A favore dei circoli degli emigrati era previsto un contributo fisso per le spese di gestione della sede e un altro, variabile, a seconda del numero e la qualità delle attività svolte. Viceversa, aspetto abbastanza singolare, ma che rispecchiava in qualche modo la cultura amministrativa dell’epoca – ispirata a scientificità e illuminismo – fu prevista, nella legge del 1965, la realizzazione di un’indagine dell’emigrazione sarda che, tuttavia, si poté effettuare solo tra il 1984 e il 1989, giacché in precedenza quest’adempimento non era apparso urgente ad alcun amministratore regionale. La ricerca, condotta in tutto il mondo da un’équipe di studiosi e coordinata da una commissione composta da professori sardi presso università italiane e straniere, consentì infatti di raggiungere una grande quantità di emigrati sardi e di comunità di corregionali in tutte le parti del mondo, presentando, nel 1989, un rapporto organico sulla loro localizzazione e condizioni di vita, che si rivelò essenziale per l’elaborazione delle relative politiche del settore.
La Regione – in epoca di abbondanza di risorse finanziarie e, prima tra le regioni italiane per tipologia, consistenza e qualità dell’intervento – accompagnava, dunque, con dosi massicce di finanziamenti e un rapporto attento e costante, l’avventura dei corregionali all’estero. Essa, prima ancora che fossero istituite le regioni ordinarie (cosa che avvenne nel 1970), s’inserì attivamente nei flussi migratori in atto, più precisamente innestandosi nella fase del riflusso. Infatti, se è vero che circa la metà di chi intraprende la strada dell’emigrazione rientra in patria dopo qualche anno, egualmente dei circa cinquecentomila sardi che, nell’ultimo dopo guerra, hanno scelto la meta dell’emigrazione, quasi il cinquanta per cento ha intrapreso la via del ritorno. Orbene, mettere in pratica un’operazione di rientro – da vivi o, addirittura, da morti – avvalendosi del contributo regionale per riportarsi indietro le salme o i mobili preferiti e gli oggetti indispensabili, che faceva parte del primo corpo di disposizioni, e, con la legislazione successiva, addirittura avere delle preferenze per i contributi regionali per l’acquisto della prima casa (opportunità concessa dalla legge regionale n. 7 del 1991), per molti sardi emigrare non equivalse più a fare un salto nel buio. Non solo, ma la Sardegna – che nel 1960 aveva varato il proprio piano di Rinascita – nel tentativo di arrestare l’emigrazione e favorire il rientro nell’isola, assicurava, ricorrendo a uno slogan apparentemente ben congegnato (sia pure in seguito portato a esempio di un certa leggerezza politica nel promettere ciò che non si può mantenere), che avrebbe trovato agli emigrati un posto di lavoro nell’isola. Da lì si comprende l’importanza di aver creato, a partire dalla legge del 1965, una corsia preferenziale per chi intendeva rientrare. Poi, magari le cose si rivelarono meno facili del previsto – non si mancò, infatti, di coniare il termine “seconda emigrazione” alludendo alla condizione psicologica che in genere attende chi decide di percorrere la strada all’inverso – tuttavia l’operazione creò attese e speranze in tanti sardi in tutto il mondo.
Negli anni Settanta, dunque, con l’obiettivo sia di contenere i flussi migratori in atto – prospettando opportunità lavorative per gli emigrati che intendevano rientrare in un’isola in cui iniziavano i processi d’industrializzazione – sia di attenuarne gli effetti negativi, si perfezionarono gli strumenti legislativi, assistenziali e amministrativi. E, con lo stesso intento, si succedevano le dichiarazioni dei politici (soprattutto nelle conferenze regionali dell’emigrazione che, all’epoca, si tennero in varie località della Sardegna negli anni Settanta), che individuavano nella debolezza economica strutturale dell’isola le cause dell’emigrazione e che, trattandola come una “piaga”, promettevano di debellarla in breve tempo. Da ciò conseguì la notevole attenzione per i sardi emigrati in Italia e all’estero, percepiti come corregionali “sfortunati”, caratterizzata dalla costante presenza della Regione nelle aree di emigrazione e rivolta a piè sospinto a sottolineare il carattere di temporaneità che in tutti i casi avrebbe dovuto avere la permanenza fuori dall’isola dei sardi: in vista di quell’obiettivo, dunque, si sarebbe dovuto fare in modo che non si attenuassero i legami con la Sardegna. I sardi, fuori, insomma, dovevano sentirsi prima che appartenenti a una società “straniera”, cittadini della Sardegna a tutti gli effetti, per niente rifiutati dalla terra madre. Da qui la grande disponibilità di risorse con cui si cercava di finanziare le spese dei circoli dei sardi, considerati sempre più come “pezzi” della Sardegna, in cui si “consumava” la cultura al pari dei prodotti agroalimentari dell’isola. Da qui egualmente la costante presenza di esponenti della Regione che facevano onore alle autorità del luogo, prendevano la parola illustrando le bellezze dell’isola e la generosità dei suoi abitanti. Poiché questa presenza, calata nel contesto del circolo, rivestiva un carattere di sostanza, in certi momenti non vi fu manifestazione di qualche livello, per presenza di pubblico e di autorità locali e consolari, cui non partecipasse un esponente della Regione; anzi, l’eventuale assenza era sempre deprecata con lettere di protesta, che facevano il giro di tutti i piani dell’amministrazione. I dirigenti dell’emigrazione stigmatizzavano, infatti, queste assenze definendole “occasioni mancate”, parlando di “disinteresse della Sardegna”, “insensibilità della Regione”, ecc. (non più di una volta l’amministrazione fu costretta a mandare in fretta e furia qualche funzionario a fare atto di presenza per impedire la pioggia a dirotto delle contestazioni).
IL RAFFORZARSI DEL CONTROLLO REGIONALE SULL’EMIGRAZIONE
Il sistema messo in piedi dalla regione sarda risultò più efficiente di quello delle altre consorelle anche perché essa era riuscita ad assicurarsi alcuni privilegi che altre non avevano; non solo quelle ordinarie, costituite successivamente, ma neanche – perlomeno con la stessa ampiezza – le altre regioni “autonome” varate subito dopo la guerra. Infatti, la Regione Sardegna – per un accordo particolare con l’Ufficio Italiano Cambi – era autorizzata a versare direttamente i propri finanziamenti ai circoli degli emigrati costituiti all’estero. E grazie alla sua autonomia (e all’indulgenza, motivata dalla particolare delicatezza sociale della materia, conservata dagli organi dello Stato deputati alla sua applicazione, in specie la Corte dei Conti), riuscì a non far funzionare nei suoi confronti la norma sulla “previa intesa” governativa necessaria per recarsi all’estero. Questo istituto imponeva alle regioni, anche per i più modesti impegni fuori della frontiera nazionale, di comunicare preventivamente al governo (attraverso il ministero degli esteri competente a istruire la “pratica”) i loro spostamenti (con relativa proiezione di costi) e attendere per la loro realizzazione il via libera della Presidenza del Consiglio dei Ministri (questi programmi dovevano essere presentati entro l’anno precedente alla loro attuazione e solo in via eccezionale erano ammesse deroghe). Col passar del tempo, grazie alla pressione delle regioni, la portata di questa disposizione fu notevolmente attenuata finendo per riguardare quasi esclusivamente le delegazioni regionali caratterizzate da presenza di politici, per cui gli organismi preposti furono meno fiscali nell’applicarla quando si trattava della “missione” di funzionari (che si riteneva si recassero all’estero per svolgere compiti per lo più tecnico-amministrativi).
Il clima e le caratteristiche con cui si esercitava la politica regionale erano, dunque, molto peculiari rispetto al quadro nazionale. L’utenza, cioè gli “emigrati”, era costituita da soggetti abbastanza determinati nel considerare l’accesso alle provvidenze regionali come un “diritto”. Un diritto, che si qualificava abbastanza impropriamente sotto il profilo strettamente giuridico, giacché nelle intenzioni di chi lo rivendicava acquisiva più che altro il sapore di risarcimento di un ipotetico “torto storico” consumato nei loro confronti da una Regione che era imputata di non essere riuscita a impedire l’uscita dei sardi dalla propria terra, per non aver saputo creare le necessarie opportunità lavorative sul suo territorio. Si trattava di una sorta di responsabilità oggettiva, di cui a posteriori – grazie anche al sostegno di tutto un retroterra cultural-politico ben definito, che aveva trovato comodo accodarsi a esso – si chiedeva in qualche modo conto agli ignari governanti dell’epoca. Infatti, nella psicologia, nella retorica e nelle posizioni ufficiali degli emigrati, si sarebbe potuto riparare a tale torto solo agevolandone il ritorno nell’isola, possibilmente prima della pensione, attraverso la creazione di sufficienti posti di lavoro (da lì in qualche modo la risposta indiretta della Regione attraverso il Piano di Rinascita con il già citato slogan rivolto agli emigrati: “C’è un posto anche per te!”) oppure favorendo l’iniziativa privata – in genere artigianale o piccolo imprenditoriale – degli emigrati che avevano accumulato fuori dell’isola un bagaglio di conoscenze e di professionalità (ed è la cosa che forse ha funzionato meglio nel tempo, soprattutto nel settore alberghiero e della ristorazione). Se tutto ciò non era possibile, nell’intento di chi rivendicava, la Regione avrebbe dovuto garantire il rientro dei sardi dopo il pensionamento (o almeno da defunti). Da qui la natura degli istituti che abbiamo visitato poc’anzi, che consistevano – a parte il rientro delle salme, per l’ipotesi estrema – in piccoli contributi finanziari a fondo perduto per una prima sistemazione, oppure nel concedere loro qualche titolo preferenziale nelle graduatorie per la costruzione di prime case (che, come si è detto, spesso lo erano davvero, ma non risiedendoci, figuravano fiscalmente come “seconde” case). Qualche associazione di tutela degli emigrati si attivò anche per garantire un minimo di certezze giuridiche per chi acquistava proprietà in Sardegna dall’estero, posto che al riguardo erano stati segnalati raggiri ai danni di chi non aveva la possibilità materiale di controllare direttamente questo genere di operazioni, soprattutto i passaggi di proprietà. Altre associazioni di tutela, e la Regione stessa, si adoperarono per assicurare una generica assistenza burocratica su tutto lo spettro dei problemi dell’emigrazione.
Per chi non era in grado di attuare piani di rientro immediato oppure si riteneva irrimediabilmente “condannato” a vivere fuori della Sardegna, il soccorso regionale diveniva ancora più massiccio. A parte gli interventi a favore dei singoli (borse di studio, sussidi individuali, colonie per i figli e, poi, vacanze e soggiorni per gli anziani e stage per i giovani), l’ancoraggio alla Sardegna era costituito soprattutto dal “circolo”, per quanto molti lo definissero spregiativamente e, talvolta, con una certa spocchia intellettuale, “luoghi di consumo della nostalgia”. In questo intervento la Regione in qualche modo giocava tutte le sue carte. Grazie a un sistema piramidale, costantemente oliato dai contributi e vigilato da una struttura amministrativa particolarmente attenta – che sul momento presentava solo pregi ma che, nel tempo, avrebbe mostrato tutti i suoi limiti –, l’istituzione regionale stringeva saldamente a sé tutte le organizzazioni dei sardi nel mondo, a partire dai circoli, passando attraverso le Leghe (termine tratto dal sindacalese e sostituito, nel 1991, dal più socialista “Federazioni”) e finendo con la Consulta Regionale dell’emigrazione (istituita con la legge regionale n. 36 del 1977 e presieduta dall’assessore del lavoro, competente in materia di emigrazione), che ne costituiva il vertice. Il sistema si presentava all’esterno come una struttura semipubblica accentuando maggiormente questo carattere quando, negli anni Settanta, si arrivò addirittura a stipulare delle “convenzioni” tra la Regione e i circoli, per effetto di cui essi s’impegnavano ad assicurare “prestazioni”, per lo più di natura socio-assistenziale, a favore degli emigrati sardi ottenendo, come “controprestazione”, che la Regione s’impegnasse a finanziarli per la gestione della sede e in tutte le attività. I problemi legali insorsero soprattutto a causa della natura contributiva dell’intervento regionale che, avendo la sua fonte in una legge, escludeva automatismi contrattuali di sorta, ragion per cui alla fine si decise di abbandonare il regime convenzionale. In realtà, infatti, la natura giuridica del sostegno regionale era di carattere assolutamente discrezionale ancorata solo a leggi (nello specifico quella del 1965), regolamenti e programmi dell’Amministrazione senza che, dal basso, si potessero precostituire diritti di alcun genere; al massimo potevano sorgere interessi legittimi sulla modalità e i criteri dei finanziamenti. Perciò il sistema delle “convenzioni” – in realtà ideato da politici in vena di generose concessioni e realizzato da funzionari disposti a non porsi troppi problemi di carattere legale circa queste soluzioni – non avrebbe potuto reggere nel tempo. E così fu, per cui, salvo qualche vecchio esponente dell’associazionismo che continuava a battersi per mantenere la qualificazione giuridica – mai posseduta – di “diritto” del contributo al circolo, la leva di dirigenti degli anni Ottanta preferì rinunciare lentamente a questa rivendicazione optando per una contrattazione politica e amministrativa del sostegno regionale.
Tuttavia, poiché l’idea di mantenere stretti rapporti tra i circoli e la Regione agitava sempre le menti sia dei dirigenti dell’emigrazione sarda sia degli amministratori regionali con cui essi stavano maggiormente a contatto, si elaborò la formula del “riconoscimento” ufficiale dei circoli effettuato dalla giunta regionale, con una procedura complessa che iniziava nell’assessorato del lavoro, conosceva un passaggio in sede di Giunta regionale ed era coronato da un decreto dell’assessore competente. Il riconoscimento – antesignano di quello analogo che darà in epoca successiva la Regione alle Onlus istituite nel territorio regionale con altri scopi e ad altre organizzazioni di volontariato – voleva essere il requisito del finanziamento giacché in sua assenza la Regione non avrebbe potuto incanalare risorse e altri interventi in direzione dei circoli e delle associazioni di tutela. Perciò, dal carattere più discrezionale dell’intervento regionale dei primi tempi e da quello convenzionale dell’epoca immediatamente successiva, si passò, grazie alla rigida parametrazione della legge n. 7 del 1991 (basata in genere sulla consistenza migratoria ricavata dalle statistiche ufficiali), al controllo totalitario dell’amministrazione regionale sulle attività delle associazioni dei sardi in Italia e all’estero “riconosciute” dalla Regione, senza peraltro che queste potessero accampare alcun diritto in ordine alle scelte da essa effettuate una volta stabiliti i criteri, ma solo cercare d’interloquire politicamente per influire sia sulla formazione di quelli sia sulla distribuzione delle somme che esulavano da quei parametri. Per fare un esempio concreto, se un circolo riusciva a entrate nel novero di quelli ritenuti di maggiore interesse per la Regione il suo contributo poteva addirittura raddoppiare, se poi diveniva anche sede di Federazione esso lievitava ulteriormente, ecc. (eventuali contributi per ristrutturazioni delle sedi costituivano, poi, un indispensabile valore aggiunto). A ciò andavano aggiunti i cosiddetti progetti regionali che, andando a favore dell’uno o dell’altro, facevano la differenza tra chi poteva trarre più o meno vantaggi dall’intervento della Regione. In questo modo l’istituzione, garantito un minimo esistenziale a tutti i circoli, spostava la sua discrezionalità su un buon quarto della manovra finanziaria. Il sistema, in un clima di rapporti corretti tra associazionismo e Regione e di onestà intellettuale e politica generale, diveniva meritocratico giacché i circoli più attivi e propositivi ne traevano vantaggio, viceversa in mano alle clientele politiche e ai giri distorti dell’associazionismo, diventava solo fonte di arbitrarie promozioni e antipatiche esclusioni.
Per avere un’idea della spendita della Regione all’epoca del maggiore interventismo regionale – che raggiunse il picco agli inizi degli anni Novanta, allorché il capitolo dell’emigrazione arrivò a prevedere entrate e uscite fino a nove miliardi di lire – si può prendere in considerazione una delle analisi più organiche sulla materia elaborata dallo stesso ufficio emigrazione, quella del 1995. Da essa si evince che lo stanziamento complessivo sul Fondo sociale, per l’emigrazione, era di Lit. 6.330.910.818, di cui il 66,70% andava alle organizzazioni degli emigrati, il 16,80% ai soggiorni dei nuclei familiari presso due residenze turistiche sarde (attività che, tuttavia, si esaurì in quell’anno e le relative somme furono indirizzate soprattutto verso le associazioni), il 14,28% per il periodico “Il Messaggero Sardo” e il 2,22% per il funzionamento della Consulta. Queste cifre, in genere, rispecchiano la spesa storica per il comparto fino all’esaurimento del secolo, una spesa che, negli anni Ottanta si era tenuta abbastanza alta, intorno ai cinque miliardi annui.
IL GRADUALE INTRECCIARSI DELL’ASSOCIAZIONISMO CON LA BUROCRAZIA E LA POLITICA REGIONALE
Inizialmente il rapporto con la galassia dei sardi emigrati all’estero, anche sotto il profilo della dialettica politica, come si è visto, era dominato dai temi della Sardegna e del futuro dei sardi, soprattutto nel senso che si dava un valore, per il futuro per l’isola, ai piani di vita e alle prospettive dei corregionali che l’avevano abbandonata. Era l’epoca dei politici illuminati, come Paolo Dettori o i primi socialisti, Francesconi e Rais, che avevano iscritto ai primi punti della loro agenda il problema dell’emigrazione; o di un Mario Melis che concepiva una Sardegna allargata e cercava di comportarsi come il presidente di tutti i sardi, inclusi coloro che non vi risiedevano più.
Col tempo la tensione politica nell’isola si abbassò e con essa anche la passione per i temi dell’emigrazione sarda che si restrinsero sempre di più ai diretti interessati e agli addetti ai lavori. Così si attuò una graduale convergenza tra visioni burocratiche e visioni politiche, giungendo a quella che il sociologo tedesco della conoscenza, Karl Mannheim, definisce l’“amministrativizzazione” del problema. L’evolversi della Regione in senso sempre più burocratico fu causato, infatti, sia dalla spinta concentrica dell’apparato regionale – che pressava quanto più possibile per formalizzare atti e procedimenti – e della classe politica – che tendeva sempre di più a fare leggi di dettaglio accompagnate da regolamenti minuziosi – sia dalla pressione degli organismi di controllo e della magistratura, che, nelle loro pronunce, costringevano l’amministrazione attiva ad adottare comportamenti sempre più garantisti. Il concorso di questi tre elementi è riuscito nel tempo a stravolgere, un po’ in tutti i campi, le norme più semplici e ispirate al buon senso che si era data la Regione negli anni Sessanta. Non a caso queste ultime avevano dimostrato, nel tempo, di possedere una maggiore capacità di resistenza alle esigenze di un mondo in trasformazione.
Negli anni successivi, andando in qualche modo contro gli interessi del mondo organizzato dell’emigrazione, furono create norme che, col pretesto di razionalizzare e di istituzionalizzare, ottennero l’unico risultato d’imbavagliare l’azione della Regione e incepparne sempre di più il meccanismo. Il culmine fu raggiunto, con la legge n. 7 del 1991. Questa, in realtà, conteneva (e contiene, essendo tuttora in vigore) alcune disposizioni obiettivamente lungimiranti e opportune, particolarmente nella cosiddetta parte programmatoria, che è quella in tutte le leggi di solito ricca di buoni propositi e concessioni. Per certi versi questo corpo normativo si poneva, addirittura, come una sorta di legge quadro sull’emigrazione per tutta la Regione, giacché gli interventi spaziavano dai servizi sociali ai rientri, dall’imprenditoria all’edilizia, all’industria e l’artigianato, al punto che intersecava in più parti la competenza di diversi assessorati (sanità, affari generali, trasporti, ecc.) e addirittura degli enti locali. Tuttavia, quando si passò a stabilire gli strumenti operativi (che a prima vista potevano apparire opportuni perché sembravano eliminare ogni discrezionalità politica) si finì per predisporre un meccanismo burocratico che, in nome di un garantismo in questo settore abbastanza ingiustificato, creò problemi infiniti al funzionamento dell’associazionismo in emigrazione per oltre un ventennio. Come se ciò non bastasse, il legislatore si adoperò a rendere ancora più macchinoso (e perfino contraddittorio) il sistema di erogazione delle provvidenze accompagnandolo da un regolamento di attuazione, varato nel medesimo anno (e dallo stesso organo, il Consiglio regionale) che sembrava studiato quasi esclusivamente per dare adito ai conflitti e alle interpretazioni più contrastanti (talvolta anche in palese contrasto con i principi ispiratori della legge cui si rifaceva). Lo spirito che alitava nella parte più strettamente dedicata all’amministrazione dei circoli, era ispirato a convinzioni di palese sfiducia nei confronti di quel particolare tipo di utenti (continue richieste di autorizzazioni preventive, svariate tipologie di percentuali di concessioni di contributi a seconda delle diverse iniziative, eccesso di dettagli sulle attività consentite e di altre no, infinite disposizioni su spese ammissibile e altre non, ecc.). In questo modo si favorì indirettamente non solo la nascita di una burocrazia all’interno delle organizzazioni per fronteggiare gli adempimenti – che comportò ancora di più la chiusura in se stesso del mondo dell’emigrazione, giacché questo spesso doveva combattere sul doppio fronte della Regione e della Federazione che sovrastava ciascun circolo – ma anche la cristallizzazione delle loro classi dirigenti, giacché per contrastare gli adempimenti regionali occorreva un apparato di circoli molto collaudato che si poteva creare solo nel tempo. Accadde che ciascun circolo fu in qualche modo autorizzato a porsi, nei confronti dei sardi gravanti nel proprio ambito territoriale di competenza, come una sorta di Regione per tutta la sorta di piccoli benefici che potevano derivare dal rapporto con l’istituzione in Sardegna. Lo slalom amministrativo per ottenere il “riconoscimento” del circolo (che ricalcava lo schema analogo previsto dal codice civile per le società e si poteva ottenere solo dopo previo parere delle Federazioni nazionali dei circoli sardi, pareri che spesso confliggevano con quelli della Regione) e le minuziose caratteristiche materiali e giuridiche richieste per l’ammissibilità dei locali che dovevano funzionare da sede (col fine apparente di farne ancora di più luoghi degni di rappresentare la terra d’origine), attuato da funzionari con propensioni tutt’altro che semplificatrici e spesso atterriti dal timore di sbagliare, fece sì che a quei riconoscimenti e a certe provvidenze potesse accedere solo chi poteva avvalersi di fili diretti con l’apparato dell’assessorato competente oppure con le associazioni di tutela dei sardi o le federazioni dei circoli o i circoli stessi che gestivano o mediavano in quei collegamenti. Al di fuori di questo circuito era quasi impossibile ottenere qualcosa dalla Regione. Le poche volte che l’amministrazione regionale provò a guardare oltre lo steccato dei circoli sardi, provocò solo una levata di scudi da parte delle organizzazioni degli emigrati che si sentivano “defraudate” perché si sarebbero toccate somme che la Regione, dal loro punto di vista, metteva a esclusiva disposizione. Il risultato finale è stato, però, che la miscela di burocrazia e di politica ha finito per asfissiare le associazioni.
Le novità legislative nel settore dell’emigrazione erano giunte in un momento (anni preparatori all’avvento della “Seconda Repubblica”) in cui la politica aveva deciso di non intervenire più in modo totalmente discrezionale sui settori che ricadevano sotto il controllo pubblico, ma solo in modo parziale. Il grosso dell’intervento pubblico avrebbe dovuto procedere su binari ben precisi, incanalato dalla burocrazia (nel frattempo s’istituiva la figura del “dirigente” e, anche in questo senso, vedremo come la legge del 1991 sull’emigrazione fosse avanzata), mentre solo quote parziali di esso erano affidate alla totale discrezionalità politica. Il sistema sembrava così migliorato e la “politica” pareva finalmente riconsegnata alla parte ideativa e programmatica. Tuttavia, come dimostrò l’avvio di Tangentopoli e le successive vicende giudiziarie che non hanno cessato di susseguirsi, le quote di discrezionalità che sembravano attribuite ai politici divennero una sorta di portafogli privato che quelli gestivano a loro esclusivo vantaggio. Quindi, mentre un tempo la discrezionalità politica ubbidiva a criteri di decenza, dagli anni Ottanta in poi questa divenne quasi esclusivamente una riserva di caccia per una classe politica sempre più spregiudicata – e quella regionale, si è visto, più delle altre –, che ha fatto del peculato e dell’abuso di potere il modo normale di gestire la cosa pubblica. A queste alterne vicende non si sottrasse neanche il settore dell’emigrazione sarda.
La legge sull’emigrazione e, ancora di più, il regolamento di attuazione emanato rapidamente nello stesso anno (segno di un disegno preordinato d’imbavagliamento di tutto il sistema) finirono, dunque, per regolare gli aspetti più minuti della vita delle associazioni e degli organismi rappresentativi. Stabilendo una pletora di norme di dettaglio – oltre a quelle già citate, non finiremmo di citarne anche altre, dalle spese ammissibili per l’affitto alle caratteristiche strutturali e legali che doveva possedere la sede, dalla distinzione tra interventi straordinari e ordinari per la sua manutenzione a quelli una tantum per le ristrutturazioni (fonte particolarmente questa d’infinite confusioni e non minori arbitri), dalla disciplina delle utenze telefoniche a quelle energetiche e informatiche, dall’attività di segreteria alla natura delle prestazioni occasionali, dalla tipologia e dalla percentuale di rimborsi e permessi di partecipazione a convegni, trasferte, viaggi in Sardegna e fuori, al controllo dei requisiti di cittadinanza e di “sardità” per l’accesso alle provvidenze regionali, ecc. –, come si è detto, l’amministrazione regionale si riempì d’impiegati che esaminavano scartoffie mentre, sull’altro fronte, si favoriva il formarsi di una nuova burocrazia, costituita da volontari o prestatori d’opera occasionali per fronteggiare i relativi adempimenti.
Il processo con cui si è arrivati alla farragine amministrativa attuale, quindi, ha un’origine normativa per certi versi indipendente dal volere della burocrazia. Sociologicamente esso partiva dall’esigenza di una determinata classe politica – che a parole si professava attenta agli interessi del mondo organizzato dell’emigrazione sarda – di controllare il flusso delle risorse in quella direzione per tutta una serie di disegni personali e di gruppo. Ossia di una classe politica che non trovò di meglio per realizzare questi fini che appoggiarsi alla burocrazia cedendole formalmente i compiti amministrativi, ma in realtà condizionandola passo dietro passo nelle sue decisioni, soprattutto attraverso il meccanismo delle nomine e delle promozioni. In questo modo, non solo si riuscì a svuotare anche le parti più innovative della legge, ma nel contempo si mise in atto un passaparola nel mondo dell’emigrazione che, grazie alla forza dei gabinetti dell’assessore, nulla sarebbe cambiato nella gerarchia dell’assessorato rispetto al passato.
Pertanto, anche se paradossalmente l’origine dell’intreccio della Regione con il mondo dell’associazionismo in emigrazione va cercata nell’esigenza di mantenere staccata dalla gestione amministrativa di questo comparto proprio la parte politica, il dividendo che quest’ultima riuscì a ritagliarsi fu proprio quello di condizionare ancora di più l’esistenza di quella complessa e lontana galassia dei sardi nel mondo. Non a caso, con l’entrata in vigore la legge del 1991, si è assistito a un incremento dell’attivismo politico e del turismo istituzionale degli assessori competenti che è stato pari solo al livello di vuoto della proposta politica.
Tuttavia, sulle prime, trovarsi totalmente affidata alle mani della burocrazia, per l’associazionismo in emigrazione sembrò in qualche modo frustrare le conquiste ottenute, giacché da tempo esso chiedeva di essere gestito dalla Regione con strumenti “politicamente” più diretti ed efficaci. Ossia, chiedeva di fare un passo in avanti rispetto alla logica e allo strumento del Fondo Sociale – che si occupava riduttivamente solo di emigrazione, in quanto seguiva anche le politiche per i cantieri comunali, sussidi ai disoccupati, scavi archeologici e, dopo il 1991, correttamente, pure d’immigrazione. Nonostante tutto, apparve comunque alquanto elevata la richiesta, manifestata fin dai primi degli anni Ottanta, d’istituire uno specifico assessorato dell’emigrazione (che, in cuor loro, esponenti di spicco di questo mondo ingenuamente pensavano di dirigere politicamente). Accantonata quella proposta, si propose la creazione di un ente regionale, staccato dall’assessorato del lavoro, analogo a quello istituito nella Regione Friuli Venezia Giulia. La prima richiesta, di aggiungere al disegno istituzionale un assessorato all’emigrazione, apparve in realtà abbastanza velleitaria, giacché compiti limitati e consistenza finanziaria ridotta non avrebbe mai giustificato, nell’architettura politica e amministrativa regionale, l’esistenza di una tale struttura. Non migliore fortuna ebbe la richiesta dell’ente, giacché cadeva proprio in un fin de siècle in cui più vigorosa si era fatta la polemica contro gli enti regionali in genere (pletorici, imbottiti di consigli amministrazione, costituiti da un numero eccessivo di dirigenti e di personale, votati alle spese superflue, ecc.). Alla fine, a cavallo degli anni Novanta e del nuovo secolo, sfumate entrambe le prospettive, si affermò l’idea di trasferire le competenze alla Presidenza della giunta. Infatti, in considerazione che la materia era interdisciplinare (abbracciava lavoro, turismo, cultura, trasporti, edilizia, ecc.), si osservò che la sistemazione all’interno degli uffici del presidente della giunta fosse abbastanza saggia. Tuttavia, per quanto ben sponsorizzata in campagna elettorale e corrispondente alle nove idee di regione del “governatore”, l’iniziativa non ebbe seguito.
Il risultato invece fu che, con l’acqua sporca, si finì per buttare via anche il bambino. Infatti, si decise di abolire il Fondo Sociale della Regione Sardegna, che era una contabilità speciale il cui programma era predisposto e realizzato direttamente dall’assessore competente su approvazione della Giunta Regionale; inoltre esso rispondeva della gestione solo a un Collegio di Revisori presieduto da un magistrato della Corte dei Conti, a differenza del resto dell’amministrazione in cui non esistevano contabilità speciali e i cui atti dovevano passare in prima istanza davanti alla magistratura contabile. Insomma, si trattava dello strumento più snello, burocraticamente e finanziariamente, di cui potesse disporre la Regione per gestire una materia la cui sfera d’intervento coincideva con tutto l’orbe terracqueo.
Il sistema, dunque, cessò nel 2000, in concomitanza con l’abolizione di tutte le contabilità speciali della Regione (in realtà la norma era stata introdotta nel 1987, ma i diversi assessori del lavoro – e dell’agricoltura, altro assessorato cui facevano capo fondi speciali – erano riusciti a resistere e a far prorogare l’efficacia della norma con emendamenti ad hoc alle leggi finanziarie di ciascun anno). Infatti, il 2000, anche grazie all’imminente entrata dell’Euro, fu considerato dal Consiglio regionale come unadeadline, per cui gli interventi a favore dell’emigrazione furono iscritti sul bilancio ordinario, col risultato che se alle organizzazioni degli emigrati un tempo i contributi regionali affluivano sin da febbraio, col nuovo sistema non se ne vedeva traccia prima di giugno, se non addirittura, come capitò ultimamente (anche per effetto dei cosiddetti “patti di stabilità”), alla fine dell’anno. In buona sostanza si era verificata una situazione tipica all’italiana: invece di adeguare la normativa generale a quella esistente, oggettivamente più spedita ed efficace, anche per ragioni di ripicche politiche si volle ancorare quest’ultima a quella più vetusta e farraginosa. Non passò del tempo, infatti, che tale si rivelò la soluzione adottata, nonostante che, nel frattempo, come si è accennato, fosse cessato il controllo preventivo della Corte dei Conti su tutti gli atti dell’amministrazione e una sezione della Ragioneria regionale fosse stata distaccata appositamente nell’Assessorato del Lavoro, proprio perché gran parte dei suoi capitoli di bilancio derivava da contabilità speciali e si voleva andare incontro a un’utenza abituata a una maggiore celerità della spesa e delle procedure (l’altro fondo speciale dell’assessorato del lavoro, per la cronaca, era quello per la Formazione professionale e, poi, si qualificava come tale anche quello che faceva capo all’Agenzia del lavoro).
I PROCESSI DI RECIPROCO ADATTAMENTO DEL MONDO DELL’EMIGRAZIONE E DELLA REALTA’ REGIONALE SARDA.
Non è escluso che uno dei motivi che hanno inciso sull’allargamento dell’abisso tra i sardi che risiedono fuori dall’Isola e l’istituzione regionale, sia costituito dalla particolare psicologia che caratterizza chi abbandona la propria terra. Vale a dire la proiezione del risentimento dell’emigrato per la terra madre che lo avrebbe abbandonato alla propria sorte: un senso di rifiuto e di disagio esistenziale di cui si troverebbero tracce anche nel “maltrattamento” riservato dalla Regione nei confronti degli emigrati e i loro circoli. Più certa è la rilevanza di un altro elemento – che incide sul disagio che prova il sardo che vive all’estero nell’avere a che fare con gli uffici pubblici isolani –, ossia il confronto che inevitabilmente s’istituisce tra le lentezze della Regione e l’efficienza delle amministrazioni pubbliche in genere con cui hanno a che fare i sardi in tutto il mondo. Si tratta di un aspetto, quest’ultimo, su cui gli emigrati hanno fatto sempre leva e nel quale si riproduce la caratteristica sospensione esistenziale tra i due mondi interiori caratteristici dei migranti: quello della società di origine e quella di accoglienza, come proiezione più ampia di una socializzazione anticipatoria che a suo tempo agì da impulso in molti sardi per abbandonare l’isola per paesi reputati, oltretutto, anche meglio “funzionanti”. Se i toni dello scontro oggi si sono notevolmente smorzati, per il semplice fatto che i protagonisti delle furiose battaglie dei primi anni del “Fondo Sociale” o non ci sono più oppure si è abbassata in loro, per via dell’età, la vis polemica, ciò non significa che la querelle sia cessata del tutto.
In realtà l’associazionismo dei sardi in emigrazione ha sempre posseduto una notevole capacità di galleggiamento nel mare in tempesta della politica e della burocrazia regionale. E ciò è avvenuto soprattutto nella misura in cui più ampie erano le capacità di autosostentamento di ciascuna realtà associativa. Molti circoli – dell’Italia settentrionale e dell’Europa –, grazie all’attività di ristorazione, di bar o altri cespiti, hanno sempre potuto disporre, per loro fortuna, di entrate sufficienti a coprire – e, talora, sopravanzare – il fabbisogno interno. Siccome il quadro di questa galassia non è mai stato uniforme, è sempre esistita una certa differenza nel mondo dell’associazionismo in emigrazione tra chi è vissuto dipendendo totalmente dal contributo regionale e chi, invece, è riuscito ad assicurarsi una propria autonomia finanziaria. Nelle frequenti ispezioni che svolgeva l’amministrazione regionale – da quando impose di dichiarare alle associazioni tutte le fonti di entrata – emergeva, per esempio, che per molti circoli europei l’entità del contributo regionale non rappresentava neanche un quarto delle entrate. Non pochi traevano cospicue risorse dal bar interno, in cui vendevano birre e alcolici a prezzi inferiori a quelli degli altri esercizi. Altri avevano messo in piedi autentici magazzini nelle proprie sedi in cui smerciavano prodotti sardi ai propri soci. Viceversa altre avevano creato centri di bigliettazione aerea e marittima, per cui qualche cespite rimaneva all’interno dell’associazione. Anche i circoli dell’America Latina, sfruttando il minor costo di certi aspetti della loro vita, sono stati in grado di capitalizzare il contributo regionale parametrato all’euro. Ritenere, insomma, che le associazioni dei sardi, per quanto fossero rette da esponenti della classe operaia, fossero poco accorte nella gestione, non corrisponde a verità. Pur senza la presenza di uomini d’affari in senso letterale, le classi dirigenti di molte di esse si sono rivelate molto accorte, non solo nel mandare avanti quelle attività, ma anche nel rafforzare le basi materiali del loro associazionismo, imbarcandosi in operazione non semplici come la ristrutturazione e l’acquisto della sede (grazie anche a speciali contributi regionali).
Riprendendo la narrazione, a prescindere dalla floridezza delle casse e dalla solidità della propria organizzazione, la contrapposizione frontale con la Regione non è mai venuta a meno. Nonostante le leggi di riforma della materia dell’emigrazione avessero promesso una maggiore speditezza amministrativa, la Regione non ha mai smesso di marciare in direzione di una crescente burocratizzazione della materia, sia pure spesso con l’intento lodevole di aumentare la trasparenza oppure di prevenire l’uso disinvolto dei soldi pubblici.
Per un fenomeno che ho esplorato altrove, gli apparati amministrativi pubblici tendono facilmente a colludere con quelli, retti su base volontaria, e comunque privati, che gestiscono le organizzazioni con cui i primi hanno a che fare. Il più delle volte codesta collusione è agevolata dalla comunanza del linguaggio e dalla consuetudine di rapporti che finisce per uniformare i punti di vista, a prescindere dal fatto che può perfino preludere a un reciproco scambio di favori. Tutto ciò, comunque, da vita a sinergie e intese reciproche. Nel caso specifico dell’emigrazione, fin dal 1965, uno dei primi effetti della complessa macchina amministrativa che si costruiva la Regione Sardegna fu l’attivarsi di un intenso scambio di rapporti tra i funzionari (e i politici) regionali, da una parte, e i dirigenti delle organizzazioni degli emigrati, dall’altra, in tutte le parti del mondo. Formalmente ciò avveniva per ragioni di controllo sull’utilizzo dei contributi regionali (anche se poteva capitare, soprattutto nei paesi extraeuropei, che per controllare dieci milioni di lire se ne spendesse altrettanto nella relativa trasferta); qualunque sia il pretesto, i funzionari presero a frequentare i circoli di tutta Italia e d’Europa (l’abitudine di recarsi oltre Oceano – che, per un accordo tacito, era riservata alle associazioni di tutela – nell’apparato regionale, in realtà, si diffuse solo negli anni Novanta) con la missione di controllare registri, vedere fatture e bollette, riscontrare attività, ecc.
Accanto al rapporto che si creava, in terra straniera, tra esponenti dell’amministrazione e del mondo organizzato dell’emigrazione, vi era anche quello, non meno solido, che si stringeva, alla distanza, sia pure con ciascuno a casa propria, tra gli esponenti delle reciproche burocrazie, come dimostra l’intreccio in vista degli interventi previsti a favore dei singoli emigrati. Anche questa storia parte da lontano. La concessione delle borse di studio agli studenti delle scuole inferiori, per esempio – prevista dal regolamento di attuazione della legge del 1965 e che andava a favore solo di qualche migliaio di studenti sardi all’estero (si trattava di piccole cifre, dell’ordine delle cinquecentomila lire, che, da sole, non avrebbero consentito o stimolato alcuno a studiare) –, era legata a una certificazione tanto farraginosa che solo il presidente o il segretario di circolo che disponesse di una linea diretta col funzionario della Regione addetto e, se si stava all’estero, col traduttore del consolato, avrebbe potuto cavarne piede. Il semplice emigrato, che sotto il profilo giuridico ne avrebbe avuto pure diritto, se stava fuori da questi circuiti, in pratica non ne avrebbe mai potuto usufruire. Altrettanto valeva per istituti come le colonie, i sussidi per indigenza, o altri come i soggiorni famiglie e anziani, viaggi oltreoceano, ecc., che si protrassero per tutto il secolo scorso. Facendo leva su tutta questa serie di piccoli istituti (che soggettivamente diventavano grandi quando, per esempio, un anziano poteva per la prima volta tornare in Sardegna dall’Argentina, per via della difficoltà di disporre di una somma sufficiente a pagarsi lo spostamento aereo, che poteva corrispondere a un anno della propria pensione) il circolo riusciva a mettersi al centro di tutto un movimento, creandosi una propria sfera d’influenza tra le persone interessate, grazie alla quale poteva gestire tutta questa serie di provvidenze regionali. Il fenomeno rivestì aspetti spesso grotteschi che prolungarono fino alle soglie del nuovo millennio. L’autore di queste note ricorda che, quando lo stato italiano e le regioni decisero di andare in soccorso dei cittadini italiani colpiti dalla crisi Argentina del 2001 e la nostra regione chiese a un certo circolo di inviare sollecitamente le ricevute dei presunti indigenti che avevano ricevuto i contributi, la risposta fu che, trattandosi del periodo estivo (per quell’emisfero) si attendesse il rientro degli interessati in città dalle rispettive seconde case… Su questo sistema ci sarebbe poco da ridire, se non fosse stato del tutto a carico del contribuente sardo e avesse creato discriminazioni e divisioni tra gli emigrati sardi (classiche quelle tra gli “amici” del gruppo dirigente dell’associazione e, invece, i “nemici”). Quindi, come si può facilmente comprendere, incontrando o intervenendo a favore di un gruppo contro un altro, funzionari, politici regionali e dirigenti di circoli si muovevano sul filo sottile della legalità, oltre che dell’opportunità.
Il rischio di cadere nel versante opposto era costituito anche dal fatto che la Regione inviava soldi all’estero a soggetti privati senza chiedere a essi di prestare alcuna garanzia. I pochi casi, per fortuna, in cui la Regione si è trovata in imbarazzo a trattare un uso disinvolto o personalistico di fondi pubblici sono stati gestiti alla buona e con danni limitati, ma l’ipotesi di qualche truffa internazionale pendeva sempre come una spada di Damocle sugli uffici e rendeva ansiosi i funzionari e frequenti e indispensabili i controlli. Da qui l’esigenza di correre sempre a verificare tutto minuziosamente, soprattutto quando si sentiva puzza di bruciato. Va dato comunque atto al mondo organizzato dell’emigrazione che, pur avendo la possibilità teorica di gestire in modo disinvolto i contributi finanziari della Regione, si è sempre comportato con grande senso di responsabilità (a differenza della gran parte dei settori della società sarda che, pur essendo in teoria più controllati, hanno munto la Regione all’inverosimile), utilizzando in genere correttamente i fondi e restituendo quanto non gli era dovuto. In realtà, l’esiguità del contributo regionale e il controllo interno dei soci – sempre pronti a denunciare alla Regione ogni sospetto tentativo di malversazione – ha rappresentato sempre un contrappeso perché succedesse nulla di grave. Casi clamorosi di abusi e corruttela che si sono verificati in quest’ambito e sono sfociati in inchieste giudiziarie, infatti, hanno per lo più riguardato soggetti estranei al mondo dell’emigrazione che solo accidentalmente o strumentalmente avevano a che fare con esso. D’altro canto l’entità delle somme stanziate in questa materia e la loro frammentazione non è mai stata tale da attirare i gruppi che, di solito, vanno alla ricerca di vantaggi e che lo possono fare solo quando vi è grande consistenza di fondi pubblici.
In tutti i casi, le funzioni amministrative non erano le sole a giustificare la presenza di assessori e funzionari presso le associazioni degli emigrati, ma loro compito era anche accertare che il finanziamento delle attività non strettamente ricreative, segnatamente quelle culturali, corrispondesse all’impegno finanziario della Regione in questo campo. Come si è detto, i circoli nascono strutturalmente con una funzione assistenziale, che ne abbraccia subito anche una di natura ricreativa. Tuttavia, nel tempo, queste ultime sono andate gradualmente riducendosi (anche senza mai sparire del tutto) sostituite da altre di tipo più artistico-culturale (inizialmente costituite quasi esclusivamente dalla valorizzazione dei simboli e dei valori della propria terra, come canti e balli del folclore locale). La funzione culturale fu imposta con decisione dalla Regione a metà degli anni Ottanta, per giustificare in qualche modo il suo intervento in questa direzione, posto che si moltiplicavano le lamentele – giungendo anche ai piani alti della politica – sulla supposta natura equivoca di queste associazioni finanziate dalla Regione, che molti visitatori dipingevano come “bettole” frequentate prevalentemente da “inzilleris”, ossia ubbriaconi (di vino o di birra), e focosi giocatori di briscola e morra. Questa preoccupazione fu sostanzialmente condivisa dalla dirigenza delle associazioni che, nutrendo la preoccupazione legittima che in questo modo ci si sarebbe automaticamente posti fuori dai circuiti regionali, fin dagli anni Settanta si adoperò a promuovere organici programmi culturali di matrice sarda, fossero essi imperniati sulle manifestazioni folcloristiche e sulla musica popolare sarda (che attirava più pubblico) o si trattasse di conferenze o presentazioni di libri (che lasciava in genere la sala semideserta).
LE RAPPRESENTAZIONI DI RUOLO.
A prescindere dalle frequenti diaspore, è sempre invalso il principio non scritto che la “casa” dei sardi all’estero, soprattutto quando è “finanziata” dalla Regione, deve essere aperta a tutti i sardi. Che i dirigenti si attenessero a questo principio sorvegliava particolarmente l’istituzione regionale, sia pure con i limiti suesposti, giacché in agguato era sempre il particolarismo locale che faceva in modo che i singoli circoli si caratterizzassero prevalentemente per appartenenze paesane, se non addirittura familiari (non sono stati infrequenti i casi in cui nella stessa città nascesse un secondo circolo frutto di scissione con quello principale a causa di faide familiari o paesane). Tuttavia, i rappresentanti della Regione Sardegna non erano chiamati solo a esercitare opera di persuasione e di rappacificazione tra i diversi gruppi di sardi esistenti nel territorio, ma essi dovevano affermare la presenza della Regione per attenuare in qualche modo il sentimento di “esilio” che caratterizzava i sardi all’estero. Aspetto, questo non secondario giacché su di esso si fondano le ragioni del calore con cui sono accolti in genere i rappresentanti delle istituzioni sarde in visita ai circoli italiani ed esteri, anche se poi per i loro comportamenti politici e amministrativi possono essere criticati ferocemente.
Com’erano i rapporti tra la Regione e il mondo dell’emigrazione alla luce di questi contatti così stretti e frequenti? In genere essi si svolgevano su due piani. Sul piano privato, come si è accennato, erano generalmente ottimi, giacché in essi aveva occasione di manifestarsi la caratteristica solidarietà tra sardi che, soprattutto fuori dell’isola, si frequentano, non mancano di farsi reciprocamente festa quando s’incontrano e parlano continuamente della terra d’origine (perciò il funzionario della Regione, qualunque sia la sua specializzazione, deve essere in grado di dare un’informazione a 360 gradi sulle vicende dell’isola). Era il piano istituzionale o, meglio ancora, l’eventuale momento ufficiale, invece, a essere caratterizzati da una particolare rappresentazione, che si poneva sulla scia della funzione politica che si attribuiva una certa parte della dirigenza.
Come si è già osservato, quasi seguendo un copione ideale, negli incontri nei loro circoli o in Regione, i dirigenti dell’emigrazione avevano l’abitudine di aprire i loro interventi una litania di accuse nei confronti della Regione, che era incolpata principalmente di avere espulso i propri figli e di non far nulla per favorirne il rientro nell’isola. A questo primo impatto – che al massimo poteva irritare politici e funzionari che la sentivano la prima volta – poteva seguire facilmente il rimprovero di non fare abbastanza per favorire la prosperità della Sardegna, preoccupazione questa non meno acuta di altre perché toccava la sorte di famiglie, parenti e amici “rimasti” nell’isola. Poi seguivano le inevitabili querimonie sul disagio del risiedere in terra straniera, seguita dall’elencazione di tutti i problemi comuni ai migranti: difficoltà a trovare abitazioni, lavoro, far studiare i figli, ecc. Le requisitorie potevano divenire più incalzanti nel caso che ci si trovasse davanti a gruppi di dirigenti impegnati politicamente nei partiti italiani all’estero. Vale a dire, poteva capitare che, essendo questi prevalentemente schierati su posizioni politiche di sinistra, gli attacchi ai rappresentanti della Regione potessero essere particolarmente feroci, perché gli poteva essere addossata anche responsabilità più specifiche dei governi nazionali. negli anni successivi la polemica ha investito talvolta la società sarda nella sua interezza, soprattutto quando era messa in confronto con quella di accoglienza, non solo sotto il profilo della dirigenza politica. In questi casi i limiti della Sardegna erano imputati non solo alla classe politica (ovviamente ritenuta sempre la principale responsabile), ma anche all’indolenza del carattere sardo e alla struttura familistica che avrebbe remato contro la meritocrazia e le capacità individuali.
L’EVOLUZIONE CULTURALE ED ECONOMICA DELL’ASSOCIAZIONISMO.
Il mondo dell’emigrazione sarda si è sempre presentato ai policy maker isolani come tre centri concentrici: l’emigrazione italiana, che non era penalizzata dall’handicap linguistico e dall’eccessiva lontananza dalla terra madre (e che, per questo motivo, dal resto delle comunità sarde nel mondo, era percepita come “intrusa”, anche perché non era riconosciuta come tale dallo stato italiano); l’emigrazione europea, che pur essendo giuridicamente qualificabile come tale, tuttavia, aveva il vantaggio di stare all’interno dello spazio europeo e di avvalersi di quella che si definiva “cittadinanza europea” e, infine, vi era l’emigrazione extraeuropea. Naturalmente quest’ultima era quella percepita in modo più problematico e perciò, soprattutto a partire dagli anni Novanta, attirò maggiormente le attenzioni della Regione (fu il periodo in cui, soprattutto gli assessori, furono accusati di aver abbandonato l’Italia e l’Europa a favore di mete esotiche in cui potevano essere svolti soggiorni più prolungati, talvolta non privi di risvolti turistici). La realtà era che l’emigrazione italiana ed europea si era ormai immessa in un binario istituzionale ed economico, nei rapporti con la Regione, che consentiva alle rispettive macchine burocratiche di marciare tranquillamente nella propria direzione senza che i macchinisti dovessero faticare eccessivamente a mantenerle sul tracciato. Viceversa, la lontananza, la diversità di sistemi politici, sociali ed economici rendeva più peculiare e più problematica quella extraeuropea. Essa, per esempio, esigeva ancora interventi di tipo assistenziale che i sardi ospitati nei paesi col più elevato welfare del mondo non avvertivano più come un tempo. Fenomeni, come quello del rientro periodico in patria, per gli anziani argentini o brasiliani, non rappresentavano certo un problema per l’emigrazione italiana ed europea. Anzi, quando questi istituti furono abbandonati alcuno avvertì più l’assenza, anche perché si erano rivelati una fonte di favoritismo per gli amici e sodali delle classi dirigenti dei circoli e in una occasione di guadagni poco leciti per coloro che, in varia misura, li avevano gestiti.
A questo punto s’innestò una seconda fase, quando, con l’ultimo esodo verso la Germania, i flussi migratori cessarono o si ridussero e le comunità degli emigrati sardi in qualche modo si assestarono, per cui i dirigenti politici regionali incominciarono a guardare il fenomeno sotto un’altra luce e a trarre le conseguenti conclusioni.
Intanto, come i flussi si assestarono – nel senso che non solo si smise di emigrare in massa, ma chi non aveva retto all’impatto dell’esperienza migratoria in genere era già rientrato – e si incominciarono a formare le comunità di sardi – tra i quali molti si erano inseriti egregiamente nella società ospitante –, si passò a considerare l’emigrazione sarda non più come una “piaga” bensì come un’“opportunità” e una “risorsa”. Infatti, anche sullo sviluppo dell’isola, che si poneva già come metà turistica internazionale di primo piano, gli emigrati sardi che, un tempo, grazie alle rimesse – che furono consistenti fino agli inizi degli anni Ottanta, ma poi cessarono quasi del tutto – avevano fatto la loro parte, ritenevano di dover dire la loro. Fu questa la fase in cui qualcuno pensò di trasformare le associazioni dei sardi – che incominciavano a non essere più viste all’esterno come centri di assistenza o di rifugio dei migranti incapaci di inserirsi nel nuovo contesto di appartenenza (e spesso, per ragioni opposte, erano disertati dai sardi più inseriti nella comunità straniera) –, in autentiche “ambasciate della Sardegna”.
Su quest’ultimo aspetto, in quegli anni, si lavorò con una certa decisione, incrementando i fondi per le associazioni degli emigrati (che arrivavano a coprire praticamente tutte le spese essenziali) e soprattutto perfezionando gli strumenti amministrativi. Cessato gradualmente il sistema convenzionale, per le ragioni suesposte, fu perfezionato il carattere piramidale dell’organizzazione, di cui pure si è accennato. In particolare fu valorizzato il ruolo della Consulta regionale dell’emigrazione, che fu ritoccata dalle leggi successive a quella istitutiva del 1975. Essa fu prima suddivisa in commissioni o gruppi di lavoro e, poi, guidata da un Ufficio di Presidenza che, in certi momenti, costituì il gabinetto dell’assessore del lavoro per le politiche in materia di emigrazione. Stando sempre nella metafora della macchina, a questo punto bastava accendere il motore (ossia approvare il bilancio del Fondo) perché questa partisse e andasse per la sua strada senza che l’assessore altro potesse fare, apparentemente, se non raccomandare alle feste degli emigrati il gruppo folk del suo paese oppure mandare in giro a fare conferenze il compare giornalista o professore (ma in realtà poteva fare molto di più, ossia infilarsi in tutti i dettagli del programma e dare a questi una propria impronta con la scelta di uomini, iniziative e associazioni da preferire ad altre). Sulla carta la volontà politica regionale era molto chiara: creare una struttura solida efficiente, oliata dai fondi e dalla sorveglianza regionale e retta da un gruppo dirigente che ormai andava consolidandosi negli anni, fatto da quarantenni e cinquantenni eternamente collocati nelle stesse posizioni (non senza alcuni grandi vecchi, come il “Commendatore” Tullio Locci di Savona che, fin quasi ai novant’anni, fu il grande ispiratore e reggitore di questa organizzazione e l’artefice principale delle politiche regionali in materia). Con questo sistema che cosa s’intendeva fare?
Questo era il punto su cui s’incagliava la politica regionale che vedeva questo apparato muoversi senza alcun controllo in tutte le direzioni, mentre già alla fine del millennio il bilancio della Regione per la prima volta andava in rosso. L’idea dei circoli come “ambasciate della Regione” incominciò a essere analizzata un po’ più a fondo. In particolare ci s’interrogò sui possibili ritorni economici che ne potevano derivare. Non si poteva chiudere gli occhi sul fatto che tutta una serie di circoli – posto che si sospettava che una buona parte di essi esistessero solo sulla carta per ricevere contributi regionali – avessero potenziato gli strumenti di raccolta di prodotti sardi, vendendoli a prezzi convenienti a soci e amici di soci, in coincidenza col fatto, cui si è già accennato, che, nel frattempo, alcuni accorti imprenditori isolani aveva incominciato a esportare prodotti sardi in Italia e in Europa, facendo affari e interessando il più vasto mercato locale (a Bruxelles incominciò a sorgere il primo grande negozio di prodotti sardi). In questo quadro s’inserivano anche le “settimane sarde”, organizzate dai circoli per tutta la comunità locale e messe in piedi con corollario di bande e complessi musicali, oltre che con gli irrinunciabili gruppi folk, provenienti dall’isola (ma di questi ultimi alcuni se ne costituirono all’estero per disporne all’occorrenza “a chilometri zero”, giacché le casse regionali incominciavano a languire). Ci si avvide che queste iniziative, migliorate sotto il profilo organizzativo, potevano costituire un potenziale canale di diffusione del prodotto sardo. Del canale turistico si è detto, ma anche qualche piccolo investitore straniero faceva la sua comparsa in Sardegna (che nel frattempo incominciava a smantellare il tessuto dell’industria pesante del dopoguerra), scortato da qualche sardo emigrato. La Regione, invero, approcciò con molta prudenza questa fase.
Se l’aspetto economico poteva sembrare interessante, ed era sbandierato con un certo trionfalismo da parte dell’assessorato del lavoro, esso era visto con maggiore scetticismo dagli altri assessorati che incominciavano a scrutare con un po’ di curiosità questo nuovo panorama – segnatamente quelli preposti al turismo, all’agricoltura e la presidenza della giunta. Sul fronte delle organizzazioni degli emigrati, viceversa, non vi era un pieno consenso su determinate vocazioni. Alcuni ritenevano che quella imprenditoriale fosse epidermicamente estranea alla cultura prevalente dei circoli (originariamente operaista e sindacale), altri reputavano che gli interessi economici – che incominciavano a fare non certo buone prove laddove il “bar” del circolo era riuscito a trasformare questo in un autentico “locale” – avrebbero stravolto l’identità di queste associazioni alterandone i valori, segnatamente la tutela della sardità, della lingua, dei costumi e delle tradizioni sarde. Episodi emblematici, come la cosiddetta “guerra del vino”, scoppiata in Belgio a cavallo degli anni Settanta e Ottanta, che divise ferocemente in due i circoli locali (tra chi si riconosceva nel presidente della Lega e chi in quello del potente circolo di Bruxelles, entrambi importatori di vini sardi), dimostrò quanto gli interessi economici potessero nuocere alla stessa armonia dei circoli, peraltro già ampiamente compromessa da gelosie locali, vecchie diatribe risalenti ai paesi di origine della Sardegna che ci si portava appresso anche nei luoghi d’immigrazione, sospetti di ruberie di fondi regionali, classe dirigente inamovibile, ecc. Del resto gli ambienti economici e produttivi non mandavano segnali positivi in questo senso.
Se è vero che una regione come il Friuli aveva potuto ricostruire il proprio tessuto economico e divenire in breve tempo la realtà economica più interessante del paese, dopo il terremoto del 1976, anche grazie all’apporto degli emigrati friulani di tutto il mondo; e se è anche vero che altre regioni, come il Veneto (con la “gondola veneta”), il Piemonte, la Lombardia e, sia pur meno, la Sicilia e la Puglia, avevano creato teste da ponte della loro economia all’estero grazie ai propri emigrati, le cose non sembravano automaticamente applicabili alla Sardegna. Sondaggi effettuati riservatamente presso economisti e imprenditori non davano grandi speranze di successo. In primo luogo era difficilmente estensibile alla Sardegna l’esperienza di altre regioni che si trovavano già alla seconda generazione di emigrati, per cui erano potuti emergere imprenditori di grande successo (come Lee Iaccoca in Usa e Grollo in Australia). Viceversa l’emigrazione sarda di massa era iniziata nel secondo dopoguerra, per cui era difficile che da una leva di pastori, agricoltori, muratori e operai scaturisse in così breve tempo una classe d’imprenditori di alto livello. Infatti, più che qualche ristoratore, importatore, imprenditore edile e commerciante o artigiano di medie dimensioni non si vide all’orizzonte, nonostante la stampa sarda tendesse talvolta a far notizia con i supposti successi di qualche self made man.D’altro canto, gli economisti facevano osservare che, anche ipotizzando che vi fosse in giro per il mondo qualche imprenditore sardo interessato a trasferire o investire in Sardegna, questo soggetto sotto tutti i cieli si comporta in modo razionale, cioè investe dove trova convenienza e non solo per una questione sentimentale. E la Sardegna all’epoca – per via dei trasporti e della debolezza delle infrastrutture – non poteva allettare nessun imprenditore seriamente intenzionato a investire sia pure coinvolto nei circuiti migratori. In tutti i casi, con prudenza, qualcosa si volle provare.
Infatti, poiché la Sardegna attraversava una fase d’ingenuo ottimismo promozionale, cercando di essere presente in tutto il mondo con i suoi prodotti (che spesso solo immaginava di possedere o non aveva a sufficienza per poterli esportare), in qualche modo incominciò a coinvolgere anche i circoli sardi in alcune attività per capire come e se si potesse collaborare con essi. I risultati onestamente non furono all’altezza delle aspettative, anzi scatenarono polemiche da una parte e dall’altra. Da parte degli enti regionali e gli assessorati preposti alla promozione perché ritenevano che le associazioni dei sardi, in ultima analisi, non possedessero le necessarie professionalità per svolgere queste attività e, da parte dei circoli, perché accusavano la Regione di preferire, a chi gravava al loro interno, personale straniero in varie vesti, d’interprete o di accompagnatore soprattutto (la polemica conobbe punte particolarmente acute in Germania in occasione di alcune importanti manifestazioni).
L’assessorato del lavoro, che osservava con scetticismo le attività promozionali della Regione – anche perché grazie ai sensori costituiti dai circoli poteva giungere a conoscenza a posteriori dei risultati mancati –, tuttavia riteneva che qualche tentativo potesse essere fatto in questa direzione nel momento in cui si fosse avuta una maggiore disponibilità di fondi. L’occasione si presentò nel 2000, quando, per effetto dell’abolizione del Fondo sociale, l’assessorato ebbe la possibilità di mettere in gioco i residui di cassa, quasi cinque miliardi di vecchie lire. Con questi soldi, spalmati in un triennio si provò a fare ciò che, per limiti di disponibilità, non si era potuto fare prima, ossia creare una serie di centri di diffusione del prodotto sardo (agroalimentare, artigianale o edilizio) e di ricerca d’investitori nelle città più rappresentative del mondo in cui esisteva un circolo sardo (Milano, Zurigo, Parigi, Londra, Berlino, Bruxelles, New York, Toronto, Buenos Aires e Melbourne), mentre su altri centri furono svolte attività più limitate e collegate con quelle principali. A ciascuna di queste sedi fu preposto un manager affiancato da una segretaria, tutti furono dotati dei budget necessari per sistemarsi in sedi decorose e organizzare iniziative promozionali di un certo profilo nella rispettiva città. I risultati furono disastrosi e tutto finì in una bolla di sapone. A parte il solito malcostume che si diffonde ogniqualvolta si muovono soldi pubblici (scampagnate in classe business di decine di politici, funzionari e imprenditori sardi nelle tappe più lontane, che non mancarono di avere un’eco anche a livello nazionale, oppure favoritismi nelle assunzioni), i manager individuati non si rivelarono all’altezza dei compiti (e molti neanche potevano definirsi tali), ma soprattutto gli imprenditori sardi non ci misero rischio, prodotti e competenze.
Questa vicenda segnò praticamente la fine di ogni velleità imprenditoriale che avesse come oggetto il mondo dell’emigrazione. Rimanevano altri ruoli. Dopo che realisticamente si era preso atto che le analisi economiche andavano lasciate agli economisti e agli imprenditori e che le valutazioni sulla congruità delle iniziative fosse di spettanza degli enti e degli uffici regionali preposti ai settori economici (e non d’improvvisati analisti economici dentro i circoli o le associazioni di tutela), si pensò che la funzione delle aggregazioni dei sardi potesse essere più realisticamente quella di dedicarsi a svolgere non meglio precisate attività utili per la Sardegna. In qualche modo, questa, potrebbe essere definita la terza fase, quella del realismo.
IL PUNTO MORTO.
La novità è che, rispetto al passato, ci si avvide che non era necessario dettare dall’alto l’agenda, ma doveva essere ciascuno a fare la sua proposta alla Regione per cosa fare con la Regione e attraverso la Regione. Del resto vi erano tanti altri aspetti non secondari, anche per l’economia sarda, cui potevano fare riferimento le associazioni. Il tema dei trasporti e della continuità territoriale, per esempio, che tradizionalmente costituiva uno dei cavalli di battaglia delle organizzazioni dei sardi, anche per un evidente interesse diretto, apparve subito tra quelli più a portata di mano (non poche volte le comunità dei sardi furono prese a punto di riferimento dalle compagnie aeree per fissare rotte e aeroporti con destinazione Sardegna). Lo stesso impegno a diffondere e difendere la cultura, che aveva sempre fatto capolino nelle attività dei circoli – e anzi aveva costituito un punto qualificante del piano triennale della regione per l’emigrazione 1994-1996 e 1997-1999 –, poteva assumere vesti nuove che potevano contemplare un certo protagonismo delle università accanto a quello tradizionale delle espressioni artistiche tradizionali grazie alle quali si poteva uscire da un certo dilettantismo. Così pure la pratica dei gemellaggi tra i centri della Sardegna con altri in Italia e all’estero vide più di frequente svilupparsi l’iniziativa delle associazioni dei sardi. Rimanevano centrali altre funzioni, sia pure attenuate nel tempo. Per esempio, quella che fin dalle origini aveva accompagnato i sardi nel loro turismo sanitario nelle mete italiane di Bologna, Torino, Verona, ecc. e, fuori dell’Italia, soprattutto a Parigi. Per altro verso non cessava l’interesse nei confronti di questi circoli come occasione di diffusione del prodotto sardo, soprattutto quello di espressione più locale e più tipica, confezionato da qualche produttore artigianale di qualche paese di provenienza, posto che ormai tutti i prodotti sardi sono presenti nei più importanti centri commerciali europei e del mondo. L’attività economica seguita da molti rimane comunque quella turistica, nella quale ci si è cimentati anche con progetti e organizzazioni più ambiziose oppure in singole iniziative rivolte alla zona in cui affonda le proprie radici il più numeroso capitale umano del circolo. In un certo qual modo si può dire che, oggi, ciascuna associazione dei sardi è alla ricerca di una propria ragione sociale autonoma, al di là degli indirizzi e dalle indicazioni generali che in qualche modo possono giungere dalla Regione.
Dopo il 2000, segnatamente col fallimento dell’emigrazione in una prospettiva economica, l’interesse della Regione nei confronti di questo comparto, comunque, è scemato sempre di più. A fronte dei tentativi, svolti per lo più dalle strutture, rivolti a qualificare meglio l’emigrazione sarda anche in termini d’investimento – come gli stage giovanili, la formazione delle nuove leve, ecc. –, la Sardegna si va sempre più disinteressando a questo problema, anche perché le organizzazioni degli emigrati fanno fatica a rinnovarsi, le classi dirigenti appaiono sempre più sclerotizzate, la tipologia delle iniziative stenta a superare gli schemi tradizionali e l’ambiente del circolo risulta sempre meno frequentato e meno aggregante. Il risultato economico è che, dal 2000 al 2013, lo stanziamento regionale per la materia dell’emigrazione si è ridotto quasi di un terzo, passando dai tre/quattro milioni di euro a poco più di un milione (per risalire in modo sospetto ai precedenti valori in vista della campagna elettorale del 2014). Il fatto preoccupante è che la riduzione della fetta della torta invece che indurre a riflettere i responsabili del mondo organizzato dell’associazionismo sardo sulle ragioni di codesta caduta di tensione, li ha portati a pestarsi ancora di più a pestarsi i piedi in una piastrella che si riduce sempre più di dimensioni.
Evitare di porsi la questione giovanile è stato ferale per la perdita di terreno della Regione in questo campo. In pratica tutti i tentativi di affermare una classe giovanile dirigente è stato affossato e boicottato dai dirigenti dell’emigrazione che non vedevano di buon occhio successori che s’immettessero in un percorso formativo differente da quello a suo tempo seguito da loro, ossia tutto imperniato sulla vita e la realtà del circolo o della federazione. E, così, giovani abituati ad altre modalità organizzative e a nuove forme di comunicazione, dopo un primo incuriosito affacciarsi in questo mondo, hanno finito, salvo qualche caso di cooptazione, per abbandonarlo definitivamente. Per conseguenza sono svanite le speranze di un ricambio e, nel tempo, probabilmente si defileranno anche interlocutori nella classe politica sarda – posto che questa diviene sempre più giovane .
Come sempre, nelle politiche, accanto a quelle che agiscono nel tempo o costruendo o erodendo – nel caso specifico un peso ha sicuramente avuto anche il fattore della distanza –, esistono anche cause scatenanti. La principale di queste è stata, come si è accennato, la pretesa del mondo dell’emigrazione di entrare nell’agone politico regionale.
Il mondo dell’associazionismo sardo è stato sempre altamente politicizzato, è inutile negarlo. Il fatto stesso che esso costituisca una élite, sottende questa vocazione. Abbiamo visto come la polemica con la Regione e la sua classe politica sia stata sempre molto elevata e, se si può dire che oggi questa caratterizzi ormai tutti i sardi, quella degli sardi fuori, ieri, in qualche modo si poneva come ante marcia. L’adesione politica comunque era una necessità per contare anche nei paesi di origine. Studi specifici in materia di migrazioni hanno mostrato come gli stranieri si diano sempre da fare politicamente nel paese di accoglienza per star meglio, contare di più, acquisire diritti, ecc. E a ciò non fanno eccezione i sardi. Tuttavia la preferenza si distribuiva lungo l’arco dei partiti tradizionali. La maturazione di una coscienza politica specifica, che sfociò nella creazione del partito intervenne, invece, intorno alla fine degli anni Ottanta e originò dall’incontro di due esigenze: la prima di far risuonare in Sardegna, senza la mediazione dei partiti tradizionali, la voce dei sardi che stavano all’estero e, la seconda, per supplire la presunta insufficienza e insensibilità degli uomini politici preposti a gestire l’aspetto dell’emigrazione, in modo da rappresentarne più adeguatamente le istanze presso la società, la politica e l’amministrazione. I risultati non furono all’altezza delle aspettative, anche perché i dirigenti dell’emigrazione avevano fondato il calcolo della loro forza, oltre che su una presunta leadership politica, sulla supposta coincidenza della consistenza sarda in Italia e all’estero col consenso elettorale, cosa che di fatto non avvenne. In realtà, se una base elettorale ci poteva essere, questa abbracciava tutt’al più gli iscritti alle associazioni che, essendo intorno ai 10.000 in tutto il mondo (e non sempre attivi frequentanti) e, in minima parte in possesso della cittadinanza italiana, non erano sufficienti a rappresentare i circa 65.000 cittadini italiani di origine sarda all’estero con diritto di voto in Italia e in gran parte indifferenti a questo. Viceversa l’appello ai parenti e agli amici rimasti nell’isola non ebbe alcun seguito, e ne avrebbe potuto avere, giacché nessuno si gioca i complessi rapporti che lo legano al politico locale per una persona, fosse pure un parente, che sta lontano dalle dinamiche interne alla propria realtà geografica.
Comunque stessero le cose, come punto di arrivo di questa maturazione, agli inizi degli anni Novanta, un gruppo tra i più politicizzati tra i dirigenti degli emigrati – in un asse che andava prevalentemente da Stoccarda a Milano passando per la Svizzera e con altri apporti qua e là, ma senza una precisa casacca partitica addosso –, incominciò a fare discorsi d’ingresso nell’assemblea regionale.
Il movimento prese piede poco prima della fine del millennio e si presentò alle elezioni con un proprio partito, l’UPS (Unione del Popolo Sardo), uscendone pesantemente sconfitto senza eleggere alcun consigliere. La stessa cosa si ripeté nell’elezione successiva che portò alla presidenza Soru. Forse esso conteneva troppi equivoci. Per esempio, pur partendo dal presupposto che non si sarebbe dovuto schierare con nessun partito in Sardegna, finì per gravitare nell’orbita del centro destra, partendo così già spaccato nel mondo dell’emigrazione europea. Infatti, a prescindere dalla storia politica personale dei suoi maggiori esponenti – di cui nessuno proveniva da schieramenti politici conservatori e meno che mai ne sposava le tesi – quasi tutto il mondo dell’emigrazione italiana ed europea si collocava sulla sinistra dello scacchiere politico. Alla resa dei conti, prima delle elezioni, ciò comportò che molti dirigenti dell’emigrazione – anche quelli che avevano guardato con una certa simpatia il sorgere di questo movimento – non se la sentirono di abiurare del tutto al loro credo politico. Il risultato fu la catastrofe elettorale. Salvo Domenico Scala, Vice presidente vicario della Consulta e presidente della Federazione svizzera, che ad Alghero aveva ottenuto un notevole successo personale, ma non era stato comunque eletto al Consiglio regionale, da tutte le altre parti i candidati dell’UPS presero un pugno di voti. In questo modo si rivelò palese l’ininfluenza politica del mondo dell’emigrazione e, poiché si sa che in politica è decisivo il peso elettorale e al mondo dell’emigrazione, sia pure a occhio, gliene era sempre stato attribuito uno discreto (sulla base degli stessi calcoli che aveva indotto i promotori a fondare un partito), una volta che si scoprì che questo in realtà non ne aveva alcuno, caddero le cautele politiche e la materia rimase un campo libero, dove tutt’al più l’assessore preposto poteva fare un po’ di turismo tra i corregionali all’estero senza neanche più preoccuparsi di quello che diceva.
Sempre tra i fattori politici secondari che hanno condizionato negativamente la materia dell’emigrazione va annoverato che, in campo regionale – segnatamente all’interno delle associazioni di tutela –, avessero trovato spazio alcuni di politici “in pensione” oppure in fase discendente. Espulsi dal gioco politico ufficiale, tuttavia, costoro conservavano ancora con il mondo politico che conta relazioni, influenza, consuetudini, affinità (molti erano stati deputati, altri consiglieri o assessori regionali, ecc.) e in ogni casi rimanevano “grandi elettori”. In queste vesti fecero danni ancora maggiori, sotto il profilo delle scelte politiche, favorendo le svolte più conservatrici, più vicine alla loro vecchia cultura, e affossando le aspirazioni dei settori più giovani (un vecchio politico in pensione, con un importante curriculum alle spalle, ricordo che soleva ripetere che i “veri emigrati” erano suoi coetanei e che a essi bisognava guardare e non ai giovani!).
Tuttavia, il dato più grave è stato il fallimento della traduzione in attività politica diretta dell’esperienza accumulata nei decenni dai dirigenti del mondo dell’emigrazione (quasi tutti peraltro legati a partiti politici ufficiali). A seguito di esso, molti dirigenti hanno tirato i remi in barca, altri si sono disamorati del problema e altri ancora si sono chiusi nella loro associazione cessando di dare ulteriori apporti alla crescita del movimento. La stesse sperimentazioni di femminilizzazione dell’organizzazione si sono rivelate abbastanza tardive, e all’interno di esse non tutte hanno costituito novità in senso anagrafico. Il risultato è stato una perdita d’interesse per il problema. O forse la chiusura di un’esperienza e l’esaurimento di un fenomeno, come sempre è capitato nel corso della storia?






























































































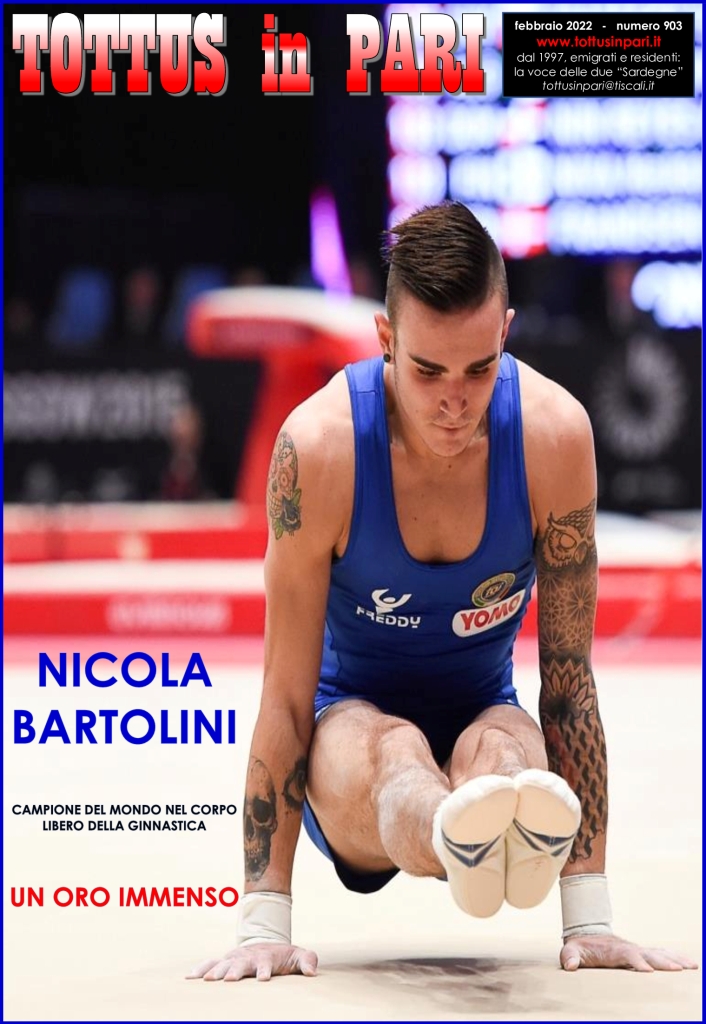











Saluto Aldo, carissimo amico
Lunghissimo, manca di sintesi
Grande Aldo Aledda!!!
Uno studio dettagliato e puntuale. E’ un’utile analisi per progettare il futuro dell’associazionismo sardo sviluppandolo su basi più moderne
Verissimo Maurizio….chi più di Aldo avrebbe fatto una analisi più dettagliata…….ma ho l’impressione che chi crede nell’associazionismo siamo sempre i soliti e in pochi….i giovani scappano con questo modo di fare e decisionale dei nostri politici…e i circoli chiudono!!!