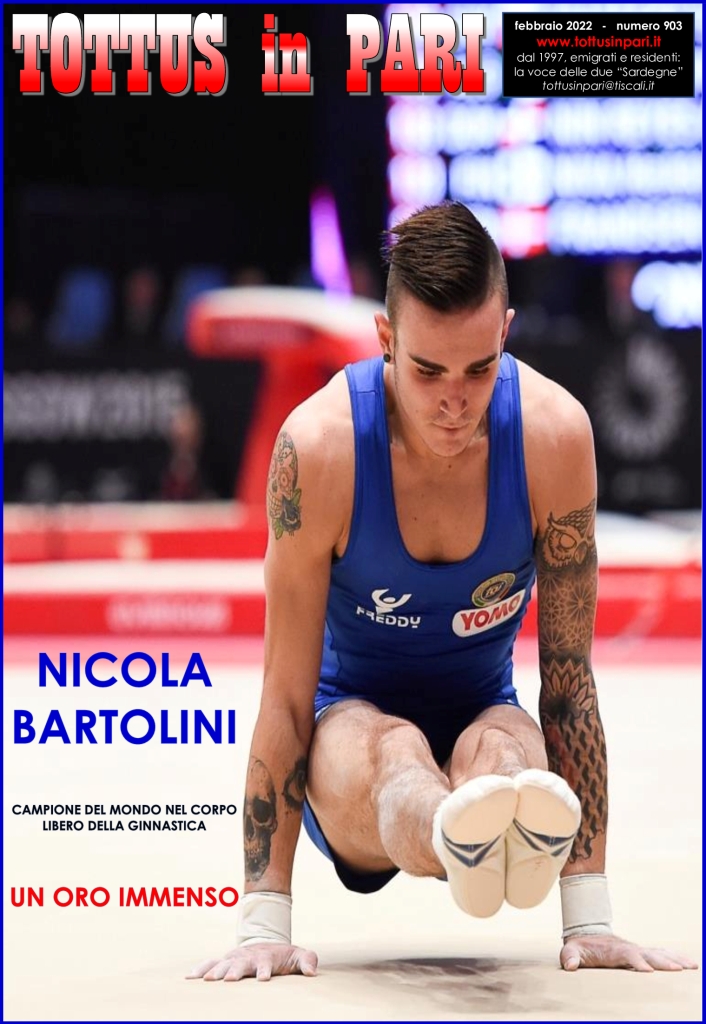Nel 1837 i debiti di Honorè de Balzac erano arrivati alla ragguardevole somma di 200mila franchi. La Sardegna fu il tentativo estremo di raddrizzare una situazione disperata. Forse la Sardegna non era l’Eldorado, ma c’era abbastanza argento da potersi arricchire. Nel sud dell’isola nei dintorni di Iglesias, la vena di galena argentifera correva qualche centinaia di metri sottoterra e in certi punti addirittura affiorava. Argento c’era anche nel nord, nella Nurra, in un giacimento sfruttato sin dall’antichità e ora abbandonato. L’attività di secoli aveva lasciato montagne di scorie che, eccitavano le più disparate fantasie. Honorè de Balzac giunse ad Alghero pensando che fosse un ottimo affare sfruttare le scorie d’argento sardo e la prima tappa fu la Nurra, dove però scoprì che la concessione per lo sfruttamento delle scorie era stata già ceduta. A cavallo puntò a Cagliari. Nel capoluogo gli venne data una notizia che era una mazzata: solo il 10% delle scorie a cui aveva puntato era piombo, e solo il 10% di quel piombo era argento. Per ricavare qualche chilo d’argento da quelle montagne di scorie ci sarebbe voluta una fortuna. L’avventura sarda di Balzac si concluse in un’ultima settimana a Cagliari, in attesa che la fine del cattivo tempo consentisse alla sua nave di partire per il Continente, senza soldi, amareggiato per il fallimento. Non a tutti, però, andava come a Balzac. A partire dal 1848 si ebbe un vero e proprio boom degli investimenti minerari. Il volume della produzione crebbe di quasi 10 volte e crebbe da 616 a 9171 il numero degli operai occupati. Ad investire erano genovesi e piemontesi e, tra gli stranieri, belgi, francesi e inglesi. I sardi erano presenti nella prima fase, la ricerca, ma poi la concessione ottenuta veniva ceduta a società di fuori. Con i prezzi del piombo e dello zinco in forte crescita, c’erano soldi da fare con le miniere sarde. Ma ai sardi toccava stare a guardare o al più, prendersi le briciole. Non a Giovanni Antonio Sanna, però, che di stare a guardare non aveva nessuna intenzione. Sanna cercò di riattivare la miniera di Montevecchio, ma quando si sarebbe trattato, come da copione, di lasciare le cose alle "mani forti" (investitori francesi e genovesi), lui mantenne il controllo della società. I metodi erano discutibili come la gestione. I suoi migliori anni (Sanna morì nel 1875) comunque furono dedicati, con successo, a risanare e ristrutturare la Montevecchio. La vicenda di Sanna mostrava tutte le difficoltà e le strozzature a cui era sottoposta l’intrapresa mineraria in Sardegna. Un percorso ad eliminazione lungo il quale quanto più si procedeva nella catena della produzione – lavorazione – commercializzazione tanto maggiori erano i problemi e più impegnativi gli investimenti. Dalla ricerca alla concessione, dall’estrazione del minerale al suo trasporto, e poi la cernita, il lavaggio, la fusione e non ultimi i problemi legati alla vendita del minerale e alle forti oscillazioni dei prezzi di minerali e metalli sul mercato internazionale: una corsa ad ostacoli in cui ad ogni ostacolo cadeva qualcuno, laddove cadere significava vendere a un concorrente più grosso. Gli ultimi decenni del secolo assistono ad una concentrazione dell’attività nelle mani di alcune grandi società: la "Monteponi" di un gruppo di azionisti torinesi che per lustri arriverà a produrre più di un quarto del piombo italiano; la belga "Vielle Montagne" che privilegiava la produzione dello zinco; le francesi "Malfidano" e "Gennamari-Ingurtosu" e l’inglese "Gonnesa Minino Company". Così l’attività mineraria conobbe in Sardegna un vero e proprio boom, senza che i sardi vi avessero parte. Non vi erano fonderie in Sardegna e il minerale, dopo essere stato sottoposto a cernitura e lavaggio, lasciava l’isola. Mancavano strade e ferrovie tra i pozzi e il mare. Dalle miniere al punto d’imbarco, costava quanto dalla Sardegna all’Inghilterra. Il trasporto del minerale comportava costi e investimenti aggiuntivi, tutt’altro che esigui. La "Malfidano" costruì la strada che portava da Buggerru alla miniera. Così la "Monteponi" fece le ferrovia Portovesme – Gonnesa. E poi la Sciria – San Gavino. A giustificare la scarsa presenza di sardi nell’industria mineraria che prosperava in casa loro, le difficoltà locali di manodopera, unite alle intemperie. Alla fine del 1800 il valore della produzione mineraria crebbe inesorabilmente. Un fiume di denaro che si trasformava in profitti e dividendi ma che alimentava anche un notevole flusso di salari e stipendi. Circa tre quarti degli operai erano sardi, mentre l’altro quarto era formato da piemontesi, toscani e bergamaschi. In gran parte minatori esperti quelli continentali, mentre ai sardi erano riservati ruoli di manovalanza: carriolanti, addetti alla cernita e al lavaggio dei minerali, legnaioli. C’era una precisa gerarchia, di funzioni e di salari, nella miniera. Nel gradino più basso i ragazzi addetti alla cernita del minerale. Poi venivano i manovali dei piazzali con un salario sino a 3 volte superiore a quello dei ragazzi. Infine, con un salario doppio di quello dei manovali, i minatori e i falegnami che armavano le gallerie. Queste due ultime categorie erano formate da continentali. La spiegazione più diffusa recitava che i sardi non erano abbastanza forti e robusti per le mansioni più dure, quelle legate allo scavo, né avevano la perizia necessaria. Fu forse in omaggio alla intelligenza e alla perfettibilità dei sardi che nel 1872 venne aperta ad Iglesias una scuola mineraria. Le miniere di piombo e di zinco dell’Iglesiente pescavano su un bacino di reclutamento corrispondente in pratica a tutta l’isola. Furono varie decine di migliaia i pastori e i contadini sardi che nell’ultimo trentennio del secolo accorsero nel bacino minerario dell’Iglesiente, ma furono ancora di più coloro al cui orizzonte esistenziale la miniera si presentò anche solo come una possibilità e una speranza. Anche la miniera, comunque, così come in certi momenti sembrava potesse assorbire chiunque, in altri respingeva coloro che considerava di troppo. Una oscillazione governata da un meccanismo tanto astratto e distante – il fixing del prezzo del piombo e dello zinco sul mercato di Londra – quando crudelmente presente alla vita dei minatori. Si aprivano nuovi pozzi, se ne riattivavano altri ormai abbandonati. I prezzi scendevano? I pozzi venivano chiusi. Dopo il boom dei prezzi del piombo e dello zinco erano venuti i tempi duri. Una ripresa impetuosa ci fu dopo il 1903. Nei punti bassi del ciclo, le grandi società, diversamente dalle piccole, non chiudevano. La loro risposta alla caduta del prezzo dei minerali era solitamente il taglio dei costi di produzione, la riorganizzazione del lavoro. In termini più espliciti: diminuzione dei salari, allungamento degli orari di lavoro ma anche l’instaurazione del sistema delle "cantine" per cui gli operai erano costretti a spendere i loro salari in spacci gestiti dalle società stesse. Se l’andamento del ciclo imponeva tagli di salari e licenziamenti affinché le miniere potessero rimanere aperte, ciò avveniva per leggi di mercato, che notoriamente non erano leggi compassionevoli. La situazione era dura con salari bassi e orario lungo? Provassero gli operai a tornare nei paesi per vedere se potevano trovare qualcosa di meglio.
Massimiliano Perlato
MINIERE E MINATORI DEL LIMBURGO
STORIA DI SARDI
Le miniere hanno da sempre rappresentato oltre che un’importante fonte di ricchezza, un’insaziabile voglia di conquista coloniale. Questo fin dall’antichità: interi territori, a cominciare dalla Sardegna sono stati oggetto di conquista da parte di altri popoli a causa delle miniere. Popoli, quali i fenici e i punici, arrivarono in Sardegna seguendo il percorso dell’ossidiana, del piombo e dell’argento. Le miniere, il lavoro di estrazione, erano alla base di fiorenti commerci. Nell’antichità, una buona parte del transito delle navi greche, fenicie, puniche e romane nelle acque del Mediterraneo, era legato al trasporto dei metalli, dei minerali da lavorare e dei materiali lapidei delle cave. Il controllo delle miniere, da sempre, ha perciò portato ad una serie interminabile di guerre e di sanguinose e dolorose conquiste: l’arrivo dei romani in Spagna è legato alla necessità di controllare i giacimenti minerari della penisola iberica ricchi di ferro. Con il sorgere delle signorie feudali, dopo i secoli bui delle invasioni barbariche, la ricerca e l’estrazione di minerali è stata via via potenziata. Intorno all’anno mille, grazie al risvegliarsi in tutta Europa delle attività commerciali in molte città e a un nuovo sistema di scambi, le navi delle compagnie espressione delle potenti città marinare, ripresero il predominio sulle antiche rotte commerciali del Mediterraneo e dell’Atlantico europeo. I metalli e le produzioni legate al ciclo minerario, ripresero prepotentemente il loro posto nei circuiti mercantili. In tal modo, minerali quali il carbon fossile, tornarono ad essere estratti e commerciati in tutta Europa. E il carbon fossile piano piano si è trovato nei secoli a legarsi ad alcuni luoghi, a cominciare dal Limburgo. La storia ricorda come nel 1100, proprio in questa regione, fossero stati i monaci del monastero di Klosterrath ad avviarne per primi un’estrazione e un commercio razionale e redditizio. L’ordinamento feudale con l’obbligo di prestazione di lavoro verso il Signore, caratterizzò la coltivazione mineraria per tutto il Medioevo, insieme alla nascita delle gilde di mestiere, che fissavano non solo le regole commerciali ma le modalità di estrazione. Tutto ciò fino al 1700. Ma, accanto a questo ordinamento, si andarono sviluppando, specialmente in Germania, nuove forme contrattuali. Il lavoro delle miniere è soprattutto un lavoro legato al numero di braccia che si hanno a disposizione: anche se lontani dai periodi bui del Medioevo, neanche le innovazioni tecniche del 1500, sono mai riusciti ad affievolire la fame di uomini delle miniere. Nel 1500, nel bacino minerario tirolese di Falkenstein, in 36 miniere si impiegavano oltre 6850 persone. Nelle miniere di carbone dell’Inghilterra del 1600, un solo padrone poteva avere necessità anche di mille persone per il lavoro di una sola miniera. Il lavoro del minatore è sempre stato un lavoro sporco e faticoso: nella miniera tirolese di Schawz, nel 1600, si aveva necessità di oltre 600 persone per trasportare l’acqua dalle gallerie alla superficie. Seicento persone che per tutta la giornata erano incaricate di riempire dei grossi tini e a forza di braccia, andarli a svuotare nei canali esterni intorno allo stabilimento. Che fosse un lavoro faticoso era chiaro, come era chiaro che con le miniere la gente cercava di non averci nulla a che fare. Erano lavori dove ci si arrivava o per disperazione, per mancanza di un’altra occupazione, o per scontare una pena. Ma era un’attività necessaria che non poteva fare a meno di braccia insieme ad una forte necessità di ricambio. Per un lungo periodo, le potenti signorie medioevali e rinascimentali della Germania, dell’Inghilterra e della Scozia, per una parte della loro vita, rendevano obbligatorio al loro popolo basso, alla plebe, il lavoro di estrazione. Questo non voleva dire che il lavoro non fosse organizzato tramite corporazioni di mestiere in molti casi potenti. Le gilde dei minatori raggruppavano le società di estrazione, che avevano il compito di stipulare con i padroni delle terre, le potenti signorie locali e le case regnanti, complicatissimi contratti collettivi. Queste prime forme di contrattazione portarono a importanti innovazioni negli ordinamenti e a modelli di contratto rivoluzionari per quei tempi, di cui ancora oggi si sentono gli effetti: il cottimo, per esempio è fra questi. Non deve, perciò, sembrare tanto strano che a quel punto, verso i centri minerari, si muovessero intere comunità. Comunità che formavano dei veri e propri centri urbani, insieme a tutti i servizi necessari per lunghi periodi: una città mineraria, nonostante la sua vita legata alla permanenza in vita del filone, poteva rimanere attiva per decenni. Si aveva bisogno allora di creare dei simulacri di città urbanizzate e organizzate, dove fosse possibile la permanenza. Le ricerche di archeologia industriale in Europa, hanno portato alla luce molti di questi centri, altri si stanno realizzando un po’ in tutto il mondo. Ma, soprattutto, molte città minerarie sono visitabili: le più celebri, che ancora oggi eccitano la fantasia di schiere di visitatori, sono le Ghost town americane, celebrate in film e racconti, spesso dell’orrore, nate nella maggior parte vicina ad una miniera di qualche importante filone di metalli preziosi. Sono luoghi classici di emigrazione e centri cosmopoliti per antonomasia. Quello del carbone è sempre stato considerato un tipo di estrazione sporca e pericolosa: i filoni dovevano essere scavati per grandi estensioni su terreni fragili dove neanche l’armatura delle gallerie basta a renderli stabili. Le gallerie potevano crollare ad ogni momento, diventando prigioni mortali a causa delle continue fughe di gas. La sua estrazione non era solo un problema di braccia ma di coraggio, di polvere e strane malattie, che alla fine impedivano agli uomini che ne erano colpiti di respirare. Le braccia e il desiderio di cambiare la propria vita erano tutto quanto occorreva per sconfiggere il desiderio di fuga da quell’inferno. Certo, i minatori non sono sempre stati come vengono ricordati nel 1900, o nel 1800. In passato, nel Medioevo, era un mestiere duro, ma certamente speciale, al limite del magico: un minatore, allo stesso tempo doveva essere in grado di individuare i terreni utili per gli scavi, capire dalle piante che nascevano in superficie cosa si poteva trovare in profondità, doveva saper armare le gallerie, e infine organizzare le laverie e le fonderie. I minatori, partivano con lo stesso spirito dei cercatori della corsa all’oro americana ed essere in grado sia di individuare il buon filone saggiando il terreno con scavi di prova che di avventurarsi in territori quasi sconosciuti. I loro strumenti erano qualche arnese e un animale su cui trasportare le provviste per lunghi periodi e legavano i loro sogni a quei buchi nella terra, umidi e caldi che portavano sempre più giù. Ma, nel bene e nel male, erano padroni del loro destino. Diverso il discorso nel 1900. Il lavoro nelle miniere aveva perduto buon parte della sua autonomia: al minatore gli si chiedeva di eseguire poche operazioni nel più breve tempo. A nessuno interessa più dare qualche nozione su cosa sono le miniere o in che ambiente si svolge il loro lav
oro. Ecco il racconto di un vecchio minatore sardo: "Pensavo che sotto fosse molto più brutto: la galleria era grande e spaziosa, c’erano quattro binari e tutta illuminata. Sembrava di essere di notte in una grande città. La cosa peggiore era il caldo. In molti punti si arrivava a 40 gradi di temperatura", ricordano diversi. "L’ascensore scendeva giù fino alla galleria. Poi, su un trenino elettrico o a nafta, si facevano fra i 10 e gli 11 chilometri. Da lì si prendeva un altro ascensore, poi si risaliva e da qui, per arrivare alla taglia. Ogni sei metri c’era una lampada. Il capo ci chiamava per numero e ci indicava la lampada dove dovevamo lavorare". Non tutto era tutto rose e fiori e la curiosità iniziale spesso si tramutava in tragedia, in incidenti. L’inesperienza poteva essere pericolosa: "A farmi male mi è capitato quasi subito, forse il primo,o forse il secondo giorno: il nastro trasportatore di ferro fu messo in moto senza accendere la lampada rossa che costituiva il preavviso, proprio mentre stavo passando". Un lavoro faticoso, che si capisce come tale dai racconti puntuali che tutti i vecchi minatori sardi fanno ancora oggi: "Per estrarre il carbone non si usava solo il martello pneumatico, ma anche una sega meccanica che poteva infilarsi fino ad un metro e mezzo nel carbone. La sega era trainata da un nastro trasportatore formato da due catene, il panzer. In altre taglie, dove il carbone era meno duro, si utilizzava lo strap, una specie di aratro con due denti che, sempre montato sul panzer continuava ad andare avanti e indietro estraendo carbone per circa 40 centimetri di profondità". I gruppi di minatori che si formavano erano una babele di lingue e di nazioni. Le miniere del Belgio, sono state per molto tempo un crocevia obbligato di tutti i popoli poveri del Vecchio Continente. Ecco la testimonianza di un sardo: "La nostra squadra era costituita da un polacco, un tedesco e tre manovali italiani. Lavoravamo sempre a 380 metri di profondità in un punto molto pericoloso, situato sotto una grande falda sotterranea. Nel lavoro di scavo della galleria dovevamo fare molta attenzione". Ricordano molti sardi del circolo: "Il primo impatto era a la va o la spacca". Si è trattato, cioè, di un incontro fortemente traumatico per quasi tutti. Non erano assolutamente consapevoli di quello che li aspettava. Venivano, bisogna sottolinearlo, da un altro mondo. Erano abituati all’aria aperta, al vento alla pioggia, alle stagioni. Tutte cose che nelle miniere scompare: "Si entrava al buio e si usciva al buio. Questo per sei giorni alla settimana. Non era il lavoro ad esser duro, ma l’ambiente. Bisognava adattarsi. Bisognava farci l’abitudine. Mi ricordo che la mancanza di sole diventava forte soprattutto dopo i primi giorni. Poi ti salvava il fatto di avere amici, di non sentirsi da soli. Io venivo da Anela, non posso dire che mi dava fastidio il freddo, mi dava fastidio il buio, la luce delle lampade. Ma nelle miniere del Limburgo si stava meglio. Noi minatori eravamo molto più rispettati di quanto non lo fossero a Charleroi. Lì le condizioni erano fra le più brutte di tutto il Belgio ". Le facce nere dei minatori che risalivano dal fondo, la gabbia dell’ascensore dove erano stipati uno addosso all’altro, la velocità con cui questo scendeva a centinaia di metri di profondità, il buio e i cunicoli, il rumore dei martelli pneumatici e dei nastri trasportatori e infine la polvere di carbone che sembrava togliere il respiro. Nessuno aveva detto loro cosa fosse il lavoro che dovevano svolgere e quali le condizioni, l’ambiente. Questo, nonostante il fatto che l’informazione sulle condi zioni di lavoro fosse prevista dall’art. 5, dell’accordo italobelga. Ci vollero non poche lotte e l’impegno di molte organizzazioni italiane, a cominciare dalle Acli, per concordare con le autorità che, almeno per i primi giorni fossero impiegati esclusivamente per far conoscere agli emigrati la miniera. In seguito è stato introdotto l’uso di fare un piccolo corso pratico di due, tre giorni, finito il quale si cominciava ad andare in galleria con l’iniziale qualifica di manovale e per la durata di almeno sei mesi. Dopo quei primi sei mesi si passava a lavori più impegnativi.
Antonio Rubattu
UNA STORIA CHE LA SARDEGNA HA PAGATO CON 1500 VITE
MINIERE E MEMORIE
Più di 1.500 in 139 anni. Sono i morti nelle miniere della Sardegna fra il 1861 e il 2000. Incidenti sul lavoro: si chiamano morti bianche, nonostante i minatori uscissero dal ventre della terra scuri in viso e sulle tute. Neri dentro, consumati dalle polveri respirate a centinaia di metri di profondità. Storie e nomi – quando ci sono – raccolti nel libro "Sardegna, minatori e miniere". Patrocinato dal Parco Geominerario e frutto di una ricerca portata avanti dai volontari dell’associazione "Minatori Memoria", il volume vuole essere una testimonianza del tributo pagato da tante generazioni di sardi. Un passaggio dalla Storia alle storie che non vuole essere fine a se stesso. L’associazione, nata nel 2005 dalla volontà di ex minatori, figli e nipoti di minatori, ha proposto alla Regione e al Parco Geominerario il progetto per uno Spazio della memoria: 1.514 alberi da piantare – uno per ogni minatore deceduto – con la supervisione dell’Ente Foreste e il contributo delle famiglie dei lavoratori e delle scuole. Nuova vita, quindi, per non dimenticare. L’opera è frutto di uno studio iniziato nel 2004 e lungo due anni. Il comitato ha raccolto una rilevante quantità di informazioni: nomi, data di nascita, età al momento della morte, comune di provenienza, data, luogo e causa dell’incidente, comune di appartenenza della miniera. A pagare il prezzo più alto all’economia mineraria in termini di vite umane sono stati i territori più ricchi di giacimenti produttivi: 480 i lavoratori deceduti nei 46 siti dell’Iglesiente, 412 quelli morti nelle miniere del Guspinese, poco più di 400 deceduti nei pozzi di carbone nel territorio di Carbonia. La maggior parte dei minatori, quasi il 40%, ha perso la vita a causa delle frane all’interno delle gallerie, mentre più del 20% per cadute accidentali in pozzi o fornelli scarsamente segnalati. Gli incidenti meccanici ai mezzi utilizzati (vagoni, gabbie, convogli, tremogge, gru, cavi d’acciaio) hanno causato il decesso nel 17% dei casi, mentre le esplosioni (dovute al cattivo funzionamento delle mine o ai temibili gas grisou) hanno inciso per il 13%. Senza dimenticare l’asfissia, il folgoramento e l’annegamento. Statistiche e numeri collegati a storie personali. Anche se le maggiori difficoltà riscontrate nel corso delle indagini hanno riguardato soprattutto l’impossibilità oggettiva di risalire all’identità della persona scomparsa. «In effetti, almeno sino ai primi anni venti del 1900, nei registri del distretto minerario», si legge nella relazione che accompagna lo studio, «si era soliti inventariare gli incidenti sul lavoro indicando solo il numero dei periti, senza soffermarsi sulle generalità delle vittime. Un costume che, più di ogni altro, indica lo s
carso peso e la minima considerazione che venivano conferiti alla vita di un minatore, ridotto alla stregua di un freddo e semplice numero». È il motivo per cui 281 minatori deceduti sui 1.514 censiti sono ancora senza nome. Fra le fonti esaminate dall’indagine figurano i racconti orali di chi ha lavorato in miniera e di chi ha vissuto a stretto contatto con gli operai: mogli, figli o nipoti. Le informazioni sono state poi incrociate e verificate con i dati presenti nei verbali e nei registri del Distretto minerario di Iglesias, nei registri parrocchiali (dove venivano registrati i defunti prima dell’istituzione dell’anagrafe), negli uffici anagrafe dei comuni e nel fondo sugli incidenti in miniera dell’Archivio Storico di Cagliari. "Minatori Memoria" è nata grazie all’iniziativa di fratel Gerardo Fabert, 73 anni, sacerdote della Congregazione dei Piccoli Fratelli del Vangelo. Prima di dedicare 23 anni della sua vita alle lotte dei contadini del nord-est del Brasile, il religioso ha lavorato per 13 anni come perforatore nella miniera di San Giovanni di Iglesias e poi, per diversi anni, a Ottana, nel complesso industriale che stava nascendo in quel periodo. Dopo l’esperienza in Brasile, il sacerdote è voluto tornare in quella che considera la sua comunità e vive adesso a Carbonia della sua pensione di lavoro.
ISTITUITO NEL 2001, DICHIARATO DALL’UNESCO PATRIMONIO DELL’UMANITA’
I GIOIELLI DEL PARCO MINERARIO
Situato al centro del bacino occidentale del Mediterraneo, il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, è stato dichiarato il primo Parco Geominerario del mondo, esempio emblematico della nuova rete mondiale di Geositi- Geoparchi istituita dall’Unesco. Esso viene così identificato come parco tematico ed inserito all’interno di un contesto territoriale particolarissimo che è quello dell’isola della Sardegna, considerata, per caratteristiche geologiche e ambientali, un piccolo ma intero continente. Il Parco comprende otto aree di interesse distribuite in tutto il territorio regionale: Monte Arci, Orani-Guzzurra- Sos Enattos, Funtana Raminosa, Argentiera-Nurra-Gallura, Sarrabus-Gerrei, Sulcis Iglesiente, Guspinese-Arburese, per una superficie totale di 3455 kmq e nel suo comprensorio ben si manifestano i segni della cultura materiale e degli insediamenti sorti intorno alle attività minerarie, che hanno generato nuove ed originali forme di paesaggio e di ambiente sociale e culturale, tali da caratterizzare vaste aree con una precisa identità di valore universale, unica e rappresentativa dell’intera regione geoculturale mediterranea. La costruzione del Parco Geominerario è il percorso di affermazione di idee, contributi, elaborazioni individuali e volontà collettive progressivamente affermatasi nel corso degli ultimi due decenni del Novecento nel territorio del Sulcis Iglesiente Guspinese. Il 1997 è l’anno della svolta nella storia del Parco: la stesura del dossier da presentare alla Commissione UNESCO raggiunge l’obiettivo di un pieno riconoscimento del valore internazionale delle specificità storiche, geologiche, minerarie e ambientali del Parco. A Parigi la Conferenza Generale UNESCO individua nell’Isola il primo parco della rete Geositi Geoparchi. Il 30 Settembre 1998, le massime autorità dell’UNESCO, del Governo italiano e le istituzioni locali sottoscrivono la Carta di Cagliari, documento guida delle linee di indirizzo operativo del Parco. Tra difficoltà e imponenti mobilitazioni popolari, il 16 Ottobre 2001 si arriva alla firma del decreto istitutivo del Parco da parte del Governo italiano: il Parco, diventa soggetto istituzionalmente riconosciuto. Nel 2007 la conferma del riconoscimento UNESCO e l’appartenenza alla rete Europea dei Geoparchi. Il Parco nasce dalla volontà di creare un circuito in grado di recuperare, tutelare e valorizzare le proprie risorse storicoculturali, legate alla comune tradizione mineraria in un contesto che sovrappone alla salvaguardia dei siti archeo-industriali e minerari dismessi, le straordinarie risorse naturalistiche e paesaggistiche del territorio. Le peculiarità multi tematiche consentono quindi di offrire il "prodotto culturale Parco Geominerario" nel suo insieme, collegando le aree costiere dell’Isola con le zone interne in un piano omogeneo di sviluppo sostenibile che rappresenta un’occasione per il riscatto economico e sociale delle sue aree, garantendo al contempo, un’offerta molteplice di temi di interesse la cui unitarietà è data dai valori di carattere universale presenti nei territori del Parco. La Sardegna è una delle regioni geologicamente più complete dell’area europea e mediterranea. La sua storia geologica fa parte quindi di quella dell’Europa occidentale e si differenzia fortemente da quella della Penisola italiana. Essa presenta una delle linee di costa più antiche d’Europa: alte falesie, lidi sabbiosi e complessi dunari rilevanti. Il Parco Geominerario della Sardegna offre al suo interno molte delle manifestazioni carsiche uniche al mondo che vedono grande concentrazione di grotte, alcune delle quali monumentali, attraversate da fiumi sotterranei. Nell’entroterra, oltre che sulle coste, si evidenziano le modificazioni del paesaggio derivanti dall’attività estrattiva praticata sin dai tempi più remoti. L’Isola ha vissuto le sue vicende geologiche più importanti durante l’Era Paleozoica. Gran parte dei sedimenti che costituiscono l’Isola offrono all’osservatore attento documenti della sua storia paleo zoologica e paleobotanica che, racchiusi nelle rocce, permettono di ricostruire le faune e le flore succedutesi nelle epoche geologiche. Gli Archeociatidi sono certamente tra i fossili più caratteristici di tutta la Paleontologia sarda e le associazioni più importanti sono state rinvenute nelle rocce cambriche dell’iglesiente. I Trilobiti sono tra i fossili più importanti di tutto il Paleozoico, perché sulla base della loro classificazione si è potuto mettere ordine nella stratigrafia delle formazioni Cambriane (Sardegna sud-occidentale). Il percorso storico della Sardegna e del suo Parco è legato a doppio filo alle miniere. Nuraghi e bronzetti, la metallurgia del piombo indicano lo sfruttamento delle miniere da parte dei Punici, Romani, Pisani e Piemontesi. La storia dei suoi codici minerari e l’intero Distretto minerario sardo sono ancora oggi la prova evidente di uno stretto rapporto tra l’uomo e lo sfruttamento delle enormi risorse geologiche che la Sardegna e il Parco tuttora racchiudono. I paesi e i villaggi minerari, la ricca e ultracentenaria storia delle società minerarie rappresentano, insieme alle lotte dei minatori e alla chiusura delle miniera, un continuum, storico che viene ad oggi garantito dal Parco Geominerario e che proietta i suoi territori verso un futuro di riconversione delle sue risorse e recupero della memoria. In un territorio ricco di ambienti e paesaggi decisamente diversificati si sviluppano le peculiari caratteristiche di una vegetazione e una fauna che, grazie al clima e alla sua privilegiata posizione geografica, costituiscono elementi di straordinario pregio ed interesse. Tra le formazioni vegetali indicatrici del climax vegetale del Parco si trovano il leccio e diverse tipologie di quercia, così come numerose ed interessantissime altre specie, in particolare quelle endemiche, alcune delle quali sono relitti di antiche flore ormai estinte. Anche dal punto di vista faunistico la posizione
geografica garantisce una ricchezza di specie ed endemismi, tra cui il, Cervo sardo e il Geotritone, mostrando inequivocabilmente come il senso e l’importanza di una continuità "ecologica" territoriale continuino ad essere tra le priorità delle comunità del Parco. Il Parco offre l’opportunità di accostarsi a un patrimonio culturale molteplice che costituisce l’occasione per rivivere appieno il fascino di un tempo, per maturare un’esperienza che risulterà indimenticabile per ogni visitatore. Le diverse culture del lavoro che si sono succedute nel tempo vengono rievocate nelle numerose feste e sagre come il Matrimonio Maritano, antico rito del matrimonio contadino, la sfilata dei costumi tradizionali di Sant’Efisio e i riti della Settimana Santa. Le aree del Parco trovano così continuità nel mantenimento delle tradizioni comuni. L’artigianato sardo con gli arazzi, tappeti, le ceramiche e le stoffe. La cucina tradizionale che ha resistito alla diffusione di pietanze sintetiche ed è fatta di piatti genuini e rustici come il pane carasau, sottile come un’ostia, is malloredus, sa fregula, is culurgiones, il pecorino, la bottarga, il miele amaro; anche la produzione vitivinicola è di alto livello con il Torbato di Alghero, il Carignano del Sulcis, il Cannonau di Ierzu, il Vermentino di Gallura. L’attrattiva di un’offerta molteplice di temi di interesse culturale connessa alle diverse aree del Parco garantisce così unitarietà ai territori che il Parco intende preservare e restituire in tutta la sua ricchezza e complessità.
DALL’ALTRA PARTE DEL MONDO: UN FILO CONDUTTORE CON LA SARDEGNA DEL SOTTOSUOLO
ESPERIENZA TRA I MINATORI DI CERRO RICO IN BOLIVIA
Scintilla, Sergio, Manlio, tutti voi che mi avete lasciato in eredità , la solidarietà e la forza di un animo da minatrice. Non ricordo tutti i nomi, ma posso ricordare i vostri volti, spesso scavati dal lavoro duro del sottosuolo, ma con gli occhi vivi e scintillanti di chi mai ha perso la speranza e la voglia di lottare per quello in cui crede. Sapevate che sarebbe arrivato il momento che sarei giunta a Potosi’, ve ne avevo parlato in quella giornata splendida che mi avete dedicato dopo la mia laurea. Dopo aver discusso la tesi che parlava di voi e del nostro territorio. Sapevate che come figlia di ex minatore, nipote di ex minatore e di una ex cernitrice, figlia del Sulcis Iglesiente, le miniere del Cerro Rico di Potosi’ erano una tappa che speravo di raggiungere con trepidazione. Ci sono arrivata. Sono entrata per l’ingresso di quella galleria, che sembra uguale in tutto il mondo. Un tunnel, dove termina la luce e inizia il regno delle tenebre. Il tempo e’ un altro, lo spazio e’ un altro, l’uomo non e’ più padrone, il lavoro lo rende schiavo, la povertà lo imprigiona sotto terra. Il buio, l’umidità, la polvere, la fatica, questo lo conoscete bene voi che siete fratelli di questi uomini che ho incontrato nella profondità della terra boliviana. Voi, come me, avete sentito il cuore stringersi in una morsa di rabbia e impotenza, vedendo le condizioni in cui alcuni dei 15.000 lavoratori delle miniere di Potosi’ continuano a scavare le viscere del Cerro Rico. In Sardegna sono rimaste le foto e i pezzi da museo delle antiche pratiche minerarie, che tuttora suscitano sgomento per la mancanza di sicurezza, di protezione. Ma Potosi’ non e’ un museo. E’ storia vivente, che fa male. Da quando gli spagnoli si impossessarono delle miniere nel 1545 tanto minerale è stato rubato alla Bolivia, ma ancora di più vite innocenti di indios e africani, schiavi, anime sotterrate nella polvere e nello sforzo disumano di un lavoro senza tregua e regole. La guida mi parlava di cose che conoscevo bene: perforazione, detonazione, mi ricordavo di San Giovanni Miniera, di tutte quelle realtà così vicine a me da farmi sentire orgogliosa di aver vissuto tra miniere e rivolte dei pozzi, tra occupazioni e marce per lo sviluppo. Perforazione, per 80 centimetri due ore di lavoro. Martello, scalpello, forza e pazienza. Il tempo non si conosce quando il sole e’ ormai un ricordo, lontano, fuori nell’altra dimensione del mondo, quella della luce. Qui si lavora anche 16 ore al giorno, qui il vagone carico di minerale si trascina a mano, senza guanti. La cultura dei minatori indigeni si e’ mantenuta viva nonostante l’imposizione della religione cattolica. Così il regno del sottosuolo e’ il regno del Tio. Come il regno della luce ha il suo Dio, il mondo dei minatori ha la sua divinità, alla quale si chiede permesso e consenso prima di rubargli una parte del suo tesoro, l’argento, lo stagno, lo zinco della miniera. Prima di iniziare il lavoro i lavoratori si riuniscono intorno al Tio, parlano di qualsiasi cosa, alla presenza della divinità, come condividendo con lui prima di penetrare nelle gallerie. Offrono alcool puro sul petto della statua, perché possa infonder loro la purezza spirituale, sugli occhi perché possa guidarli ad individuare il minerale, sulla braccia perché dia forza nel lavoro e sulle gambe perché non manchi sicurezza nel cammino. Due foglie della pianta di coca, (così lontana dalla droga di cui sentiamo parlare) due come gli opposti, notte e giorno, bene e male. Due foglie sulla testa del Tio, sicurezza e concentrazione nel lavoro. Chi lavora con l’esplosivo riconosce in queste due parole due elementi sacri: Sicurezza e Concentrazione. Avrei voluto abbracciare quel ragazzo che riposava e che non sapeva dirmi da quante ore stava lavorando. Avrei voluto aiutarlo a terminare le sue 15 tonnellate giornaliere, avrei voluto stringergli la mano, dirgli che ero figlia di minatore. Il suo sguardo fiero era lo sguardo di mio nonno. E per la prima volta dopo tanto tempo ho sentito la sua mancanza, avrei voluto raccontargli tutto quello che ho visto. Lui e i suoi polmoni sapevano bene quale maledizioni custodisce la miniera. Lui e le sue mani forti sapevano rappresentare l’orgoglio di un lavoro tra i più duri sulla faccia della terra, o meglio del profondo della terra. Mi sono sentita piccola, come sempre, davanti ad una tragedia, ma grande grazie agli insegnamenti che mi avete lasciato voi, minatori del Sulcis, mio nonno, mio padre che alla mia età stava nelle miniere del Raibl a spaccare ghiaccio il giorno del suo compleanno. E fuori della miniera di Potosi’ due donne chine sulle pietre polverose, separavano il minerale buono dal cattivo. Cernitrici. Un altro pezzo della mia famiglia, mia nonna. Che con i suoi 86 anni ancora in piedi e attiva può raccontare la sua esperienza alla laveria Lamarmora di Nebida, quella che adesso sembra un anfiteatro sul mare, ma che e’ il simbolo di un’attività mineraria ricca e decaduta. Nel freddo dell’altipiano centrale ho osservato quelle donne, con le mani bianche, perdere ore della loro vita sotto il sole a 4200 metri d’altezza, perderle per sempre dietro un lavoro pesante e senza fine. Sotto l’ombra del Cerro Rico, che come una piramide rappresenta la storia della Bolivia, questa donna sfruttata e maltrattata, la loro madrina resistente sotto la coltre della schiavitù. Preferisco non parlare dei bambini che ho visto uscire dalla miniera, con il naso sporco e gli occhi vuoti di stanchezza. Cosa potrei dire io, che le miniere le ho sentite raccontare, le ho vissute percorrendole quasi per gioco e anche per passione, ma senza perdere la voglia di giocare dietro la voglia di argento, stagno o zinco. Non posso dire niente. Ma non posso chiudere gli occhi. Dent
ro le viscere della terra pulsa un orgoglio che e’ il motore dell’uomo, il suo lavoro ruba alla terra, ma con rispetto, con riconoscenza, talvolta imprecando per la fatica per la brutalità delle condizioni. Qui dentro l’uomo tende la mano all’altro uomo, la sua vita e’ vita collettiva, non e’ solo, e’ figlio di Pacha Mama, (la Madre Terra) fratello di ogni altro uomo, la sua ombra non esiste e’ ombra universale, abbraccio dell’oscurità della galleria. Il dolore, il sudore, la risata, la paura si condivide, si divide, si distribuisce, si fa più leggera, perché i tuoi occhi sono miei occhi, le mie orecchie percepiscono il tuo urlo che mi avvisa di scappare poco prima della detonazione. ABRUXIA. Un pensiero trafitto e dolorante a quanti non hanno sentito quell’urlo e durante gli anni di una storia nera sono rimasti sotterrati in un cimitero senza aria e senza sole, né luna. Un pensiero a chi ha lasciato le sue ossa e il suo ultimo sospiro in un braccio di questa madre miniera, così simile in tutto il mondo, così affamata e severa. Un pensiero meno gravido di sofferenza, un pensiero più leggero a tutti coloro che hanno lavorato tanti anni sotto terra, uscendo ogni giorno da quella galleria e ringraziando Dio per il regalo del cielo blu; un pensiero per voi amici miei, che mi accompagnate sempre nel viaggio, senza lasciarmi sola un solo istante. Voi che con il vostro grande cuore, con il vostro sorriso grande e pieno di significato mi avete consegnato tutta la vostra semplicità, vitalità, energia. Mi sento minatrice, non smetterò mai di dirlo, sono orgogliosa quanto voi, sono orgogliosa di voi.
Elisa Cappai