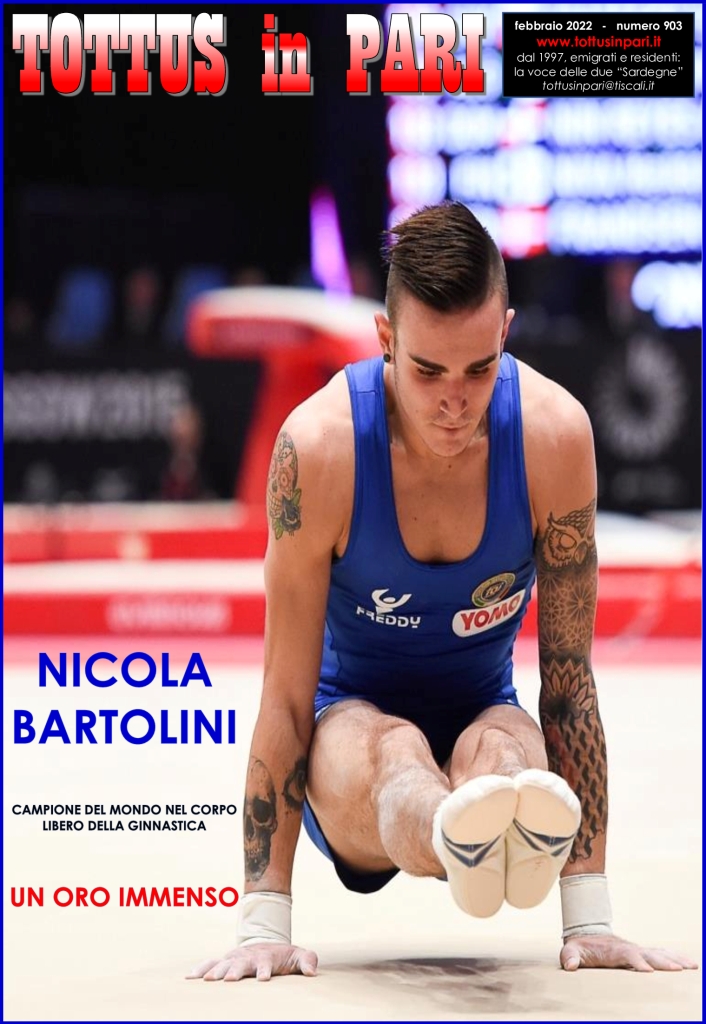di Gianpaolo Visetti *
«Mio padre aveva ragione. Io ho sbagliato. Voleva liberarmi dalla prigione dell’industria, che sfratta usando la scienza, per restituirmi alla libertà della natura, che trattiene rigenerando la bellezza. Lui aveva visto che il mondo rurale, assieme alla terra, avrebbe perso il potere. Io non ho capito che, nel deserto, comanda il vuoto. La mia vita è la risposta alla tragedia ignorata della Sardegna e dell´Italia». Gavino Ledda, a 70 anni, rinnega "Padre padrone". Nella casa di Siligo, dove è tornato, sta riscrivendo il suo capolavoro. Dopo 35 anni vuole denunciare la violenza opposta a quella che, costringendolo a diventare un bambino pastore, recise il suo destino di scolaro: i genitori ridotti ormai a «spingere nel mercato dello studio», cacciando i figli da campagne e paesi. «Eravamo padri e padroni – dice – ora siamo sterili e servi. Meglio essere proprietà di un padre che di una banca, o di un podestà». È la sintesi del dramma che, nell’arco di una generazione, erige oggi l’isola a specchio di un Paese orfano. «I campi – dice a Baddhevrùstana – sono la metafora dell’enigma chiamato libertà. Dobbiamo ammettere l´incapacità di chiarirlo: e riconoscere che, per non mettere a tutti una valigia in mano, si deve avere una cultura propria da trasmettere».Da sette giorni, per guardare il divorzio italiano dall’agricoltura, dalla natura e dai suoi borghi, vago in Sardegna assieme a pastori, casari, contadini e genti delle Barbagie. In nessun altro luogo, sospeso tra coste brulicanti e montagne inselvatichite, la rinuncia della nazione a se stessa è tanto impressionante. L´ultima crisi del mondo, come l´alluvione annunciata a Capoterra, travolge chi è rimasto a produrre cibo, o a mettere ordine nei campi, sui pascoli e tra i boschi. Migliaia di sopravvissuti sono scossi da uno stupore: prendere atto di essere stati abbandonati.«La mancanza di un grande progetto civile nazionale – dice lo storico Manlio Brigaglia – riproduce la catastrofe antropologica del dopoguerra. L’ufficio sostituisce lo stabilimento. Lo spaesamento sociale, culla di una rivolta possibile, è però peggiore: perché politica e sindacato, inconsapevoli, hanno rinunciato ad affrontarlo». Gli effetti di tale distrazione, motore degli abbandoni, sono una serie di primati devastanti. In Sardegna c’è il luogo più avvelenato d’Italia, Portovesme, e il più intatto, Budelli. Quartu Sant’Elena ha la più alta concentrazione demografica, 602 abitanti per chilometro, e Gerrei la più bassa, 14. L’età media dei contadini è di 62 anni. Non c’è più di un figlio per donna. Attorno al Gennargentu le femmine hanno in media 52 anni. Su 377 Comuni, 164 sono prossimi all’estinzione. Olbia, in trent’anni, passerà invece da 3 mila a 100 mila residenti. Villasimius, in agosto, schizza già da 20 a 110 mila. In estate le persone che vivono sull’isola oscillano da 1,6 a 20 milioni. Arzachena è il Comune più ricco d’Italia, Desulo il più povero. Cagliari, su 9 mila ettari, ospita 190 mila persone. Orgosolo, su 22 mila ettari, 3 mila. L’86% dei sardi vive ormai a non più di 30 chilometri dalla costa, solo il 5% nei villaggi più antichi dell’interno. In due città, Cagliari e Sassari, si è spostato un terzo di tutti gli abitanti. Sull’isola ci sono 800 mila abitazioni: 8 mila vuote solo nel capoluogo, mentre nei paesi il 47% sono abbandonate. In dieci anni la superficie coltivata si è dimezzata, i pascoli incolti sono quintuplicati, mentre 90 milioni di metri cubi di cemento hanno coperto i 1600 chilometri di litorale. Settemila aziende agricole sono all’asta,180 mila contadini pagano i mutui solo grazie ai contributi Ue e sono schiacciati da 800 milioni di euro di debiti.Belano in compenso quasi 4 milioni di ovini: 300 mila quintali di pecorino romano prodotto per il sempre più precario mercato Usa. Il cortocircuito, economico e sociale, tocca qui il suo apice storico. Esprime però, nella sospensione di un’isola a rischio liquidazione, il carattere nuovo dell’Italia all’asta. E rivela infine il suo esito: 300 mila poveri, un sardo ogni cinque. «La costa produce cemento – dice l’antropologo Bachisio Bandinu – l’interno formaggio. Le due materie prime sarde, mare e latte, sono nelle mani di un pugno di persone, in maggioranza del continente, o straniere. Alla gente non resta nulla. La Sardegna, come il resto della nazione, si rende conto dell’errore. Ha trasformato la natura in industria, turistica o alimentare, ignorando la lezione dei petrolchimici. Il guaio è che, nonostante il fallimento di quel modello, lo Stato continua ad alimentare la catastrofe: con la complicità dell’Europa».Il tentativo di reagire, da alcuni mesi, lacera l’opinione pubblica. La Sardegna è l’unica regione italiana ad aver approvato un piano paesaggistico coerente con il codice dei beni culturali.La sola ad aver vietato nuove costruzioni a meno di due chilometri dalle rive. La rivolta, scatenata dal partito di costruttori e speculatori, ha avuto un finale inatteso: il referendum contro la conservazione dell’ambiente, i primi di ottobre, si è schiantato sul 20% di votanti. «Non è purtroppo – dice il leader degli ambientalisti, Stefano Deliperi – un addio al cemento. Certifica però vergogna e nostalgia: l’appello di genti che, ovunque, si sentono sempre più impotenti. Inutili».Il paesaggio in sé, del resto, è un certificato di incertezza. Spiagge, campagne, colline e monti non trasmettono un carattere, né rivelano un’attitudine. Loculi di calcestruzzo, ammassati, si alternano a scollegate distese selvagge. Per metà si coltiva, per metà si abbandona. In parte si tutela, in parte si sfrutta. Una scissione consumata, ma non compiuta. «È un territorio indeciso – dice l’archeologo Giovanni Lilliu – che esprime un’insicurezza, la sfiducia in se stesso. Penso alla mia isola e vedo l’Italia: luoghi dal destino imprevedibile, che nessuno ama più. Ho 94 anni: se l’improvvisazione non si arresta, temo di essere in tempo per assistere a un collasso». I sintomi sono evidenti. La piana tra Uta e Decimoputzu è invasa da migliaia di metri quadrati di serre pericolanti. Scheletri di plastica, o di vetro, con le piante secche ancora all’interno. Centinaia di fallimenti, innescati da contributi illegali. Vani scioperi della fame. Un banchetto, per il credito. «Per ventimila euro – dice Riccardo Piras, di Altragricoltura – battono all’asta terreni che valgono 2 milioni. Un infermiere in pensione, per conto di un’immobiliare milanese – ne ha comprati 32. Prima ci hanno fatto investire, poi fallire. Il verde agricolo perduto, in un anno, diventa edificabile. Politici, banchieri e costruttori, il potere sardo e italiano, si stanno spartendo le campagne». Esemplare, pochi giorni fa, il ciclone tropicale a Capoterra. Fino al 1990 qui si coltivavano carciofi e pomodori. Tre ore di diluvio hanno sommerso una distesa di case brutte, abusive e senza piano. Sugli alvei di fiumi e canali hanno costruito asili, scuole, negozi, cimiteri, strade. «La soglia della sostenibilità – dice Fanny Cao, presidente regionale di Italia Nostra – è stata superata. Confondere lo sviluppo con il cemento non distribuisce ricchezza. Brucia risorse: e semina cadaveri».Una lista terribile di orrori, per l’isola più bella e completa del Mediterraneo. Il Campidano, granaio di Roma, è a
bbandonato ad un’orticoltura intensiva avvelenata e fallimentare. Portovesme soffoca in una nube tossica. A Porto Torres le scorie restano sepolte nei terreni. Liquami e concimi chimici devastano gli stagni di Arborea. Nel Sulcis, liberato dalle miniere, i fiori sono ancora impregnati di metalli. Pula, la costa del Sud, Villasimius, la costa Rei, Olbia e la Gallura, la Nurra attorno ad Alghero, sono sepolte di hotel e seconde case. Uno squallore: design seriale camuffato da architettura d’autore. Altri milioni di metri cubi di edifici giacciono nei progetti: le onde, invisibili, si gonfiano oltre i centri commerciali. Si salvano solo le valli delle Barbagie. «Perché ormai sono vuote come agnelle arrostite – dice Bachisio Porru, portavoce dei piccoli Comuni – e i politici non sanno nemmeno dove siano. In 60 paesi l’età media è di 48 anni, il ricambio generazionale impossibile. È il destino che sta travolgendo tutto il Meridione, gli Appennini, l’arco alpino. Lo Stato ha tolto l’occupazione, quindi i servizi: quattro italiani su cinque costretti a lasciare le loro immense case nei villaggi. Sono gli stessi che oggi, in città, non riescono a pagare il mutuo dei miniappartamenti. Chiamano globalizzazione quello che nel secondo Novecento battezzavano progresso. Ma i sardi sanno che il cambiamento si risolve in un affare da agenzia immobiliare: chiudere paesi per aprire periferie».Attorno a Nuoro la Sardegna chiusa per paura, e l’Italia che sceglie di trasformarsi in un’isola governata dalla preoccupazione, si impongono con ferma meraviglia. I quartieri della città sono un mosaico di borghi serrati, come se qualcuno li avesse raccolti al tramonto e innestati qui entro l’alba. Molte vecchie, nere e rotonde come bacche di ginepro, siedono sugli usci di condomini incompiuti, in mattoni rossi, come fossero al focolare. I costumi restano abiti: trasportano nei villaggi vicini, di cui non resta che un’indecifrabile traccia, oppure nei paesi che si consumano in un isolamento accanito. Queste stesse donne, che mantengono i figli con pensioncine antiche, si incontrano anche in altri luoghi. Si muovono come fantasmi, calme e indifferenti, e trasformano la regione in una sconfinata, silenziosa corsia di ospedale. «I loro nipoti – dice lo scrittore Giorgio Todde – sono camerieri, o commessi. Non si fidano del turismo, che vedono rapace, ma non credono più nella civiltà rurale, che sanno spietata. Aspettano, come tutti, di vedere se davvero la bellezza può tramutarsi in oro, senza poi sparire».Orune, Lula, Olzai, Teti, Osidda, Oliena, Desulo, centinaia di altri borghi remoti e sacri, restano intanto cavi come ghiande. Non sono più contadini, non ancora altro. I bar offrono sandwich con speck e fontina, o "vero formaggio svizzero fatto in Olanda".I caci affumicati e ingrassati con l’olio, che per secoli hanno annegato i pastori con un sogno, sono irraggiungibili, come una nuvola oltre il Supramonte. Di bello, di valentemente banditesco, restano i cartelli stradali sfondati a pallettoni. Ricordano un destino: una nazione incerta tra Orgosolo e Porto Cervo, esposta al rischio di essere felice perché non si conosce, eternamente.«Sembriamo in effetti la Sardegna – dice a Ollolai Efisio Arbau, portavoce del movimento dei pastori – ma non siamo più capaci di fare i sardi. È chiaro che non possiamo più consegnare 300 mila quintali di latte a 3 industriali, che confezionano un sottoprodotto per gli hamburger made in Usa. Qualità significa però avere una capacità artigianale, credere nella natura, in una identità. Non i piccoli con un carattere, ma i grandi privi di espressione, iniziano a morire. Unendoci, reinvestendo nella nostra dimensione, possiamo sottrarci ai "prenditori" che svendono il Paese a pochi: per incompetenza, o per corruzione». Come sempre, nella "domo de casu" barbaricina, o nello stabilimento di Andrea Pinna a Thiesi, si discute del prezzo del latte di pecora.A Cagliari Giorgio Piras e Luca Saba, leader sindacali, sfornano studi e appelli alla Regione. A Seneghe Francesco Cubeddu lotta per la quotazione della carne di Bue Rosso. Fulvio Tocco, nel Medio Campidano, tratta il costo del porcetto. Battista Cualbu, a Campu Calvaggiu, poco fuori La Corte, si commuove contando quattrocento pecore in linea e pensando al padre: scendeva a piedi da Fonni, per la transumanza nella Nurra, e per mesi dormiva nei cespugli. Potrebbe sembrare tutto immutabile, o reale come le aste – truffa dei terreni contadini a Villasor: una civiltà che affonda nei debiti, tra l’ex Mussolinia e Reggio Emilia, in balìa dell’assistenza e in ostaggio del mercato. «Invece siamo in crisi – dice a Fordongianus Giuseppe Cugusi detto Cuccara, professione pastore, vocazione casaro – solo perché abbiamo dimenticato chi siamo, rinunciato alla storia. Non crediamo più nelle pecore e raddoppiamo le stalle. Non crediamo più nel latte e quadruplichiamo le mungitrici. Non crediamo più nel Fiore Sardo e ci umiliamo con il pecorino romano. Non crediamo più nella terra e investiamo in sementi e concimi. Non crediamo più nemmeno nel mare, e lo sostituiamo con l´idromassaggio. I sardi non credono più nella Sardegna come gli italiani con credono più nell’Italia: perché rinunciano a se stessi e imitano, come patetici replicanti cinesi. Per andare avanti dobbiamo tornare indietro: animali al pascolo, forme preziose stagionate dietro l’ovile, vendita diretta, on-line come un tempo alle fiere. Gavoi che sfila a cavallo, Rimini che sega gli ombrelloni: il massimo della modernità, contro gli strozzini che producono conti. Ma soprattutto contro una politica vecchia, che non vede la profondità di un cambiamento». Francesco Pigliaru, economista originario di Orune, conferma che non è una resa alla nostalgia.«La qualità dell’ambiente – dice – diventa sviluppo perché chi investe su quel valore acquista ormai solo natura. Per averla, paga di più: ma se non c’è, non spende. Il riflesso, per i prodotti agricoli, è il medesimo. Mondo rurale, civiltà paesana e turismo della bellezza, sono davanti al bivio della tutela integrale: o bruciano l’ultima materia prima rimasta all’Italia, o si impegnano per ricostruire un equilibrio infranto, cuore della competitività economica». Cemento, Turixeddu, pecorino romano, serre e "Unione Sarda", contro sabbia, Busachi, Fiore sardo, grano e "l’Unità". «Due Sardegne – dice l´antropologo Giulio Angioni – ma pure due Paesi opposti, un´idea di Europa: una sfida estrema, in primavera, tra ritorno al feudalesimo e riscoperta della democrazia». È già, rapidamente, buio. Gavino Ledda, ancora pastore, continua ad aspettare una donna. Cammina nell’arboreto che ha piantato con i soldi dei suoi libri. Una collina di cotogni, corbezzoli, mirti, ginepri, olivi, sugheri, lecci, erbe. I compaesani adesso hanno capito. Suo padre aveva ragione: ma lui, alla terra da cui era fuggito, lascia infine un giardino. Una profezia, cesti di frutti, come eredità.
* La Repubblica